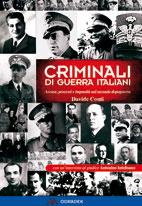La teoria Marxista poggia la sua forza sulla scienza... che ne valida la verità, e la rende disponibile al confronto con qualunque altra teoria che ponga se stessa alla prova del rigoroso riscontro scientifico... il collettivo di formazione Marxista Stefano Garroni propone una serie di incontri teorici partendo da punti di vista alternativi e apparentemente lontani che mostrano, invece, punti fortissimi di convergenza...
sabato 6 dicembre 2025
"Russofobia, russofilia e verità" - conferenza con Angelo D'Orsi, Vincenzo Lorusso e Alessandro Di Battista
venerdì 5 dicembre 2025
Le vere origini della russofobia - Alessandra Ciattini
Da: https://futurasocieta.org - https://www.lantidiplomatico.it - Alessandra Ciattini (Collettivo di formazione marxista Stefano Garroni - Membro del Coordinamento Nazionale del Movimento per la Rinascita Comunista) ha insegnato Antropologia culturale alla Sapienza di Roma. E' docente presso l'Università Popolare Antonio Gramsci (https://www.unigramsci.it).
Vedi anche: Russofobia: origini, miti e propaganda – Alessandra Ciattini
Leggi anche: La fabbrica della “russofobia” in Occidente - Sergio Cararo
Annie Lacroix-Riz: "C'è un contesto storico che spiega perché la Russia è stata messa all'angolo"La russofobia, che i penosi leader europei cercano di alimentare tutti i giorni, prefigurando misteriose minacce di invasioni e conquiste da parte del nostro vicino euroasiatico, costituisce un sentimento, a prima vista, irrazionale e quindi razionalmente incomprensibile. Eppure la conoscenza storica ci consente di individuarne le origini nelle ambizioni politiche dell’imperialismo statunitense, cui si sono inchinati i suddetti leader che, incapaci ed imbelli, anche dopo la pubblicazione del cosiddetto piano di Trump, reclamano una schiacciante sconfitta della Russia.
Nei giorni passati è stato impedito al Prof. Angelo D’Orsi, eminente studioso di A. Gramsci, di tenere una conferenza sulla russofobia nelle sale del Polo del Novecento a Torino con l’accusa del tutto ingiustificata che l’evento sarebbe stato incentrato sulla propaganda putiniana, tema centrale della attuale demagogia politica, ma che non sembra essere condiviso dalla maggior parte della popolazione italiana. Per note vicende storiche e politiche, quest’ultima è legata alla Russia, ex Unione sovietica, di cui ha apprezzato la straordinaria cultura musicale, letteraria, artistica e politica e, in gran parte, il tentativo di costruire il socialismo in un paese arretrato. D’Orsi ha successivamente tenuto la sua conferenza, riuscendo a richiamare un pubblico assai più vasto di quello che sarebbe intervenuto se non fosse stato censurato. Solo questo fatto mette in luce la cretineria politica dei suoi censuratori.
domenica 30 novembre 2025
"Catastrofe neoliberista" - Luciano Canfora, Angelo d'Orsi, Vito Petrocelli e Antonio Di Siena
mercoledì 12 novembre 2025
Censura democratica: Clara Statello intervista Angelo d'Orsi
mercoledì 11 giugno 2025
Il Partito comunista - Antonio Gramsci
Da: https://futurasocieta.org - https://www.marxists.org/italiano/gramsci/20/partitocomunista.htm - [Archivio Gramsci] - Tratto da «L'Ordine Nuovo», 9 ottobre 1920 -
Leggi anche: "I partiti e la massa"* di Antonio Gramsci – a cura di Giorgio Gattei
Antonio Gramsci. Ritratto di un rivoluzionario - Angelo D'Orsi
Su Gramsci e la fondazione del Pci - PIERO GOBETTI
Gramsci. Eretico e comunista - Rossana Rossanda
mercoledì 28 maggio 2025
Catastrofe Neoliberista. Una terapia contro la narrazione tossica - Massimo Zucchetti
Da: https://contropiano.org - Massimo Zucchetti è professore ordinario dal 2000 presso il Politecnico di Torino, Dipartimento di Energia. Attualmente è docente di Radiation Protection, Tecnologie Nucleari, Storia dell’energia, Centrali nucleari. - Massimo Zucchetti
Angelo d'Orsi, Professore ordinario di Storia del pensiero politico all’Università di Torino.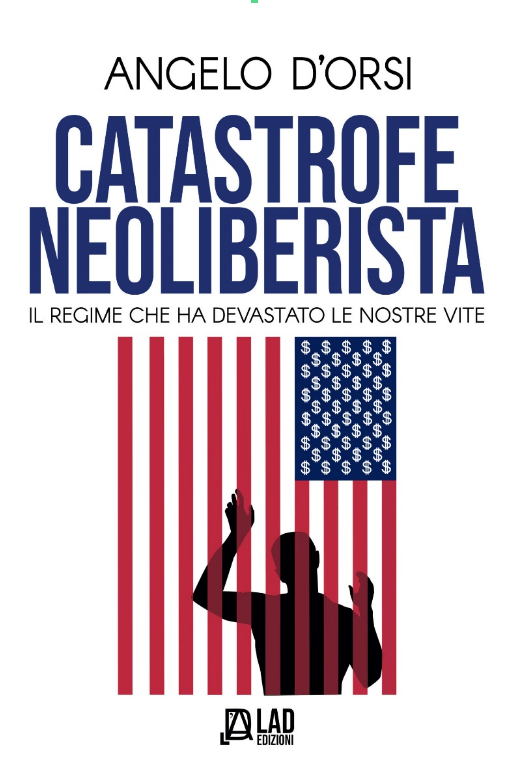
Angelo d’Orsi, storico di fama internazionale e forse il maggiore conoscitore vivente su Antonio Gramsci, è l’autore di “Catastrofe Neoliberista“, appena pubblicato per LAD Edizioni, 2025.
Dagli anni ’70 a oggi, il neoliberismo si è imposto come un sistema economico, sociale e culturale globale, espandendosi in modo inarrestabile. Attraverso l’uso strategico di guerre, rivoluzioni colorate, media e meccanismi di controllo, ha piegato stati sovrani e devastato economie locali, eliminandone la resistenza.
“Catastrofe neoliberista” di Angelo D’Orsi è innanzitutto un vademecum della storia recente: ripercorre le origini e le dinamiche di quella che de facto è una dittatura totalitaria mondiale, capace di imporsi con violenza e di camuffarsi abilmente da paladina della libertà e della democrazia. Come un vademecum, deve essere snello e utile: solo attraverso la comprensione profonda dell’avversario è possibile immaginare alternative. L’opera ci offre gli strumenti per decifrare il presente e provare a costruire un futuro diverso.
L’analisi riguarda essenzialmente il periodo successivo al 1989-91, con il letterale naufragio della nuova “Grande Illusione”, simboleggiata dalle previsioni di Francis Fukuyama (un mondo senza più guerre, di pace e progresso): la realtà si è invece dipanata in questi tre decenni e mezzo con il neoliberismo, che ha portato a una “guerra infinita” e all’aumento delle disuguaglianze, delle povertà e delle vittime del tritacarne imperialista.
Gli anni ’70 come cerniera tra welfare e neoliberismo.
D’Orsi descrive gli anni ’70 come la fine dei “Trenta (anni) Gloriosi” e l’apice dello stato sociale. Menziona le conquiste sociali degli anni ’60 e ’70 in Italia, come il divorzio, l’aborto, il servizio sanitario nazionale e lo statuto dei lavoratori.
Il prosieguo vede le deviazioni della “lotta di classe (dal basso)” verso la lotta armata, come reazione sbagliata ai tradimenti di molte delle speranze del dopoguerra.
Ma nel frattempo partiva anche la reazione del capitale: citando Domenico Losurdo, avveniva in contemporanea la “lotta di classe dall’alto“. D’Orsi paragona la controffensiva capitalistica a una mazza nelle mani delle classi dominanti, come il fascismo nel primo dopoguerra, citando Giovanni Arrighi. Il neoliberismo si può definire ultracapitalismo, turbocapitalismo e ipercapitalismo, citando Luciano Gallino e Rudolf Hilferding.
giovedì 15 maggio 2025
“Né fascismo né liberalismo: soviettismo!” - Antonio Gramsci
Da: https://giuliochinappi.wordpress.com - https://www.nuovopci.it/classic/gramsci/gramsci.htm
Leggi anche: Il nostro Marx*- Antonio Gramsci
Cadaveri e idioti - Antonio Gramsci
Su Gramsci e la fondazione del Pci - PIERO GOBETTI
Gramsci. Eretico e comunista - Rossana Rossanda
Internazionalismo e questione nazionale nel pensiero di Gramsci - Salvatore Tinè
"I partiti e la massa"* di Antonio Gramsci – a cura di Giorgio Gattei
Vedi anche: Antonio Gramsci. Ritratto di un rivoluzionario - Angelo D'Orsi
Due o tre cose che so di Gramsci. Antonio Gramsci ai Giovani. - Angelo d'Orsi
L’Unità, 7 ottobre 1924
Nella crisi politica di liquidazione del fascismo il blocco delle opposizioni appare sempre più come un fattore di secondario ordine. La sua composizione sociale eterogenea, le sue esitazioni e la sua avversione ad una lotta della massa popolare contro il regime fascista, riducono la sua azione ad una campagna giornalistica e a degli intrighi parlamentari che si urtano impotenti di fronte alla milizia armata del Partito fascista.
Nel movimento di opposizione al fascismo la parte più importante è passata al Partito liberale perché il blocco non ha altro programma da opporre al fascismo che il vecchio programma liberale della democrazia borghese parlamentare, il ritorno alla costituzione, alla legalità, alla democrazia. Nella discussione sulla successione al fascismo a proposito del congresso del Partito liberale, il popolo italiano è posto, dalle opposizioni, di fronte alla scelta: o fascismo o liberalismo; o un governo Mussolini di dittatura sanguinaria o un governo Salandra, Giolitti, Amendola, Turati, don Sturzo, Vella, tendente a ristabilire la buona vecchia democrazia liberale italiana sotto la cui maschera la borghesia continuerà ad esercitare il suo dominio di sfruttamento.
martedì 29 aprile 2025
Con “l’Occidente contro il resto del mondo” si rischia la catastrofe - Angelo d’Orsi
Da: https://www.africa-express.info - Angelo d'Orsi* Professore ordinario di Storia del pensiero politico all’Università di Torino.
Vedi anche: L'OCCIDENTE NICHILISTA vuole UCCIDERE la RUSSIA - Angelo D'Orsi
Luciano Canfora: "L'asse franco-inglese vuole fare guerra alla Russia, il rischio è altissimo"
La russofobia sta portando l'Europa al disastro. L'asse franco-anglo-tedesco, preannuncia un destino di morte per il continente. Si assiste a un’accelerazione del passaggio dal welfare al warfare. (Redazione Africa ExPres)
Sono almeno dieci-quindici anni che la russofobia – che è paura del mondo russo, ma anche la sua espunzione dalla “civiltà” – ci sta ammorbando, sta ottenebrando le nostre menti, sta condizionando i nostri pensieri, indirizzandoci anno dopo anno, giorno dopo giorno, verso la possibilità di un conflitto armato contro Mosca.
Dal 2022 quella possibilità è diventata, nelle parole irresponsabili di gran parte della classe politica euro-occidentale, una necessità alla quale, presto o tardi, dovremmo sottostare.
E in un crescendo spaventoso, dopo l’arrivo di Donald Trump alla White House, con le sue promesse di porre termine al conflitto in Ucraina (NATO vs. Federazione russa combattuto sul suolo ucraino ma anche sempre di più in territorio russo), ormai la guerra, una guerra totale tra Europa/Occidente e Russia/Oriente ci viene presentata non soltanto come necessità, ma come necessità inderogabile e urgente.
Tre Stati in difficoltà
sabato 22 marzo 2025
Confine orientale e identità: foibe e narrazione - Raoul Pupo
Vedi anche: La narrazione intorno alle foibe. Un'ambigua verità di stato - Angelo d'Orsi
domenica 9 marzo 2025
Il vero significato dell'appello di Michele Serra. Intervista al prof. Angelo D'Orsi
martedì 11 febbraio 2025
L'OCCIDENTE NICHILISTA vuole UCCIDERE la RUSSIA - Angelo D'Orsi
lunedì 10 febbraio 2025
Sulle foibe - Rossana Rossanda
Da: Massimo Zucchetti - Rossana Rossanda (Pola, 23 aprile 1924 – Roma, 20 settembre 2020) è stata una giornalista, scrittrice e traduttrice italiana, dirigente del PCI negli anni cinquanta e sessanta e cofondatrice de il manifesto.
Vedi anche: La narrazione intorno alle foibe. Un'ambigua verità di stato - Angelo d'Orsi
Leggi anche: “E allora, le foibe?!”
L’occupazione italiana nei Balcani - Angelo Del Boca
https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2019/02/14/von-banditen-erschossen-su-mattarella-e-le-foibe
Da quando è presidente della Camera, Luciano Violante si è investito della missione di riscrivere la storia, che secondo lui non è mai stata giusta. Rifacendola, si potrebbe “riconciliare la nazione” che, come si sa, nel 1943 si divise.
Prima ci ha spiegato che occorre (o sarebbe addirittura occorso l’8 settembre?) capire i giovani che sceglievano Mussolini e Salò. Adesso rimprovera il suo ex partito - o ex suo partito o comunque si voglia chiamare il PCI - di aver nascosto che dal 1943 al 1945 i partigiani jugoslavi giustiziarono sommariamente e cacciarono nelle foibe non solo gli ustascia ma alcune migliaia di istriani che sospettavano d’accordo con loro, sicuramente molti innocenti. Il PCI ha occultato tutto, dice Violante riprendendo il segretario pidiessino di Trieste, per complicità totalitaria con Tito.
Si dà il caso che io sia stata una del PCI, e istriana da diverse generazioni. Conosco quella storia. Ma la conoscono tutti fuorché, forse, la distratta generazione di Violante: dal 1948 in poi le foibe ci vennero rinfacciate a ogni momento, e non solo dai fascisti che rivolevano Trieste (i loro eredi ancora mettono in causa il trattato di Osimo). Se la federazione triestina del PCI, a lungo diretta da Vittorio Vidali, fu dilaniata nel giudizio politico, storicamente non c’era nulla da scoprire.
Non è questione di archivi da portare alla luce, ci sono storie e documenti. Se Violante avesse velocemente consultato la abbastanza buona biblioteca della Camera, si sarebbe risparmiato delle enormità. La prima delle quali è tacere l’essenziale d’una vicenda che si pretende di ricostruire.
Non ci sono due possibili interpretazioni delle responsabilità italiane in Jugoslavia: ce n’è una. Ed è che l’Italia seguì Hitler nell’invasione della Jugoslavia del 1941, pretese un dominio particolare sulla Croazia, appoggiando Ante Pavelic e sovrapponendogli a mo’ di sovrano Aimone di Savoia Aosta, duca di Spoleto. Per due anni i corpi d’armata italiani, soprattutto la Pusteria, e i generali Cavallero, Ambrosio e Roatta attuarono operazioni orrende contro la guerriglia partigiana, la più lunga e coraggiosa d’Europa, gli ebrei, i musulmani, i serbi ed altre minoranze; le fonti di Renzo De Felice calcolano in oltre duecentomila gli uccisi.
Mentre una nobile gara si instaurava, teste indiscusso Luigi Pietromarchi, fra Roma e Berlino su come spartirsi le spoglie dei Balcani. In capo a due anni, con l’8 settembre, l’esercito italiano si disgrega e per l’onore del nostro disgraziato paese diversi soldati e ufficiali raggiungono le formazioni partigiane jugoslave. Ma non perciò esse hanno vinto: i tedeschi non mollano il fronte jugoslavo, se perdono dei territori tentano di riprenderli o li riprendono con ripetute offensive, che tengono impegnata la Wehrmacht come in nessun altro fronte occidentale. La Jugoslavia si può considerare liberata e la guerra quasi conclusa nel tardo 1944 con la presa di Belgrado.
L’unificazione dei comitati partigiani è avvenuta un anno prima. E Tito sarà riconosciuto come interlocutore soltanto alle soglie del 1945, gli inglesi avendogli preferito il governo all’estero di Mihailovic (alleati cetnici inclusi finché non cambiarono bandiera). Quattro anni di guerra di guerriglia, che il variare del fronte e degli esiti rende subito guerra, quattro anni di scontro con un esercito potente e crudele, di massacri, rappresaglie e saccheggi, sono un tempo infinito. L’odio seminato, e meritato, da italiani e collaborazionisti fu grande, e non dimenticato. E le vendette certamente atroci, e non dimenticate.
Ma le responsabilità non sono le stesse.
Non tiriamo in ballo i morti, che sono davvero fuori dalla storia, per far intendere che le colpe sono uguali, e che lo scontro è stato tra due totalitarismi che si equivalevano.
Questa è mistificazione, prima ancora che revisionismo. L’ignoranza e la confusione sono già abbastanza grandi perché un presidente della Camera ex comunista venga ad aumentarle.
domenica 8 dicembre 2024
LETTERA APERTA A EDITH BRUCK E LILIANA SEGRE - Angelo D'Orsi
Da: facebook.com/angelo.dorsi - Angelo d'Orsi è professore ordinario di Storia del pensiero politico all’Università di Torino.
Leggi anche: 7 ottobre, come è andata veramente - Rock Reynolds
mercoledì 22 giugno 2022
PARIGI 1871: L'ESPERIMENTO COMUNISTA - LUCIANO CANFORA
La Comune di Parigi e gli intellettuali contemporanei - Alessandra Ciattini
150° anniversario della Comune di Parigi, una memoria capitale – Joseph Confavreux
giovedì 10 febbraio 2022
Italia: una “memoria condivisa” fatta di vittimismo e negazione del conflitto Una conversazione con Davide Conti
Da: https://www.facebook.com/Odradek.edizioni - https://www.odradek.it - https://www.pane-rose.it -
Davide Conti/, storico, è consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica, della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage del 2 agosto 1980) e della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage del 28 maggio 1974). È inoltre autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica.
Leggi anche: L’occupazione italiana nei Balcani - Angelo Del Boca
Vedi anche: La narrazione intorno alle foibe. Un'ambigua verità di stato - Angelo d'Orsi
Spesso, in questi anni, come forze dell’antagonismo sociale e della sinistra di classe abbiamo realizzato iniziative volte a contrastare la rilettura ufficiale della storia italiana. Uno sforzo meritorio, che ha prodotto momenti di discussione utili, anche sul piano della formazione di chi vi ha partecipato. Mai come oggi è necessario rafforzare questo impegno, fondandolo su una piena comprensione delle ragioni che hanno spinto a definire i nuovi criteri di interpretazione della vicenda italiana. In questa intervista, Davide Conti – autore di L’occupazione italiana dei Balcani (2008) e Criminali di guerra italiani (2011) – si sofferma sulle caratteristiche di quella “memoria condivisa” che si è andata delineando a partire dalla fine della Prima Repubblica. E che negli ultimi anni è stata sancita attraverso una precisa, ragionata calendarizzazione, tesa a sottacere le verità più scomode e capace di rifunzionalizzare alle nuove esigenze antichi miti, come quello degli “italiani brava gente”. Per il suo carattere complessivo, il discorso di Conti deve essere preso in considerazione da chiunque voglia contrastare la narrazione storica oggi dominante. Anche per superare quella frammentarietà – legata alla necessità di intervenire volta per volta su singoli aspetti del dibattito pubblico sulla memoria – che ha inevitabilmente segnato la nostra azione su questo terreno.
Naturalmente le ragioni che hanno permesso una sostanziale impunità per i presunti criminali di guerra italiani (adotto questa formula proprio perché non sono stati fatti i processi), non vanno rintracciate nella dimensione giuridica.
Semmai le motivazioni sono state in primo luogo di carattere geopolitico ed in second'ordine legate a questioni interne. Dal punto di vista geopolitico - cioè dell'asse portante del paradigma dell'impunità dei criminali di guerra italiani - sicuramente la collocazione del nostro paese nell'ambito del dispositivo internazionale della NATO ha prodotto, per gli alleati, la necessità di evitare processi contro i vertici ed i quadri medio-alti e medi del Regio Esercito. Si voleva impedire quella decapitazione di fatto del nostro corpo militare, che sarebbe stata la naturale conseguenza di una seria procedura di epurazione in seno all'esercito. L'idea era invece quella di riarmarlo e di reintegrarlo in un nuovo dispositivo bellico, perciò gli alleati rinunziarono a processare quei criminali di guerra che loro stessi avevano indicato in liste apposite, consegnate alle Nazioni Unite. Parliamo della Francia, degli USA e dell'Inghilterra. Per quanto riguarda gli altri paesi, fummo aiutati dalle stesse ragioni geopolitiche: la contrapposizione col blocco orientale consentì all'Italia, appoggiata dagli alleati, di non consegnare gli accusati di pratiche e condotte militari illecite soprattutto in Unione Sovietica ed in paesi balcanici come Jugoslavia ed Albania. Un discorso a parte andrebbe fatto per la Grecia, che fa parte dell'area dei Balcani ma trovandosi nello stesso schieramento geopolitico dell'Italia, quello occidentale, rinunciò con un accordo segreto siglato nel 1948 a vedersi consegnati i presunti criminali di guerra. Di più, essa sbloccò di fatto delle procedure che permisero il progressivo rientro anche di quei militari italiani che, essendo stati già processati e condannati, stavano scontando la pena nelle carceri greche.
Questo è il quadro generale. Il risultato, sul piano interno, fu la possibilità sostanziale per i governi a maggioranza conservatrice di mantenere quella continuità dello Stato che è stato il tratto caratteristico del dopoguerra italiano.
martedì 30 novembre 2021
“Storia e Politica”: un dialogo tra Angelo d'Orsi e Alessandro Barbero
mercoledì 8 settembre 2021
La guerra civile francese - Alessandro Barbero
sabato 26 giugno 2021
La narrazione intorno alle foibe. Un'ambigua verità di stato - Angelo d'Orsi
Leggi anche: “E allora, le foibe?!”