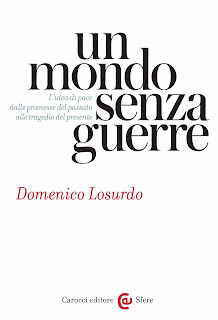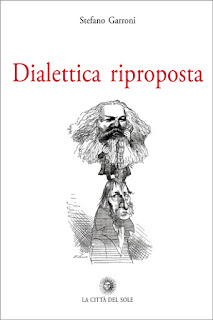Testo tratto da: Friedrich Engels - Karl Marx Critica della
critica critica Contro Bruno Bauer e soci. Editori Riuniti, Roma 1967. Titolo
originale: "Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen
Bruno Bauer und Consorten". Traduzione e cura di Aldo Zanardo.
"Il mistero svelato del «punto di vista»"
«Rodolfo non rimane fermo al suo elevato» (!) «punto di
vista... egli non teme la fatica di occupare con libera scelta i punti di vista
che stanno a destra e a sinistra, in alto e in basso». Szeliga.
Uno dei misteri principali della critica critica è il «punto
di vista» e la valutazione del punto di vista del punto di vista. Per lei, ogni
uomo, così come ogni prodotto spirituale, si trasforma in un punto di vista.
Niente è più facile che scoprire il mistero del punto di vista, se si è
penetrato il mistero generale della critica critica, consistente nel riscaldare
nuovamente il vecchio cavolo speculativo.
Sia anzitutto la critica stessa a esprimersi per bocca del
patriarca, del signor Bruno Bauer, sulla sua teoria del «punto di vista». «La
scienza... non ha mai a che fare con questo individuo singolo o con questo
punto di vista determinato... Indubbiamente, essa non mancherà di fare ciò, e
supererà il limite di un punto di vista, se ne vale la pena e se questo limite
ha realmente un significato umano universale; ma essa considera questo limite
come pura categoria e determinatezza dell'autocoscienza e parla quindi solo per
coloro che hanno l'ardire di elevarsi all'universalità dell'autocoscienza, cioè
per coloro che con tutte le loro forze non vogliono rimanere in quel limite»
(«Anekdota», vol. 2, p. 127)
Il mistero di questo ardire baueriano è la
"Fenomenologia" di Hegel. Poiché, qui, Hegel pone al posto dell'uomo
l'autocoscienza, la realtà umana più diversa appare solo come una forma
determinata come una determinatezza dell'autocoscienza. Una semplice
determinatezza dell'autocoscienza è, però, una «pura categoria», un semplice
«pensiero», che io quindi posso sopprimere anche nel «puro» pensare e posso
superare mediante il pure pensare.
Nella "Fenomenologia" di Hegel i fondamenti
materiali, sensibili, oggettivi, delle diverse figure alienate
dell'autocoscienza umana sono lasciati sussistere e tutta quanta l'opera
distruttiva ha avuto come risultato la filosofia più conservatrice, dato che si
crede di avere superato il mondo oggettivo, il mondo sensibilmente reale,
appena lo si è trasformato in una «cosa del pensiero», in una semplice
determinatezza dell'autocoscienza e appena si può quindi dissolvere
l'avversario, diventato etereo, nell'«etere del pensiero puro».
La "Fenomenologia", quindi, si conclude
conseguentemente con il porre, al posto di tutta la realtà umana, il «sapere
assoluto»: il sapere, perché questo è l'unico modo di esistere
dell'autocoscienza e perché l'autocoscienza rappresenta l'unico modo di esistere
dell'uomo; sapere assoluto, appunto perché l'autocoscienza sa soltanto se
stessa e non è più disturbata da un mondo oggettivo. Hegel fa dell'uomo l'uomo
dell'autocoscienza, anziché fare dell'autocoscienza l'autocoscienza dell'uomo,
dell'uomo reale, vivente quindi in un inondo reale, oggettivo, dell'uomo
condizionato da questo mondo.
Hegel pone il mondo sulla testa e quindi può anche risolvere
nella testa tutti i limiti, con il che naturalmente essi continuano a
sussistere per la cattiva sensibilità, per l'uomo reale. Inoltre, egli
considera necessariamente come limite tutto ciò che rivela la limitatezza
dell'autocoscienza universale, tutta la sensibilità, tutta la realtà, tutta
l'individualità, degli uomini e del loro mondo. Tutta la "Fenomenologia"
vuole dimostrare che l'autocoscienza è la sola realtà e tutta la realtà.
Negli ultimi tempi il signor Bauer ha ribattezzato il sapere
assoluto chiamandolo critica, e la determinatezza dell'autocoscienza
chiamandola "punto di vista", che è parola dal suono più profano.
Negli «Anekdota», i due nomi rimangono ancora insieme, e il punto di vista è
ancora spiegato mediante la determinatezza dell'autocoscienza. Poiché il «mondo
religioso in quanto mondo religioso» esiste solo come il mondo
dell'autocoscienza, il critico critico - teologo ex professo - non può affatto
arrivare al pensiero che ci sia un mondo in cui coscienza ed essere sono
distinti, un mondo che continua a sussistere, se io sopprimo semplicemente la
sua esistenza pensata, la sua esistenza come categoria, come punto di vista,
cioè se io modifico la mia propria coscienza soggettiva senza mutare la mia
propria realtà oggettiva, la mia propria e quella degli altri uomini.
L'identità mistica, speculativa, di essere e pensiero, si ripete, perciò, nella
critica, come l'identità egualmente mistica di prassi e teoria. Di qui la
rabbia della critica contro la prassi, che vuole essere anche qualcosa di
diverso dalla teoria e contro la teoria che vuole anche essere qualcosa di
diverso dalla dissoluzione di una categoria determinata nell'«universalità
illimitata dell'autocoscienza».
La teoria della
critica si limita a dichiarare che tutto ciò che è determinato è un'opposizione
rispetto all'universalità illimitata dell'autocoscienza, e che quindi è un
nulla; così per esempio lo Stato, la proprietà privata, eccetera. E' necessario
all'opposto dimostrare che Stato, proprietà privata, eccetera, trasformano gli
uomini in astrazioni, o che sono prodotti dell'uomo astratto, anziché essere la
realtà degli uomini individuali, concreti. E' chiaro di per sé infine che, se
la "Fenomenologia" di Hegel, nonostante il suo peccato originale
speculativo, dà in molti punti gli elementi per una reale caratterizzazione dei
rapporti umani, il signor Bruno e soci forniscono invece solo la caricatura
priva di contenuto, una caricatura che si accontenta di estrarre da un prodotto
spirituale, o anche da rapporti e movimenti reali, una qualsiasi
determinatezza, di trasformare questa determinatezza in una determinatezza del
pensiero, in una categoria, e di far passare questa categoria come il punto di
vista del prodotto, del rapporto e del movimento, per potere quindi, con
sapienza presuntuosa, dal punto di vista dell'astrazione, della categoria
universale, dell'autocoscienza universale, guardare giù trionfalmente verso
questa determinatezza.
Come per Rodolfo tutti gli uomini si collocano nel punto di
vista del bene o in quello del male e sono giudicati secondo queste due
rappresentazioni fisse, così, per il signor Bauer e soci, tutti gli uomini si collocano
nel punto di vista della critica o in quello della massa. L'uno e gli altri
trasformano però gli uomini reali in punti di vista astratti.
 Nello squallido e
mistificante panorama dei mass media internazionali risalta il lavoro
informativo di Telesur, la catena televisiva voluta dal presidente Hugo Chávez,
e che impiega schemi interpretativi utili a stimolare la riflessione critica
degli spettatori. Una metodologia che si contrappone all'approccio puramente
emotivo e individualista tipico dei media nostrani.
Nello squallido e
mistificante panorama dei mass media internazionali risalta il lavoro
informativo di Telesur, la catena televisiva voluta dal presidente Hugo Chávez,
e che impiega schemi interpretativi utili a stimolare la riflessione critica
degli spettatori. Una metodologia che si contrappone all'approccio puramente
emotivo e individualista tipico dei media nostrani.