La teoria Marxista poggia la sua forza sulla scienza... che ne valida la verità, e la rende disponibile al confronto con qualunque altra teoria che ponga se stessa alla prova del rigoroso riscontro scientifico... il collettivo di formazione Marxista Stefano Garroni propone una serie di incontri teorici partendo da punti di vista alternativi e apparentemente lontani che mostrano, invece, punti fortissimi di convergenza...
lunedì 8 dicembre 2025
Com'era vivere nella Germania dell'Est? - Francesco dall'Aglio
domenica 7 dicembre 2025
ARLACCHI SPIEGA LA CINA ALL'OCCIDENTE MA L'OCCIDENTE E' DISPOSTO AD ASCOLTARE? - Carlo Formenti
Vedi anche: “I tre segreti della civiltà cinese: meritocrazia, pace e socialismo” - Pino Arlacchi -
Leggi anche: Cina, Brics e Occidente: come sta cambiando il mondo - Pino Arlacchi
Il falso mito della Cina capitalista e gli occhi strabici dell’Occidente - Pino Arlacchi
IA: le differenze tra la Cina socialista e l'occidente - Pino Arlacchi
L’economia reale è sulla Via della seta - Pino Arlacchi
giovedì 13 novembre 2025
Cina, Brics e Occidente: come sta cambiando il mondo - Pino Arlacchi
domenica 2 novembre 2025
“I tre segreti della civiltà cinese: meritocrazia, pace e socialismo” - Pino Arlacchi
domenica 10 agosto 2025
Die Wende - Nicolò Monti
Da: Nicolò Monti (https://www.facebook.com/nico12.666) - Nicolò Monti già segretario nazionale della Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI).
Leggi anche: La rivincita del capitale: 40 anni di RDT, 25 anni dopo - Vladimiro Giacché
domenica 12 gennaio 2025
Marxismo in Cina e la via cinese al socialismo
martedì 5 novembre 2024
La categoria di imperialismo è ancora attuale e quali sono i paesi imperialisti? - Domenico Moro
IL COLONIALISMO di ieri e di oggi. USA, RUSSIA, e CINA: quali sono realmente i PAESI IMPERIALISTI? - Alessandra Ciattini
Leggi anche: L'imperialismo. Fase suprema del capitalismo*- Vladimir Lenin (1916)
Il capitale finanziario (estratti dal capitolo XXII, 1910) - Rudolf Hilferding
Esiste oggi un imperialismo europeo? - Domenico Losurdo
Sviluppo capitalistico e Guerra. Un testo illuminante di Gianfranco Pala
Il mito dell’imperialismo russo: in difesa dell’analisi di Lenin - Renfrey Clarke, Roger AnnisIMPERIALISMO E SOCIALISMO IN ITALIA - Vladimir Lenin (1915)
L’imperialismo nel XXI secolo - John Smith
Dalla fine dell’Ottocento, l’imperialismo moderno si sviluppa come sistema di dominio economico e politico delle potenze capitaliste occidentali. Oggi, nonostante la decolonizzazione, persistono dinamiche imperialiste che si manifestano tramite il controllo finanziario e geopolitico esercitato da Stati e multinazionali.
Il termine di imperialismo è associato ai più importanti imperi del passato come quello romano o quello persiano. Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento il termine di imperialismo è stato ripreso per descrivere la nuova realtà mondiale, caratterizzata dalla formazione di diversi imperi facenti riferimento soprattutto agli stati dell’Europa occidentale. Per questo il periodo tra la seconda metà dell’Ottocento e il 1945, quando inizia la decolonizzazione, è stato definito l’età degli imperi. L’impero più vasto era quello britannico, seguito da quello francese, spagnolo, portoghese e olandese, che erano gli imperi più antichi. Tra gli ultimi Paesi a partecipare alla corsa alle colonie ci furono gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania, il Belgio e l’Italia.
L’imperialismo moderno si differenzia da quello antico perché non rappresenta soltanto un espansionismo militare bensì un espansionismo in primo luogo economico, basato sulla conquista di territori da sfruttare e utilizzare economicamente, le colonie. L’imperialismo è una fase dello sviluppo del capitalismo, caratterizzando in modo peculiare l’economia dei Paesi imperialisti. Dal punto di vista globale l’imperialismo è un sistema basato sulla divisione tra un centro metropolitano, i Paesi imperialisti, e una periferia e una semiperiferia, entrambe sfruttate e oppresse dal centro.
Dal momento che dopo il 1945 è iniziato il processo di decolonizzazione e le ex colonie sono divenute stati indipendenti, si può parlare dell’esistenza di un imperialismo ancora oggi? Riteniamo di sì, ma con delle differenze. Quella di imperialismo rimane, quindi, una delle più importanti categorie di interpretazione della realtà. Per analizzare l’imperialismo attuale e definire le novità rispetto a quello della prima metà del Novecento dobbiamo partire da un testo che fu fondamentale nell’interpretazione dell’età degli imperi, “L’imperialismo. Fase suprema del capitalismo” di Lenin.
domenica 3 novembre 2024
Il «nuovo» Capitale: una teoria in costruzione - Sebastiano Taccola
Da: https://jacobinitalia.it - Sebastiano Taccola ha studiato filosofia presso l’Università di Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa ed è docente di filosofia e storia nei Licei.
L’onda lunga della crisi del marxismo (tra prassi e teoria) - Roberto Fineschi
Vedi anche: Incontro con Roberto Fineschi - Unigramsci Pisa
Marx e la società postcapitalista - Vladimiro Giacché
Il primo libro de Il capitale di Karl Marx: edizione critica e nuova tradizione con Roberto Fineschi: https://www.youtube.com/watch?v=aGGdbGQkDqo&t=2sLa nuova edizione dell’opera di Marx, curata da Roberto Fineschi, rafforza il carattere rivoluzionario di uno studio che illustra la processualità capitalistica e il metodo per studiarla e contrastarla
Nel momento in cui sono proliferate le recensioni della nuova edizione einaudiana del primo libro del Capitale su testate giornalistiche inaspettate (La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Riformista, Il Sole 24 ore, L’Avvenire, tra le altre) in chi scrive si è profilata l’ipotesi che il metodo socratico e la sua capacità di cogliere nel linguaggio dell’agorà delle spie del sapere e dell’ideologia della polis potesse servire, si parva licet, da canone interpretativo interessante e produttivo anche in questo caso.
Secondo la splendida ricostruzione corale e teatrale che ne ha dato Platone, il metodo socratico ha una serie di effetti teoricamente significativi: 1) la ricerca sull’essenza degli oggetti del sapere si sviluppa in maniera dialettica e critica; 2) critica non perché basata su una dismissione strumentale ed esteriore delle posizioni altrui, ma su una critica immanente che mette in luce gli aspetti unilaterali e arbitrari di queste; 3) il che significa che la verità non è qualcosa di puntuale né, tanto meno, di personale, ma è il risultato di uno sforzo collettivo e dialogico, che prova a superare l’arbitrio dei molti punti di vista individuali; 4) non esistono, dunque, risposte errate, ma ogni risposta è un momento del tutto e, nello stesso tempo, una spia del sapere della polis (genitivo oggettivo e soggettivo), della quale rappresenta anche un risultato ideologicamente rilevante.
Invece di scartare immediatamente l’interesse dei giornali della stampa liberale e borghese come il segnale di una cultura post-ideologica o come l’inevitabile marchetta da pagare a un editore prestigioso come Einaudi, si può provare a cogliere in questo fenomeno qualcosa di più profondo: un sintomo o effetto di struttura dei rapporti ideologici dell’agorà del nostro tempo.
giovedì 17 ottobre 2024
Marx e la società postcapitalista - Vladimiro Giacché
sabato 21 settembre 2024
Come e quando ha inizio una guerra - LUCIANO CANFORA
martedì 13 agosto 2024
"Filosofia dell'Ottocento. Dall'idealismo al positivismo" - Vladimiro Giacché
martedì 28 maggio 2024
Contro la sinistra neoliberale: il caso Sarah Wagenknecht - Vladimiro Giacché
lunedì 22 aprile 2024
La Rivoluzione d'ottobre e il pensiero di Hegel - Emiliano Alessandroni
martedì 9 aprile 2024
Lenin, a cento anni dalla morte -
domenica 17 marzo 2024
Hegel, la dialettica e il marxismo - Renato Caputo intervista Vladimiro Giacché
martedì 6 febbraio 2024
La dialettica di Hegel NON È tesi-antitesi-sintesi - Lucio Cortella
martedì 30 gennaio 2024
Hegel: un ”cane morto” molto vivace. Intervista a Vladimiro Giacché - Luca Cangianti
Da: https://www.carmillaonline.com - Luca Cangianti si è laureato prima in Filosofia e poi in Sociologia. È autore del romanzo storico-fantastico Sangue e plusvalore e coautore della raccolta di saggi Immaginari alterati. Scrive sulla webzine letteraria “Carmilla”.
Vladimiro Giacché, presidente del Centro Europa Ricerche (CER), è un filosofo ed economista italiano. Ha studiato a Pisa (Italia) e Bochum (Repubblica Federale di Germania) come allievo della Scuola Normale Superiore (laurea, diploma e dottorato cum laude).
Vedi anche: Pensare con Hegel - Vladimiro Giacché
È la contraddizione che muove il mondo - Vladimiro Giacché
Leggi anche: “La contraddizione è ciò che muove il mondo” - Leo Essen intervista Vladimiro Giacché
Quando le latrine saranno d’oro*- Luca Cangianti
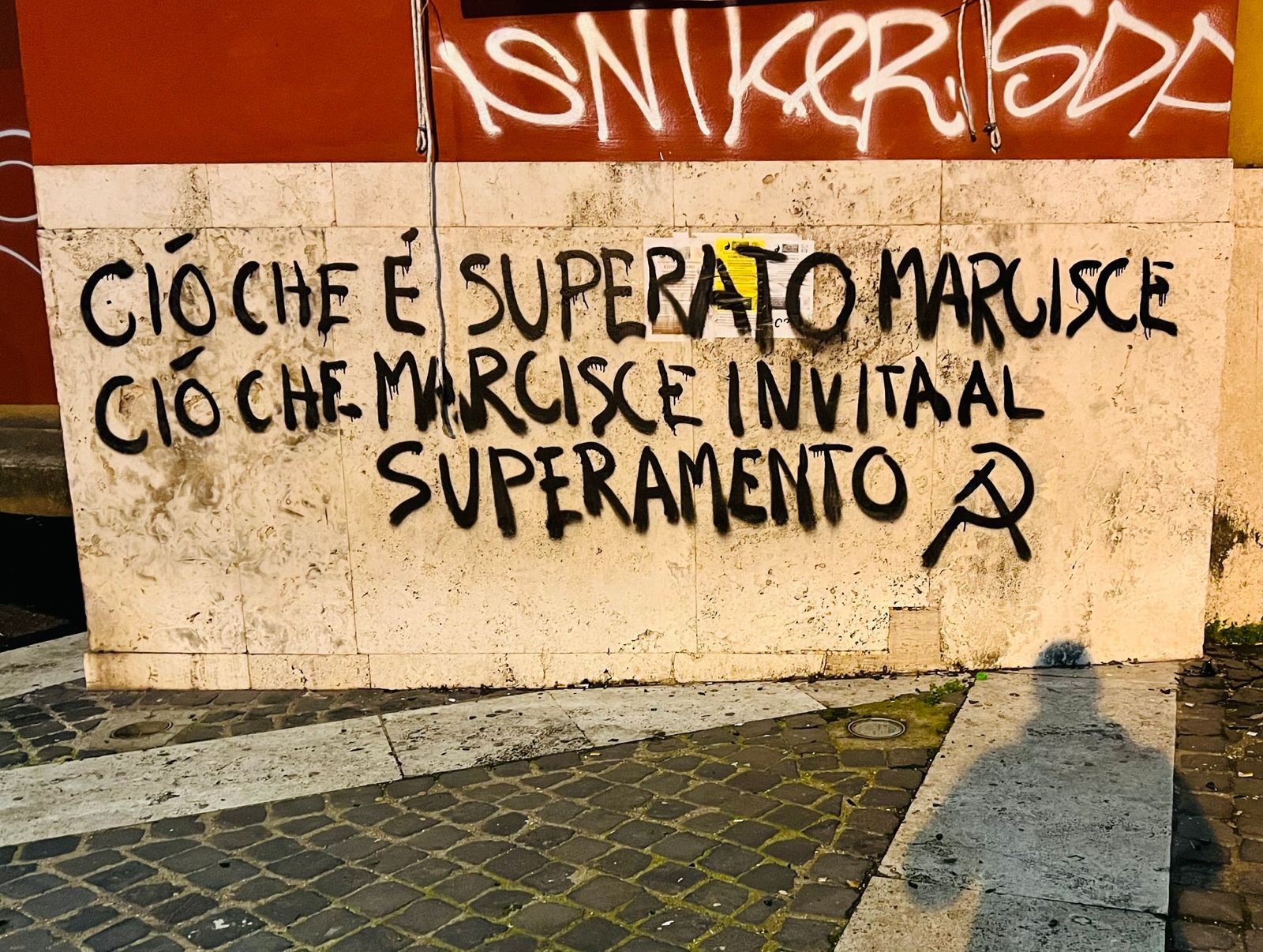 Nel “Poscritto alla seconda edizione” del Capitale Marx stigmatizzava la generale disposizione a trattare Hegel da «cane morto», si professava suo discepolo ed evidenziava l’imprescindibile necessità della dialettica per afferrare il funzionamento del modo di produzione capitalistico. Tuttavia, se in Marx vediamo la dialettica al lavoro, rimane pur sempre aperta la questione di che cosa sia nello specifico. Certo, ci si può rivolgere direttamente a Hegel per togliersi la curiosità, ma il pensiero di questo filosofo è notoriamente esposto con un linguaggio spesso oscuro. Per accostarci a questo pensatore, quindi, un’opera come Hegel. La dialettica di Vladimiro Giacché (Diarkos, 2023, pp. 240, € 18,00) risulta di grande utilità. Nella nuova edizione (la prima era uscita nel 2020 in piena pandemia), l’autore ha ulteriormente semplificato il linguaggio (in verità già ampiamente chiaro), arricchito la parte antologica e aggiornato i riferimenti alle nuove edizioni critiche.
Nel “Poscritto alla seconda edizione” del Capitale Marx stigmatizzava la generale disposizione a trattare Hegel da «cane morto», si professava suo discepolo ed evidenziava l’imprescindibile necessità della dialettica per afferrare il funzionamento del modo di produzione capitalistico. Tuttavia, se in Marx vediamo la dialettica al lavoro, rimane pur sempre aperta la questione di che cosa sia nello specifico. Certo, ci si può rivolgere direttamente a Hegel per togliersi la curiosità, ma il pensiero di questo filosofo è notoriamente esposto con un linguaggio spesso oscuro. Per accostarci a questo pensatore, quindi, un’opera come Hegel. La dialettica di Vladimiro Giacché (Diarkos, 2023, pp. 240, € 18,00) risulta di grande utilità. Nella nuova edizione (la prima era uscita nel 2020 in piena pandemia), l’autore ha ulteriormente semplificato il linguaggio (in verità già ampiamente chiaro), arricchito la parte antologica e aggiornato i riferimenti alle nuove edizioni critiche.
LC – Hegel viene considerato da molti il filosofo della reazione prussiana. Eppure da giovane scrive opere sovversive (che si guarda bene dal pubblicare), sostiene la necessità dell’abolizione dello stato e manda alle stampe testi politici anonimi. Poi, nel corso di tutta la vita, intreccia rapporti con rivoluzionari, liberali ed ebrei fino ad aiutare un prigioniero politico. Insomma, che tipo di filosofia è quella di Hegel? Ha ragione Marx a ritenerla rivoluzionaria o di contro Popper a sostenere che fosse reazionaria?
VG – Popper sicuramente non ha ragione. Di contro alle opere giovanili e a quanto contenuto nelle lettere, è vero che nei volumi pubblicati e specialmente nella Filosofia del diritto si avverte un adeguamento alla situazione politica vigente. Ma il tema va affrontato in termini più filosofici che politici. Il problema è come interpretiamo il rapporto tra razionale e reale. Come noto, per Hegel «ciò che è reale è razionale”. Ma questo non significa affatto che tutto ciò che esiste, per il fatto stesso di esistere, sia razionale. Uno stato cattivo può ben esistere, ma per Hegel è “non-vero”, cioè inadeguato, imperfetto. Inoltre – Engels lo ha spiegato molto bene – il nesso realtà-razionalità in Hegel non può esser considerato in termini statici: in questo senso si può dire che era razionale il feudalesimo, ma anche il capitalismo che l’ha sostituito. La filosofia di Hegel è basata sulla processualità delle cose e sulla realtà della contraddizione. Questa non è un fallimento del pensiero, ma una sfida per il pensiero, che deve essere capace di comprenderla. Una filosofia del genere non si presta a giustificare un ordine economico e giuridico immutabile. Alla base del pensiero hegeliano c’è l’inquietudine.
giovedì 25 gennaio 2024
Il mondo di Lenin. Passaggio a Oriente - Luca Cangemi
Da: https://www.girodivite.it - Luca Antonio Cangemi Docente di Filosofia e Storia, dottore di ricerca in Scienze Politiche, fa parte della segreteria nazionale del Partito Comunista Italiano.
Leggi anche: Lenin - Opere complete
Sulla Nostra Rivoluzione*- Vladimir Lenin (1923)
LENIN - CENTRALITA' DELLA TEORIA (1996) - Stefano Garroni
LENIN: LA RIFLESSIONE SUL PARTITO. UN USO DELLA DIALETTICA* - Stefano Garroni
RICERCHE MARXISTE - L’ambivalenza di Lenin - Stefano Garroni
RICERCHE MARXISTE - Lenin: teoria, ideologia, burocrazia - Aristide Bellacicco
RICERCHE MARXISTE - Materialismo dialettico, materialismo non dialettico - Aristide Bellacicco
Un “ponte sull’abisso”. Lenin dopo l’Ottobre*- Alexander Höbel
l concetto di «capitalismo di Stato» in Lenin - Vladimiro Giacché
Lenin, 150 anni dopo la sua nascita - Atilio A. Boron
Il mito dell’imperialismo russo: in difesa dell’analisi di Lenin*- Renfrey Clarke, Roger Annis**
La luxemburg, Lenin e la democrazia. - Stefano Garroni. 14/06/2006
Domenico Losurdo: Il fondamentalismo occidentale - Emiliano Alessandroni
Esiste oggi un imperialismo europeo? - Domenico Losurdo
Il governo della guerra attacca la scuola - Luca Cangemi
Un blocco imperialista digitale? - Luca Cangemi
Vedi anche: Rivoluzione socialista e Rivoluzione anticoloniale - Domenico Losurdo
PENSARE LA RIVOLUZIONE RUSSA* - Luciano Canfora
Cento anni dalla Rivoluzione d'Ottobre - Vladimiro Giacché - Domenico Losurdo
Il discorso di Lenin sull’Oriente è anche il discorso di un nuovo, necessario, rapporto tra il movimento operaio dei paesi capitalistici dell’occidente e i popoli in lotta per la liberazione dal giogo coloniale. La Rivoluzione russa viene vista come il ponte tra queste due realtà. La sconfitta del movimento operaio e del marxismo in occidente pongono ora problemi enormi.
Se la cifra di questi nostri anni convulsi è il tendenziale rovesciamento della ri-colonizzazione (americana) del mondo, più nota sotto il nome di globalizzazione, e persino il tramonto del dominio occidentale sul globo (esito tutt’altro che scontato ma possibile), allora è necessario tornare a studiare l’iniziativa leniniana poi sviluppatisi lungo assai tortuosi sentieri ben oltre la fine del Secolo Breve (che sembra pretendere di diventare molto lungo) che di questi sconvolgimenti è, indiscutibilmente, la matrice. È come se attraverso la faglia leniniana prorompesse una nuova ondata di materiale storico incandescente, che non si può comprendere se non si torna alle caratteristiche originarie di quella frattura.
Che di frattura decisiva si tratti fu chiaro subito ai protagonisti di questa lunga storia. Il carattere “sconvolgente” e “costituente” delle idee di Lenin e degli atti del governo sovietico (sin dai primi giorni) sull’autodeterminazione dei popoli sono rilevati con stupore praticamente da tutti gli esponenti che da posizioni assai diversificate (a volte lontanissime da quelle dei comunisti) si pongono il tema dell’emancipazione delle nazioni costrette dagli europei alla condizione di colonie o semicolonie.
A Canton Sun Yat Sen fece chiudere i teatri per tre giorni alla notizia della morte di Lenin. È notissima la lettera che (siamo già nel 1930) Nehru scrive da una prigione inglese alla figlia Indira Gandhi indicando come memorabile l’anno di nascita della ragazzina (il 1917!) grazie all’opera di “un grande uomo”, ma valutazioni e attenzioni simili le troviamo in nazionalisti turchi, intellettuali persiani persino in qualche principe afghano con volontà di emanciparsi dal controllo inglese. Senza parlare ovviamente di coloro per cui militanza comunista e militanza anticoloniale da subito si identificarono.
martedì 19 settembre 2023
Nietzsche i millenni plebei e l'avvenire della vita - Salvatore Natoli
Appunti su “la Distruzione della Ragione”, di György Lukács -










