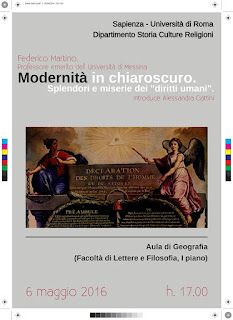Vedi anche; http://ilcomunista23.blogspot.it/2016/01/i-marxismi-in-italia-roberto-finelli.html
“È
preferibile ‘pensare’ senza averne consapevolezza critica, in modo disgregato e
occasionale […] o è preferibile elaborare la propria concezione del mondo
consapevolmente e criticamente? […] Si è conformisti di un qualche conformismo,
si è sempre uomini-massa […] Criticare la propria concezione del mondo
significa dunque renderla unitaria e coerente e innalzarla fino al punto in cui
è giunto il pensiero mondiale più progredito pensare coerentemente e in modo
unitario”
A. Gramsci, Quaderni del
carcere
1. Una rivoluzione
passiva.
Alla fine degli anni ’70 del secolo scorso gli intellettuali
italiani hanno abbandonato, in massa e in modo definitivo, il marxismo. Il
fenomeno non è stato solo italiano, ma in Italia, per il radicamento e la lunga
storia che il marxismo, nelle sue varie accezioni, aveva avuto, quel congedo
significava la conclusione e la disgregazione di un mondo, di una comunanza di
idee, di linguaggio, di confronti e di scontri. “Nell’arco di quattro o cinque
anni, fra il 1976 e il 1981, sprofondarono in una rapida obsolescenza modelli
di pensiero, criteri di valutazione morale e psicologica, forme della
sensibilità. E con le ‘cose’ cambiarono le ‘parole’. A sottolineare il
carattere radicale di questo fenomeno di trasformazione dei modi di pensare di
tutto un ceto sociale e delle sue propaggini immediate qualcuno impiegherà più
tardi la metafora della mutazione antropologica e genetica”1 .
Da tale passaggio socio-culturale, che ha segnato
profondamente l’intellettualità e l’ideologia italiana, è derivata insieme ad
altri fattori, quella rivoluzione passiva che i ceti popolari e i gruppi
sociali più radicali hanno vissuto e subìto durante l’ultimo quarantennio, e continuano
tuttora dolorosamente e drammaticamente a subire. Perché a me sembra che quanto
sia venuto accadendo negli ultimi decenni, sul piano storico-sociale, nel mondo
occidentale, e particolarmente in Italia, sia definibile appunto come una rivoluzione
passiva nel senso più rigorosamente gramsciano di questa espressione, quale
rivoluzione-restaurazione: cioè quale realizzazione reazionaria e regressiva di
un programma di rivoluzione etico-politica originariamente avanzato dai ceti
subalterni2 .
Infatti non rientra, nel canone, appunto, di una rivoluzione
passiva l’assunzione e la trasformazione/svuotamento dei valori più positivi ed
innovativi del ’68 nella realtà di un’«autorealizzazione amministrata»3 , ossia
di un’affermazione e di una valorizzazione del Sé ricondotte a funzione della
tecnologia e delle macchine dell’informazione di cui s’è avvalsa l’ultima
rivoluzione industriale?