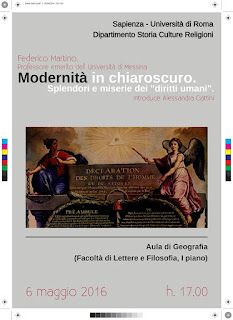In un'interessante
lezione Federico Martino ha ricostruito la storia dei diritti umani, mostrando
la stretta relazione che essi intrattengono con l'individualismo occidentale e
con il costituirsi della borghesia. Tale legame di classe ostacola però la loro
efficace applicazione.
Il passato 6 maggio Federico Martino, storico
del diritto e professore emerito dell'Università di Messina, ha tenuto
un'interessante lezione sui diritti umani, il cui titolo coincide
con quello del presente articolo. La lezione è stata tenuta nell'ambito del
corso di Antropologia culturale, disciplina il cui oggetto precipuo è
rappresentato dallo studio delle differenze tra le forme di vita sociale che si
sono succedute nella storia e che coesistono nella società contemporanea, sia
pure ormai inserite in un unico sistema politico-economico profondamente
conflittuale. In ambito antropologico l'indagine sulle differenze è sempre
accompagnata dalla riflessione sulla possibilità di individuare un denominatore
comune che possa fungere da elemento di raccordo tra le diversità che, in
seguito ai processi migratori degli ultimi decenni, costellano la nostra vita
quotidiana.
Federico Martino ha esordito indicando quali erano i
presupposti metodologici a cui si richiamava per illustrare sia pure rapidamente
la storia di tali principi fondativi della nostra forma di organizzazione
sociale, rimarcando al contempo le criticità che sono strettamente connesse
alla loro applicazione, assai spesso ispirata alla volontà di ingerenza ed
espansione.
Tali presupposti metodologici sono stati individuati in
questi tre assunti: 1) la storia è sempre storia contemporanea, nel senso che
lo studioso parte dai problemi dell'oggi per riflettere sul passato, pur
rifuggendo da una prospettiva riduzionistica che leggerebbe quest'ultimo come
mera anticipazione dell'attuale; 2) le idee scaturiscono dalle relazioni
sociali tra gli uomini, le quali si fondando sui rapporti di produzione, e al
tempo stesso le prime interagiscono dialetticamente con tale dimensione; 3) ogni
forma di comprensione storica studia i fenomeni nella loro specificità e
particolarità, ma si pone anche l'obiettivo di inquadrarli in categorie di
carattere più generale; in questo senso lo studioso non si limita ad osservare
il singolo albero strappandolo dalla foresta, ossia dal quadro generale nel
quale esso si colloca.
Fatte queste premesse Martino ha letto un passo assai
significativo della Dichiarazione di indipendenza dalla Gran Bretagna delle 13
colonie statunitensi scritta da Thomas Jefferson nel 1776, e che rappresenta un
buon condensato del nucleo fondamentale dei diritti umani così come ancora oggi
in larga parte sono intesi. Così scrive Jefferson: “Noi riteniamo che le
seguenti verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini siano stati
creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro creatore di alcuni diritti
inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della
Felicità; che allo scopo di garantire questi diritti sono creati fra gli uomini
i Governi; che ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo tende a negare
tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo
Governo, che si fondi su quei principi e che abbia i propri poteri ordinati in
quella guisa che gli sembri più idoneo al raggiungimento della sua sicurezza e
felicità” [1] (Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America).