*Da: https://www.facebook.com/Economisti-di-classe-Riccardo-Bellofiore-Giovanna-Vertova-148198901904582/?fref=ts (pubblicato in due parti come: (a) Economia politica e
filosofia della storia. Variazioni su un tema smithiano: la missione
‘civilizzatrice’ del capitale, in
“Teoria politica”, n. 2, 1991, pp. 69-96; (b) Cambiare la natura umana. Ancora
su economia politica e filosofia della storia, “Teoria politica”, n. 3, 1991,
pp. 63-98)
**Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bergamo
Jean Paul Sartre, "Matérialisme et révolution",
in Situations, I, Paris 1957, p. 213
1. Introduzione
L'economia politica ha costituito da sempre terreno fertile
per la riflessione filosofica. Gli ultimi anni, da questo punto di vista, non
fanno eccezione: basta pensare al proliferare di studi di epistemologia
economica, o ancora alla questione della relazione tra etica ed economia. Il
problema che vorrei affrontare nelle pagine che seguono è invece di quelli un
po' desueti: la ricerca bibliografica difficilmente registrerebbe titoli recenti;
l'inglese non sarebbe forse la lingua egemone; la letteratura definibile in
senso lato come empirista e liberale sarebbe una componente importante ma non
esclusiva.
Si tratta, per dirla in breve ed un po' enfaticamente, di
ripercorrere le tappe principali di quella linea di pensiero che si è
interrogata sulla missione "civilizzatrice" e sul ruolo storico del
capitale. Di riandare, dunque, a quegli autori che hanno visto nel primato
dell'economico un problema, sino in alcuni casi ad auspicare, o a temere, un
suo possibile superamento. E che, proprio perché questo era il loro tema, si
sono trovati a fare affermazioni impegnative sulla "natura umana", e
sul "significato della storia". Terreno che altri giudicherà
scivoloso, e che senz'altro lo è: ma che comincia ad apparirmi culturalmente, e
politicamente, ineludibile, per ragioni che spero saranno più chiare alla fine
di questo scritto. Certamente in questa luce l'economia politica si confonde
con la filosofia della storia e con la filosofia morale; l'indagine sulle leggi
di funzionamento del sistema sfocia nella questione del "senso" del
corso storico, si confonde con la discussione sulla "giustificazione"
del capitalismo - come vedremo, le due cose sono anzi per molti degli autori
che considererò due facce della stessa medaglia.
Il metodo che adotterò sarà quasi sempre quello di far
parlare direttamente i testi. Metodo soggettivo ed arbitrario quant'altri mai,
al di là dalle apparenze: benché poco di ciò che dirò pretenda di essere
originale, la selezione e il percorso che proporrò presuppongono un filtro
interpretativo molto forte, che rimarrà però in buona misura implicito. Il
gioco, o le buone regole, della conversazione intellettuale richiedono che io
mostri di credere fino in fondo alle ipotesi che avanzo: ciò non toglie che -
trattandosi di un tema che costringe ad abbandonare i sicuri recinti degli
specialismi - la critica sia la benvenuta.
2. Migliorare la propria posizione. Natura e storia in
Smith.
"Nessuno, se non un mendicante, sceglie di dipendere
soprattutto dalla benevolenza dei suoi concittadini."
Adam Smith, La Ricchezza delle nazioni. Abbozzo (ca
1763), Boringhieri, Torino 1959, p. 42
2.1. La filosofia morale.
E' ormai riconosciuto che il punto di partenza della teoria
economica di Smith va individuato in quell' originale compromesso tra le
posizioni contrapposte di Hobbes e Hume cui l'autore scozzese approda
nella sua filosofia etica: un compromesso di cui la Teoria dei
sentimenti morali è il frutto più maturo, e senza il quale la Ricchezza
delle nazioni sarebbe incomprensibile.
Nello stato di natura di Hobbes, i liberi individui isolati
sono mossi esclusivamente da moventi egoistici, sicché la relazione tra di essi
è definibile come una guerra di tutti contro tutti. Qualora lo stato di natura
si realizzasse nella sua purezza, qualsiasi convivenza sociale si rivelerebbe
impossibile. La società civile nasce in conseguenza dell'alienazione allo Stato
dei propri poteri naturali: della rinuncia all'agire secondo passione, e
dell'istituzione di un patto secondo ragione. Si tratta, dunque, di una
costruzione artificiale. Dell'esito volontario di una convenzione, o di un
contratto, tra soggetti calcolanti.
La critica di Hume a Hobbes ha inizio con il rifiuto della
finzione di uno stato di natura e con il riconoscimento di una dualità
psicologica fondamentale. Accanto al linguaggio dell'egoismo, Hume individua
infatti un "sentimento" originario di natura opposta allo spirito di
cupidigia; un sentimento che spinge alla realizzazione del bene (o
dell'utilità, o della felicità) individuale e sociale, e che è la fonte del
giudizio morale. Tale sentimento è la "simpatia", o
"benevolenza". L'etica di Hume si qualifica così come rigorosamente
altruistica: la generale diffusione di un "senso di umanità", e la
possibilità dell'individuo di giudicare la propria azione come se fosse uno
spettatore imparziale, fanno sì che il comportamento virtuoso possa aver luogo
non in circoli ristretti ma in società allargate.L'egoismo, il self-love,
appare
invece come eticamente neutro.
Lo sviluppo ed il rovesciamento che Smith opera rispetto a
Hume possono apparire in piena evidenza una volta che si sottolinei come per
Smith l'egoismo è il mezzo essenziale per la costituzione concreta di quel
legame generale tra gli uomini, di quella "società" in senso proprio,
che dovrebbe essere il luogo dove si esercita il comportamento morale di Hume.
Infatti, il meccanismo impersonale del mercato - l'interazione tra i mercanti
spinti esclusivamente dal perseguimento dell'interesse individuale - produce
una accelerazione della crescita della ricchezza materiale. Il benessere di
ciascuno diviene funzione del lavoro di sconosciuti.
In quest'ottica l'egoismo può caricarsi, sia pure
mediatamente, di un suo valore "morale", per un duplice ordine di
ragioni. La reale "possibilità" ed "universalità"
dell'etica altruistica di Hume, come etica non particolare ma comune al genere
umano, dipende dal generalizzarsi dello scambio: in altri termini, se si guarda
a ciò che avviene nella sfera economica, la "guerra di tutti contro
tutti", lungi dal disgregare la società, ne pone le fondamenta. Inoltre,
l'inclusione nel mondo del lavoro dei poveri, trasformati da mendicanti in
salariati, e la crescita del benessere materiale goduto da tutti gli ordini
della società, sono entrambi l'effetto - certo inintenzionale ma cionondimeno
positivo - del libero confliggere dell'avidità dei singoli.
La presenza di questi due temi - la società
"progredita" è una società di mutua e generale dipendenza materiale;
un paese è "civile" se la prosperità è diffusa tra tutte le classi -
è evidente sin dalle prime pagine della Ricchezza delle nazioni (1776).
Per quanto riguarda la sempre maggiore integrazione sociale propria dell'epoca
moderna, si vedano per esempio questi due brani:
"In una società incivilita" l'uomo
"ha bisogno in ogni momento della cooperazione e dell'assistenza di
moltissima gente, mentre tutta la vita gli basta appena per assicurarsi
l'amicizia di poche persone." In quasi tutte le altre razze animali
l'individuo giunto a maturità è del tutto indipendente, e nel suo stato
naturale non ha bisogno dell'assistenza di altre creature viventi. L'uomo
ha invece quasi sempre bisogno dell'aiuto dei suoi simili e lo aspetterebbe
invano dalla sola benevolenza; avrà molta più probabilità di ottenerlo
volgendo a suo favore l'egoismo altrui e dimostrando il vantaggio che gli altri
otterrebbero facendo ciò che egli chiede." (Indagine sulla natura e le
cause della ricchezza delle nazioni, Isedi, Milano 1973, p.19)
"senza l'assistenza e la cooperazione
di molte migliaia di persone, l'ultimo degli abitanti di
un paese civile non potrebbe mai godere, come ora di norma gode, di
un tenore di vita che noi a torto riteniamo semplice e facile ad aversi.
Sembrerà certo tale, a paragone del lusso più sfrenato di un gran signore;
pure, è probabile che da questo punto di vista, la distanza che separa un
principe europeo da un contadino industrioso e frugale è meno grande di quella
tra quest'ultimo e i vari re africani, padroni assoluti della vita e della
libertà di diecimila selvaggi nudi."(Ricchezza, p. 16)
Non meno netto è il legame che Smith istituisce tra la
società "progredita" - quella società dove la divisione del lavoro ha
preso piede al punto da condurre ad una specializzazione tendenzialmente senza
limiti - e la generale diffusione del benessere materiale anche tra gli
appartenenti alle classi più povere:
"La grande moltiplicazione dei prodotti di
tutte le varie arti, in conseguenza della divisione del lavoro, è
all'origine, in una società ben governata, di una generale prosperità
che estende i suoi benefici fino alle classi più basse del popolo. Ogni
operaio può disporre di una grande quantità del suo lavoro che supera le sue
necessità, e dal momento che tutti gli altri operai si trovano esattamente
nella stessa situazione, è in grado di scambiare una grande quantità dei suoi
beni con una grande quantità dei beni degli altri, oppure, che è lo stesso, con
il prezzo di questa quantità. Egli li fornisce copiosamente di ciò di cui hanno
bisogno ed essi fanno lo stesso con lui, sicché una generale abbondanza
si diffonde fra tutti i diversi ceti sociali." (Ricchezza, p.
15)
Queste tre citazioni nascondono tra le proprie righe il
problema che la società moderna pone a Smith, e le linee generali della
soluzione che egli avanza. Il modo con cui l'uno e l'altra sono esposti ci
consentono di cogliere quale sia per Smith la giustificazione storica della
"grande società", del modo di produzione capitalistico. E' a queste
tre questioni che dedicherò questa sezione e le due seguenti.
2.2. Il problema: ineguaglianza e benessere.
Il problema di Smith è rivelato dal confronto tra la
disparità di benessere che separa ricchi e "poveri che lavorano"
all'interno della società progredita (il principe europeo e il contadino
industrioso), e il maggiore "agio" che separa il lavoratore a
giornata dai capi di una società arretrata. La diseguaglianza propria della
"società commerciale" non si accompagna solo al comprensibile lusso
dei proprietari - il cui privilegio si esprime nella condizione di non lavoro e
nella possibilità di comandare, di impiegare per il proprio utile, il lavoro di
altri. Essa si accompagna anche, più misteriosamente, ad un continuo
miglioramento della condizione degli strati più bassi e numerosi della
popolazione, i lavoratori non proprietari. Vi è qui un contrasto significativo
con lo stadio "rozzo e primitivo", dove ognuno è proprietario tanto
delle condizioni della produzione quanto del prodotto del proprio lavoro; dove
non esistono classi che non lavorano; e dove vige una generale eguaglianza.
Eppure, nota Smith, in tale situazione, ad essere condivisa non è, come ci si
aspetterebbe a prima vista, l'abbondanza ma la miseria.
Insomma: le società arretrate hanno come destino la
stagnazione e la fame; viceversa, la società del mercato e del capitale
garantisce la crescita della produzione, l'aumento della popolazione
lavoratrice, una generale diffusione del benessere materiale. Questa
considerazione - che è spesso l'alfa e l'omega di una visione apologetica della
società capitalistica - è invece, per Smith, l'enigma che l'analisi deve
sciogliere. Già nell' "Introduzione" della Ricchezza
delle Nazioni si legge che:
"Nelle nazioni selvagge di cacciatori
e pescatori, ogni individuo in grado di operare è più
o meno impiegato in un lavoro utile con cui si sforza di provvedere
alle necessità e ai comodi della vita . . . Pure, tali nazioni vivono
in una povertà così orribile che soltanto per bisogno si trovano
spesso ridotte, o almeno credono di esserlo, alla necessità di eliminare
bambini, vecchi e ammalati inguaribili . . . Nelle nazioni civili e
floride, all'opposto, sebbene una gran quantità di gente non lavori
affatto, e molte di queste persone consumino il prodotto di un lavoro dieci
e spesso cento volte maggiore della maggior parte di quelli che lavorano, pure
il prodotto complessivo del lavoro sociale è così grande che tutti gli
individui ne risultano spesso abbondantemente provvisti." (Ricchezza, p.3-4)
Nell' Abbozzo (1763) Smith era stato ancora
più esplicito nell'individuare la contraddizione della "grande
società" contemporanea tra "ineguaglianza nella proprietà" e
"universale benessere" (p.26), e nello svelare il suo punto di vista:
"Non è certo molto difficile spiegare come
avvenga che in una società evoluta, il ricco e il potente si procaccino gli agi
e tutto ciò che è necessario per vivere, meglio di quanto non possa fare
qualsiasi persona che viva da sola allo stato selvaggio. E' molto
facileimmaginare che colui che può, in ogni tempo, dirigere ai suoi propri
fini il lavoro di migliaia di uomini debba essere provvisto di tutto ciò di cui
ha bisogno meglio di chi dipende dalla propria ed esclusiva attività. Ma
non è così facilmente comprensibile come avvenga che il contadino e il
lavoratore siano egualmente meglio provvisti. In un paese civile i poveri
provvedono a se stessi e all'enorme lusso dei loro signori . . . Tra i
selvaggi, invece, ognuno gode dell'intero prodotto della propria attività. Non
ci sono tra loro né padroni, né usurai, né esattori di tasse. Potremmo
quindi naturalmente attenderci - se l'esperienza non ci
dimostrasse il contrario - che ciascuno di essi debba godere degli agi
e di tutte quelle cose che sono necessarie per vivere, in misura maggiore che
non gli strati inferiori del popolo in un paese civile." (Abbozzo, p.
18-19)
Nella società commerciale chi lavora è soggetto ad una
"enorme defalcazione" sicché "a quelli che lavorano di più
tocca di meno" (nelle Lezioni di Glasgow (1762-1763)
è detto, sullo stesso tono: "colui che sopporta, per così dire, il peso della
società, è quello che ne trae i minori vantaggi " (incluso in
Claudio Napoleoni, Smith, Ricardo Marx, Boringhieri, Torino, 19732,
p. 178)). Eppure, anche chi è "schiacciato da una così opprimenteineguaglianza"
gode di una "maggiore ricchezza e abbondanza di beni" rispetto ai
membri di una società "selvaggia" (p. 20-21).
2.3. La soluzione: divisione del lavoro e inclinazione
allo scambio.
La soluzione di Smith fa perno sulla divisione del lavoro:
un lavoro "sociale", specializzato ed adibito ad una unica mansione,
ad una attività particolare, produce più di quanto produrrebbe il lavoro di un
produttore "isolato". L'aumento della produttività media consente il mantenimento
sia di "padroni", "mercanti" e proprietari fondiari, sia di
oziosi e improduttivi. Ma consente anche di soddisfare sempre meglio i bisogni
naturali, le necessità fondamentali (cibo, vestiario e riparo), tra le classi
più umili. La ragione è costituita dal fatto che ciò che resta al lavoratore è
un prodotto comunque maggiore di quello che egli si sarebbe procurato con un
lavoro non diviso, anche tenendo conto delle "deduzioni" del profitto
e della rendita. L'estrazione di un sovrappiù nella "grande società"
si accompagna per questa via ad un miglioramento, quantitativo e qualitativo,
della sussistenza rispetto alle società primitive, nelle quali la divisione del
lavoro è solo ai primi passi, ed in particolare rispetto alla condizione del
lavoro non diviso:
"Quando il lavoro è così diviso, e una così grande
quantità di lavoro viene eseguita in proporzione da un solo uomo, il sovrappiù,
ossia ciò che supera quanto è necessario al sostentamento delle persone
impiegate, è considerevole, e ognuno può ottenere nello scambio
quattro volte quello che gli sarebbe stato possibile se avesse eseguito il
lavoro interamente da solo. Per questa via il bene prodotto è accessibile a
un prezzo molto più basso, e il lavoro diviene invece molto più caro."
(Lezioni, p. 179)
Come si sa, la divisione del lavoro dipende per Smith dallo
scambio, per così dire, tanto a monte quanto a valle. A valle, perché la
divisione del lavoro, e dunque l'innalzamento della produttività, sono tanto
più approfonditi quanto maggiore è l'estensione del mercato: dunque, quanto
maggiori sono le aspettative di profitto degli imprenditori. A monte, perché la
divisione del lavoro trova la sua sorgente in una inclinazione,
"naturale" e "comune a tutti gli uomini", al baratto e allo
scambio: la quale a sua volta, come recitano le Lezioni di Glasgow,
può essere ricondotta al "desiderio di persuadere, così caratteristico
della natura umana" (p. 183).
Abbiamo già visto, da una delle citazioni dalla Ricchezza
delle Nazioni, che, a differenza delle altre specie animali, l'uomo ha
bisogno dell'assistenza dei suoi simili. Tale affermazione è peraltro ambigua,
nel testo di Smith. Il bisogno di cooperazione e assistenza viene infatti
interpretato a chiare lettere da Smith come una condizione propria della
società "progredita", delle nazioni "civili"; al tempo
stesso, l'autore scozzese sembra suggerire una tesi alternativa, quella secondo
cui "quasi sempre" l'uomo dipende dai propri simili (d'altronde, già
nella Teoria dei sentimenti morali Smith aveva sostenuto che
"l'uomo può vivere solo in società").
Credo che questa duplicità possa essere sciolta se si coglie
che per Smith la società di mercato, come mutuo nesso materiale, realizza
pienamente nel corso della storia la dipendenza dell'uomo dall'uomo,
corrispondente alla "natura". Anche qui - sulla scorta della lettera
del 1755 all' "Edinburgh Review" in cui Smith commenta il Discorso
sull'ineguaglianza del filosofo ginevrino - la posizione di Smith può
essere interpretata come un compromesso tra la tesi di Mandeville e quella,
appunto, di Rousseau:
"Il Dr. Mandeville rappresenta lo stato primitivo del
genere umano come il più triste e il più miserabile che si possa immaginare.
Rousseau, al contrario, lo considera come il più felice e il più conforme alla
nostra natura. Entrambi tuttavia ritengono che nell'uomo non vi sia
alcun istinto che l'induca necessariamente a ricercare la società come tale.
Secondo il primo, è la miseria del suo stato originario che costringe l'uomo a
far ricorso a questo sgradevole rimedio. Secondo l'altro un seguito di eventi
sfortunati" (trad. in Lucio Colletti, Ideologia e società,
Laterza, Bari 1970, p. 265)
Impiegando le parole stesse di Smith, la nostra lettura è
che per l'autore scozzese lo stadio "rozzo e primitivo" è realmente
"il più triste e miserabile"; davvero la scarsità stringe l'uomo
nella sua morsa. Ciononostante, la debolezza - per così dire - dell'individuo
isolato rispetto alla natura non è il primo motore del legame sociale. E', al
contrario, la presenza, già nella condizione originaria, di un "istinto
che l'induce necessariamente a ricercare la società come tale" - è
l'inclinazione allo scambio che gli è propria in quanto essere dotato di
ragione e linguaggio - che dà conto della spinta a vivere in società. In altri
termini: nello stato primitivo, la socialità è sì essenziale, ma esiste solo in
potenza. Da questo punto di vista, la natura umana appare un prodotto storico,
non un dato di partenza: ed il meccanismo che consente che essa giunga a
maturità è appunto la divisione del lavoro.
La situazione originaria, in cui l'uomo vive in comunità, è
una situazione per un verso di eguaglianza e scarsità, per l'altro di
indipendenza reciproca. In essa gli individui sono egoisti, ma spinti
alla comunicazione: autonomi materialmente, dipendono però dal giudizio
dell'altro. In questo senso, si può ben qualificarli come animali sociali. Lo
"scambio" intellettuale si tramuta ben presto nel commercio vero e
proprio, e nel volgere a proprio vantaggio l'egoismo degli altri:
"Se un qualche animale intende effettuare uno scambio,
per così dire, od ottenere qualcosa dall'uomo, può riuscirvi solo in grazia del
suo affetto e della sua gentilezza. L'uomo fa, nella stessa
maniera, leva sull'egoismo dei suoi simili, offrendo loro un motivo
sufficiente di tentazione per ottenere da essi ciò che vuole. Un siffatto
comportamento può così esprimersi: "Dammi ciò che voglio, e avrai ciò che
vuoi". Al contrario del cane, l'uomo non spera qualcosa dalla
benevolenza, bensì dall'egoismo." (Lezioni, p. 183)
Su questa base si erige quella divisione del lavoro per cui
alla fine "ogni uomo vive di scambi, o diventa in certa misura un
mercante" (Ricchezza, p. 26) e che fa sì che l'egoismo divenga il
cemento della società. La divisione del lavoro è la conseguenza - certamente
"lenta e graduale" (dunque, non preordinata; inintenzionale) ma
cionondimeno "necessaria" - "delle facoltà della ragione e della
parola" (Ricchezza, p. 16). La storia si configura qui come il
progressivo svolgimento di un principio originario e benefico, in forza del
quale l'egoismo proprio dell'uomo, il fare dell'altro un mezzo per i propri
scopi, diviene a sua volta - attraverso l'impulso che dà al processo di
specializzazione - il tramite essenziale per il completo dispiegarsi di una
altrettanto originaria tendenza alla integrazione o socialità.
Se, come spesso viene fatto, si attribuisce troppo
facilmente a Smith l'identificazione tra la "società commerciale" di
cui parla nei primi due libri della Ricchezza delle nazioni ed
il capitalismo emergente che ha concretamente di fronte, il passo è breve per
farne senza troppi complimenti il sostenitore della razionalità e naturalità
del mondo che esce dalla rivoluzione industriale. Il capitalismo si
configurerebbe, in questa lettura, come la fine della storia e la realizzazione
della natura.
Le cose, come vedremo, non sono così semplici. Prima però di
dar conto di questo nostro giudizio, conviene analizzare con più attenzione le
tensioni contrastanti che attraversano la visione della natura umana di Smith,
e la sua interpretazione della divisione del lavoro: tensioni che trovano il
loro momento di cristallizzazione nella teoria del valore-lavoro comandato.
2.4. Ancora sulla filosofia morale
Prima di procedere oltre, vale la pena di notare che la
naturale "socialità" dell'essere umano si riverbera sullo stesso
egoismo, che è per Smith inseparabile da una dimensione relazionale. E'
mettendo al nostro servizio l'egoismo degli altri che possiamo perseguire il
nostro interesse individuale. Ma, più fondamentalmente, la molla universale che
ci spinge è "migliorare la nostra posizione":
"Da dove dunque nasce quell'emulazione che corre
attraverso tutti i diversi ceti degli uomini, e quali sono i vantaggi che ci
proponiamo con quel grande obiettivo della vita umana che chiamiamo migliorare
la propria posizione? Essere osservati, che ci si occupi di noi, che ci
si informi di noi con simpatia, con compiacimento e approvazione, questi sono i
soli vantaggi che possiamo proporci di ottenere con esso. E' la
vanità, non l'agio o il piacere che ci interessa." (Teoria dei
sentimenti morali, p. 50, cit. in Maria Luisa Pesante, Economia e
politica , Angeli, Milano 1986, p. 20).
Lo stesso egoismo rimanda dunque al principio originario
della socialità umana, la dipendenza dallo sguardo dell'altro.
"Il desiderio di migliorare la propria
condizione", "di norma calmo e scevro di passionalità, è presente in
noi fin dalla nascita e non ci abbandona mai fino alla tomba". "Il
mezzo più comune e ovvio" con cui tale desiderio si realizza è "un
aumento del patrimonio" (Ricchezza, p. 336). Ogni individuo
"mira solo al suo proprio guadagno ed è condotto da una mano invisibile,
in questo come in altri casi, a perseguire un fine che non rientra nelle sue
intenzioni": curando il proprio interesse, dà luogo alla prosperità
pubblica. Perseguendo l'egoismo, porta al massimo grado la socialità.
Siamo ben lontani dall'individuo isolato di Hobbes, o - se è
per questo - anche dall' "amor proprio" di Rousseau. La rivalità nel
commercio dell' uno con l'altro conduce ad un addolcimento del carattere e
frena le passioni: l' uscita da quello stato permanente di guerra e di
dipendenza servile che caratterizza l'ordine feudale è in qualche misura essa
stessa un portato della ricerca del proprio utile individuale. Smith nega come
corrispondente alla natura una originaria autonomia dell'uomo isolato, e
afferma anzi una sua essenziale socialità. La struttura relazionale del self-love e
l'affermazione dello scambio, prima intellettuale e poi materiale, come nesso
sociale "naturale", fanno dell'autore scozzese qualcosa di molto
diverso da un individualista radicale.
3. Il comando sul lavoro. Individuale e sociale, dallo
stadio "rozzo e primitivo" alla "grande società".
"Sono sempre disposto a correre il rischio di
essere noioso pur di essere sicuro di essere chiaro. E dopo aver fatto tutti
gli sforzi possibili per essere chiaro, potrà ancora risultare qualche oscurità
su un argomento per sua natura estremamente astratto."
Adam Smith, La Ricchezza delle Nazioni , p.
31
3.1. Il lavoro dell'uomo isolato
La rottura di Smith con la posizione che afferma una
primitiva asocialità dell'uomo è peraltro contraddetta da un motivo altrettanto
potente della sua teoria economica, il motivo del lavoro.
Quando Smith deve spiegare la generale diffusione del
benessere nella società mercantile ricorre agli effetti della divisione del
lavoro: nella sua argomentazione, un ruolo chiave è giocato dal paragone tra la
produttività del lavoro diviso e quella del "lavoro dell'uomo isolato".
Il lavoro dell'uomo isolato segnala l'inatteso riemergere di tracce della
problematica dello stato di natura in Smith. Per un verso, attraverso quel
paragone Smith effettua un confronto tra, da un lato, la situazione di
isolamento degli individui autosufficienti nella produzione e nel consumo che è
propria dello stato originario e, dall'altro lato, una situazione pienamente
storica quale quella della "grande società", in cui gli individui
sono integrati nel consumo e il lavoro è diviso. Per l'altro verso, la
possibilità stessa del paragone presuppone la presenza di un carattere
della attività pratica di appropriazione della natura che permane immutato
nella storia. Vediamo meglio.
Il "lavoro dell'uomo isolato" rappresenta un caso
estremo, quello in cui non esiste specializzazione produttiva, ed in cui dunque
il lavoro di ognuno deve provvedere interamente ai propri bisogni; un caso
estremo che è approssimato dalle società arretrate nelle quali la divisione del
lavoro è limitata e gli scambi sporadici. Ma si tratta anche di un caso che
rende evidente la dipendenza dell'uomo: questa volta però dalla natura, prima e
più fondamentalmente che dall'altro uomo. E' qui, nel lavoro come originario
confronto tra l'uomo solo e la natura, che affonda le sue radici il primato che
la attività di trasformazione dell'ambiente materiale ha nella teoria economica
di Smith. La ragione può essere detta in breve. Per quanto il passaggio dal
lavoro isolato e indipendente al lavoro sociale e diviso aumenti a dismisura la
capacità produttiva, cioè incida sul risultato del lavoro, tale passaggio non
muta però la natura del lavoro stesso. Nella fabbrica moderna il lavoro, pur
ripartito su più persone, rimane sostanzialmente eguale, tanto nel
"sacrificio" che comporta quanto nelle modalità di esecuzione,
rispetto a quello della società primitiva.
Questo "naturalismo" di Smith - se così lo
possiamo chiamare - è il contenuto rimosso che riemerge ripetutamente tanto
nella sua visione della divisione del lavoro quanto nella sua teoria del
valore-lavoro comandato, nonostante e contro l'indubbia centralità dello
scambio tanto per l'una quanto per l'altra.
3.2. Lavoro comandato e scambio
Vediamo, per cominciare, come ciò sia vero nel caso della
teoria del valore.
Il valore è dato per Smith dalla quantità di lavoro che la
merce può comprare o comandare, cioè dal potere d'acquisto di ciò che si è
prodotto e venduto, misurato in lavoro:
"Il valore di una merce, per la
persona che la possiede e che non intende usarla o consumarla lei stessa
ma scambiarla con altre merci, è quindi uguale alla
quantità di lavoro che essa la mette in grado di comprare o di comandare.
Il lavoro è dunque la misura realedelvalore di scambio di
tutte merci. Il prezzo reale di ogni cosa, ciò che costa
realmente a chi ha bisogno di procurarsela, è la pena e il
disturbo di procurarsela. Il valore reale di ogni
cosa per chi se l'è procurata e ha bisogno di collocarla o di scambiarla con
qualche altra è la pena e il disturbo che essa può risparmiargli
imponendoli ad altri." (Ricchezza, p. 32)
Nello stadio "rozzo" e "primitivo" che
precede l'accumulazione del capitale e l'appropriazione della terra , ed in cui
quindi non esistono profitto e rendita, il lavoro comandato è identico al
lavoro contenuto, cioè al lavoro che è stato necessario mettere in movimento
per ottenere quella data merce. L'eguaglianza tra tempo di lavoro comandato e
tempo di lavoro contenuto, come anche l'eguagliamento di lavori di diversa
faticosità o qualificazione, sono garantiti dallo scambio e dalla mobilità del
lavoro. Nel caso di divergenze dei valori di scambio dai lavori contenuti,
converrebbe infatti spostarsi dalle produzioni in cui tale divergenza è
negativa a quelle in cui essa è positiva. Il processo concorrenziale fa dunque
sì che il "valore di scambio" della produzione, ovvero il lavoro
comandato, e il "valore del lavoro", ovvero la spesa necessaria a
pagare il lavoro contenuto, siano identici. Smith descrive tale situazione
dicendo anche che l'intero prodotto è esaurito dal salario.
La divisione del lavoro, facendo emergere un sovrappiù che è
sottratto al lavoratore ed appropriato da capitalisti e proprietari fondiari,
dà luogo ad una eccedenza del lavoro comandato sul lavoro contenuto. Il valore
di scambio di una merce ora comprende anche il profitto e la rendita, ed è
dunque tale da poter acquistare merci in quantità superiore all'equivalente
della spesa in salari sostenuta per la sua produzione. La cosa può essere
espressa in due modi. Lo scambista riceve ora sul mercato più lavoro di quanto
ne offra, perché la merce che vende ha richiesto meno lavoro di quelle che
ottiene in cambio. O, alternativamente - dato il valore del lavoro (il salario)
- con il ricavato della vendita della propria merce egli può ora "mettere
in movimento" più lavoratori di quanti ne erano stati necessari per
produrre quanto ha venduto. Nel primo caso, si sottolinea che dietro lo scambio
di merci vi è indirettamente uno scambio di lavoro (oggettivato). Nel secondo
caso, si sottolinea invece che in conseguenza dello scambio di merci è
possibile acquistare direttamente sul mercato del lavoro più lavoro (vivo).
E' stato spesso rilevato come l'argomentazione di Smith
nasconda un circolo vizioso, in quanto fa dipendere il valore di scambio dal
livello del salario, e dunque da un valore esso stesso. Ciò è senz'altro vero.
Ma - riguardato non dal punto di vista di una teoria della determinazione
dei prezzi relativi, ma dal punto di vista di una teoria che si interroghi
sulla natura dello scambio e del capitale - il ragionamento di Smith è
tutt'altro che incoerente. La definizione del valore come lavoro comandato è
valida, per Smith, in qualsiasi stadio della società. Essa rimanda senza
equivoci al primato della dimensione sociale nella sua visione della natura
umana: infatti, quella definizione non fa che ribadire l'universalità della
originaria "disposizione a trafficare"; e mette in evidenza le
conseguenze della tesi smithiana che quella inclinazione trova la sua piena
realizzazione solo in epoca moderna.
Lo sforzo ricorrente del quinto e del sesto capitolo del
primo libro della Ricchezza delle Nazioni è quello di
generalizzare il punto di vista dello scambio. Si pensi alla circostanza
singolare per cui Smith, quando deve spiegare il valore nello stadio rozzo e
primitivo, non procede nel modo che potrebbe apparire più lineare. Non lo
definisce cioè come il tempo di lavoro contenuto nella merce stesso. Egli
mantiene piuttosto la spiegazione generale: lo determina, dunque, come il tempo
di lavoro che la merce comanda nello scambio tra produttori indipendenti, e
introduce solo a mo' di specificazione la considerazione che, nelle condizioni
istituzionali delle società primitive, tempo di lavoro comandato e tempo di
lavoro contenuto sono identici. Smith è insomma costretto a interpolare nella
descrizione dello stadio "rozzo e primitivo" caratteristiche
"moderne", come la presenza di uno scambio di merci non occasionale
ma ripetuto e la compiuta affermazione del meccanismo concorrenziale:
condizioni entrambe necessarie per poter giustificare l'affermazione che tipi
diversi di lavoro vengano effettivamente equiparati nella vita di tutti i
giorni, e che dunque il tempo di lavoro possa costituire la base del
valore.
All'interno della stessa logica, ed in modo del tutto
analogo, il valore del prodotto del "lavoro dell'uomo isolato" è
determinabile vedendo in quest'ultimo non il produttore autonomo ma lo
scambista: immaginando, cioè, "l'uomo solo" come un soggetto
che scambi con se stesso. Ed anche in questo caso, Smith anticipa al produttore
indipendente categorie distributive moderne, facendone un percettore di di
salario.
3.3. La ricchezza come potere: lavoro comandato e
disuguaglianza
In generale, per l'individuo il "valore reale di ogni
cosa" è "la pena e il disturbo che essa può risparmiargli imponendola
ad altri". La ricchezza è dunque non solo un insieme di valori d'uso
destinati al consumo ma anche e soprattutto potere sull'altro, comando sul suo
lavoro:
"La ricchezza, come dice Hobbes, è potere. Ma la
persona che si procura una grande fortuna o la eredita non deve necessariamente
procurarsi o ricevere in eredità un qualche potere politico, civile o militare.
La sua fortuna può forse fornirgli i mezzi di procurarsi l'uno e l'altro, ma il
semplice possesso di quella fortuna non se li porta dietro necessariamente. Il
potere che quel possesso si porta dietro immediatamente e direttamente è
il potere di comprare, cioè un certocomando su tutto il lavoro,
ovvero su tutto il prodotto del lavoro che si trova sul mercato. La
sua fortuna è maggiore o minore in proporzione esatta all'estensione di quel
potere: ovvero alla quantità sia del lavoro di altri uomini sia,
che è lo stesso, del prodotto del lavoro di altri uomini che
esso lo mette in grado di comprare o di comandare. Ilvalore di scambio di
ogni cosa deve essere sempre esattamenteuguale
all'estensione di questo potere che esso conferisce a chi lo possiede."
(Ricchezza, p. 33)
In origine, quando il prodotto appartiene interamente al
lavoratore, questo potere è reciproco e non in contrasto con l'eguaglianza.
Fuori dallo stadio "rozzo e primitivo", la presenza di deduzioni dal
prodotto del lavoro rivela invece l'esistenza di classi che non lavorano: di
classi che possono attribuire ad altri la "pena e il disturbo" della
produzione della ricchezza. Per queste classi, la ricchezza come consumo è
funzione della ricchezza come potere diseguale. Nella società
"progredita", il sovrappiù può essere destinato ad un impiego
produttivo: può, cioè, essere reinvestito nell'acquisto di lavoratori che
producono altra merce. Di conseguenza, dopo la vendita il capitalista non solo
tornerà in possesso del valore anticipato come monte salari, ma otterrà anche
una eccedenza, nella forma di un profitto lordo (che eventualmente spartirà con
il proprietario fondiario, pagandogli una rendita). In tal modo,
"quell'oggetto o, il che è lo stesso, il prezzo di quell'oggetto, può
successivamente, se necessario, mettere in moto una quantità di lavoro uguale a
quella che lo ha originariamente prodotto"(Ricchezza, p.
323).
Da questo angolo visuale, la teoria del valore-lavoro
comandato esprime, in modo del tutto adeguato, la prospettiva dello scambista
in un mercato capitalistico: una prospettiva che, per quanto abbiamo detto sin
qui, è da Smith resa universale. Detto altrimenti: Smith, facendo valere
"all'indietro" la categoria del lavoro comandato, è in grado di
individuare e sottolineare lo slittamento che la prospettiva dello scambista
subisce quando si passa da una società di produttori indipendenti ad una società
capitalistica.
Al centro del quadro è ora la classe capitalistica. Nella
società moderna, chi acquista dopo aver venduto non è più soltanto il
lavoratore diretto, ma è anche e soprattutto un "mercante", un
"padrone", o "imprenditore". Per il primo le cose, dal
punto di vista del tempo di lavoro comandato, non sono cambiate: il lavoratore
compra ancora merci il cui costo salariale è identico a quello delle merci che
egli stesso produce in quanto operaio; per lui il lavoro comandato continua ad
essere uguale al lavoro contenuto. Per il "padrone", invece, è tutto
diverso. Il fatto che egli percepisca un profitto rivela che egli è in
grado di far lavorare altri per sé, che può procurarsi "le cose necessarie
e comode della vita" non mediante il lavoro ma mediante il comando sul
lavoro, sia oggettivato che vivo. Eppure, paradossalmente, il desiderio
di arricchire della classe imprenditoriale invece di condurre i suoi membri ad
un consumo opulento, si traduce in investimento, e quindi in un aumento del consumo
di una massa crescente di "poveri che lavorano".
La ricchezza come potere di pochi finisce per questa via,
che è la via dell'accumulazione - della parsimonia, cioè dell'astensione dal
consumo; della divisione del lavoro; del reinvestimento del profitto, e
dell'allargamento della popolazione lavoratrice - per conciliarsi con la
ricchezza come benessere materiale di tutti.
3.4. Lavoro comandato e produzione
La lettura della teoria del valore-lavoro comandato come
teoria dello scambio ha posto l'accento sul mutamento di senso, da egualitario
a disegualitario, del termine "comando" nell'espressione
"comando sul lavoro". Si tratta - potremmo dire - di una teoria del
cambiamento, che proietta all'indietro, sullo stadio "rozzo e primitivo",
le caratteristiche proprie della società moderna: lo scambio come comando sul
prodotto del lavoro dell'altro; e, appunto, il comando sul lavoro in senso
stretto, nel mercato del lavoro e nelle fabbriche.
Ma il fatto che Smith insistentemente intenda come sinonimi
il comando sul prodotto del lavoro ed il comando sul lavoro ci dice anche
qualcosa d'altro. Ci induce a concentrare l'attenzione su quel
"lavoro" che è l'oggetto del comando. Quel lavoro che, per Smith, si
configura sempre e comunque come una lotta con la materia, in buona misura
immutabile e immutata dallo stato originario alla società moderna. La lettura
della teoria del valore-lavoro comandato è ora l'opposto della precedente:
vista come teoria della produzione, essa è una teoria della permanenza.
Proietta sulla società moderna l'ombra del "lavoro dell'uomo
isolato":
"In ogni tempo e luogo, uguali quantità di
lavoro si può dire abbiano uguale valore per il lavoratore. Nel suo
stato ordinario di salute, di forza e d'animo, al livello ordinario della sua
arte e della sua destrezza, egli deve sacrificare sempre la stessa quota del
suo riposo, della sua libertà e della sua felicità . . . In ogni tempo
e luogo , è caro ciò che è difficile da raggiungere, ovvero che costa
molto lavoro per procurarselo; ed è a buon mercato ciò che si può avere
facilmente o con pochissimo lavoro."(Ricchezza, p. 35)
La prospettiva, adesso, è cambiata: non è più quella dello
scambista capitalista: di colui che acquista lavoro oggettivato sul mercato
delle merci, o gli operai sul mercato del lavoro. Il punto di vista - lo
dichiara lo stesso Smith - è ora quello del lavoratore: del lavoratore
all'interno del processo di produzione. Direbbe Marx: del lavoratore come
erogatore di lavoro vivo. E' per lui che uguali quantità di lavoro sono sempre
di uguale valore, quale che sia il salario. La fatica e la pena del lavoro, per
lui, non si sono modificate rispetto alla condizione di isolamento e
autosufficienza del lavoratore nello stato originario.
Per Smith, il lavoro è, sempre, la fonte di ogni ricchezza:
il "primo prezzo" con cui sono state comprate in origine tutte le
ricchezze del mondo. E' per questo motivo - perché il lavoro è l'unica fonte
della ricchezza materiale , di cui muta solo l'organizzazione - che
"il lavoro è la sola misura universale del
valore, oltre che la sola precisa, ovvero che è la sola unità di misura per
mezzo della quale possiamo paragonare i valori di diverse merci in
tutti i tempi e in tutti i luoghi" (Ricchezza, p. 38)
Il ragionamento, insomma, ruota tutto attorno alla tesi che,
quale che sia la "ricompensa reale del lavoro", cioè "la
quantità reale di cose necessarie e comode della vita che esso può procurare al
lavoratore" (p. 77) - una ricompensa che è indubbiamente aumentata a causa
della divisione del lavoro - non cambia la "pena del proprio corpo"
(p. 32) nel tempo di lavoro:
"Il prezzo che egli paga deve
essere sempre lo stesso , qualunque sia la
quantità di beni che ne riceve in cambio" (Ricchezza, p. 35)
E' l'intrinseca invariabilità del lavoro come
"sacrificio" nel corso della storia che spiega come per Smith le
condizioni della distribuzione siano parimenti irrilevanti quando si tratta di
individuare la misura appropriata del valore:
"il lavoro misura il valore non solo della parte del
prezzo che si risolve in lavoro, ma anche di quella che si risolve in rendita e
quella che si risolve in profitto" (Ricchezza, p. 51)
Al centro dell'attenzione sono l'uomo come agente attivo della trasformazione della materia ed il lavoro vivo in quanto lavoro naturale. E' soltanto il lavoro l' "oggetto" che l'ineguaglianza può, direttamente o indirettamente, redistribuire tra le classi. Non vi è dunque contraddizione tra, da un lato, l'affermazione di Smith che vede nel salario, nel profitto e nella rendita le tre "fonti originarie" del valore di scambio e, dall'altro lato, la riconduzione della ricchezza al solo lavoro. Ciò che Smith vuole dire è che il valore di scambio, che sappiamo da lui definito essenzialmente come un potere d'acquisto, dipende dai redditi: ma quello che i redditi acquistano dipende a sua volta dal lavoro. Ritroviamo qui la duplicità - ma non, si badi, l'aporia - di Smith: diviso, ancora una volta, tra il principio "sociale" dello scambio e il principio "naturalistico" del lavoro. Non c'è dubbio insomma che, per lui, dietro il "valore di scambio" c'è sempre e comunque il "prezzo reale", il lavoro.
3.5. Ancora sulla divisione del lavoro
L'argomentazione di Smith ha così compiuto una perfetta
rivoluzione su se stessa. La definizione del valore-lavoro comandato,
inconcepibile al di fuori di una prospettiva centrata sullo scambio, nasconde
una più fondamentale teoria del lavoro come necessario ed unico costo reale
della produzione.
Ce lo conferma un ulteriore sguardo all'analisi smithiana
sull'origine della divisione del lavoro. Partita come una rivendicazione del
primato causale dello scambio sul lavoro diviso, approda infine alla tesi di un
primato del lavoro dell'uomo isolato sullo scambio: lo scambio non può
modificare rispetto alla situazione originaria la natura del lavoro, ma
soltanto accrescerne la produttività. Il lavoro diviso,
"sociale", è - insomma - una specificazione del lavoro
individuale. Un risultato tanto più rilevante se si pensa che in Smith
l'indagine sulla divisione del lavoro ha una larga autonomia dalla problematica
del valore, di cui in qualche modo costituisce il presupposto: sia nel senso
che essa è già pienamente formulata in quegli scritti preparatori della Ricchezza
delle Nazioni in cui la teoria del valore-lavoro non fa ancora la sua
comparsa; sia nel senso che anche nell'opera maggiore i capitoli dedicati alla
divisione del lavoro precedono quelli sul valore.
Nelle società primitive dedite alla caccia e alla pesca, i
lavoratori benché vivano in società riproducono la situazione ipotetica del
lavoratore isolato: effettuano tutti lo stesso lavoro e sono adibiti agli
stessi compiti.
Smith spiega in due modi - addirittura nella stessa pagine -
l'emergere della divisione del lavoro nello stadio "rozzo e
primitivo". Comincia con l'osservare che una pur limitata diversità dei
"talenti naturali" è sufficiente a mettere in moto il processo della
specializzazione:
"In una tribù di cacciatori e di pescatori, un
individuo fa per esempio archi e frecce con più rapidità e destrezza degli
altri e li dà spesso ai suoi compagni in cambio di selvaggina o bestiame. Alla
fine si accorgerà che in questo modo può avere più bestiame e
selvaggina di quanto ne avrebbe se fosse andato a caccia di persona, sicché
in base al semplice interesse egoistico la fabbricazione di armi e frecce si
trasformerà nella sua occupazione principale ed egli diventerà una specie di
armaiolo."(Ricchezza, p. 19)
La diversità delle abilità individuali, e perciò la presenza
di un ventaglio di produttività, conduce i lavoratori - in quanto soggetti
"egoisti" - a percepire la convenienza della separazione dei compiti
e della cooperazione nella produzione: dividendosi i compiti allo scopo di
sfruttare le differenze nelle rispettive abilità, essi possono produrre più di
prima. Ogni lavoratore vedrà probabilmente migliorata la propria situazione:
potrà infatti aumentare il consumo rispetto alla situazione di partenza, tanto
del bene alla cui produzione si è specializzato, quanto degli altri beni che
potrà procurarsi dagli altri lavoratori scambiando con loro l'eccedenza sul
proprio autoconsumo.
In questo ragionamento la divisione del lavoro ha la precedenza
sullo scambio, di cui costituisce la condizione. Ma Smith rovescia subito la
sequenza:
"La differenza tra i talenti naturali degli uomini è in
effetti molto minore di quel che si pensa; e in molti casi, le diversissime
inclinazioni che sembrano distinguere in età matura uomini di diverse
professioni sono piuttosto effetto che causa della divisione
del lavoro. La differenza tra due personaggi tanto diversi come un filosofo e
un volgare facchino di strada, per esempio, sembra derivi non tanto
dalla natura quanto dall'abitudine, dal costume e dall'istruzione"(Ricchezza,
p. 19)
Qui la divisione del lavoro è piuttosto vista come un
risultato dell'inclinazione allo scambio. E' perché gli uomini comunicano, è
perché "scambiano" col linguaggio, che sono poi indotti a scambiarsi
i prodotti del proprio lavoro, e dunque ad affinare diverse abilità, che
rompono l'eguaglianza originaria e creano i presupposti della disuguaglianza
storica.
Smith sembra dare la preferenza alla seconda spiegazione,
integrandovi la prima. Coerentemente con la propria filosofia morale, ribadisce
la precedenza della dimensione sociale su quella tecnica nell'attivazione del
processo di crescita materiale della ricchezza. Va rilevato, peraltro, che il
progresso della divisione del lavoro - pur così essenziale nel discorso
smithiano - non modifica in nulla la descrizione che egli dà dei caratteri
della divisione del lavoro né sembra avere conseguenze sulla sua visione del
lavoro. Vi è un preciso parallelismo tra ciò che Smith scrive dell'una e
dell'altro nello "stadio rozzo e primitivo" e nella società
"progredita". In un passo già citato, per esempio, Smith ripete per
la fabbrica la descrizione della divisione del lavoro in un società di caccia e
pesca. In un paese "civile e fiorente, come conseguenza della divisione
del lavoro nelle manifatture:
"Ogni operaio può disporre di una grande quantità
del suo lavoro che supera le sue necessità, e dal momento che tutti gli
altri operai si trovano esattamente nella stessa situazione, è in grado
di scambiare una grande quantità dei suoi beni con una grande quantità dei beni
degli altri, oppure, che è lo stesso, con il prezzo di questa
quantità." (Ricchezza, p. 15)
Ad essere cambiata è dunque solo la scala del processo, che
ora è molto più estesa. Una volta che il capitale si è accumulato, la divisione
del lavoro può essere spinta ai suoi estremi: sia perché è possibile anticipare
un salario ai molti operai parziali, adibendoli a mestieri sempre più
frammentati; sia perché è possibile aumentare le dimensioni delle unità
produttive in conseguenza della frantumazione sempre più spinta del ciclo
lavorativo. Ma il ciclo lavorativo stesso continua ad essere il medesimo del
lavoratore isolato, solo ripartito tra più braccia:
"ciò che è opera di un sol uomo in
uno stadio primitivo della società diviene infatti opera
di parecchi in una società progredita."(Ricchezza, p.
11)
Insomma: il lavoro 'sociale' della manifattura è lo stesso
lavoro dell'individuo isolato: semplicemente, ognuna delle operazioni dello
stadio primitivo è divenuta l'attività unica dell'operaio moderno, sicché essa
è svolta con più destrezza, in minor tempo, e facilitata dalle macchine.
L'identità di natura posta da Smith tra la divisione del
lavoro nelle società primitive e la divisione del lavoro manifatturiera è
rilevante anche per un'altra ragione. Essa consente di equiparare la relazione
tra operai nella fabbrica moderna alla relazione di scambio tra produttori
indipendenti. Vi è qui un collasso tra divisione tecnica e divisione sociale
del lavoro, che - già nel primo capitolo del primo libro della Ricchezza
delle Nazioni - apre la strada al sorprendente isomorfismo tra la
famosa descrizione della fabbrica di spilli (p. 9-10), con la sua necessaria
sequenza di fasi lavorative concatenate, e quella integrazione tra industrie
che deve essere assicurata dal mercato affinché venga prodotto anche il più
umile dei beni di consumo (p. 15-16).
Una confusione che sembra rendere cieco Smith di fronte alla
contraddizione tra, da un lato, l' organizzazione pianificata del lavoro dentro
le unità produttive e, dall'altro lato, la separazione e il conflitto
concorrenziale tra queste ultime sul mercato. Per lui, separazione e
cooperazione governano ugualmente imprese e scambio. La società moderna finisce
con l'essere così ridotta, squarciato il velo del mercato, ad una unica grande
fabbrica. Un quadro che, come vedremo, non poteva non inquietare lo stesso
Smith.
4. Il mercato e i "poveri che lavorano". La
giustificazione storica del capitale.
"Può forse essere il caso di notare che è nello stato
di prosperità, quando la società sta procedendo verso nuove acquisizioni,
piuttosto che quando essa ha acquisito tutta la sua ricchezza, che la
condizione del povero che lavora, cioè della grande massa del popolo, sembra
essere più felice e confortevole. Essa è dura nello stato stazionario, e
miserevole in quello di decadenza. Lo stato di progresso è in realtà lo stato
felice e sano di tutti i diversi ordini della società."
Adam Smith, Ricchezza , p. 81
4.1. Mano invisibile ed equità sociale
Tiriamo le fila del discorso. Gli imprenditori sono mossi
dal movente egoistico del profitto: vogliono divenire ricchi, non accrescere le
capacità produttive del lavoro, né soddisfare meglio i bisogni degli operai. Ciononostante,
è proprio l'impulso a migliorare la propria condizione, accoppiato all'operare
impersonale del mercato, che garantisce che sia questo il risultato delle
loro azioni, al di là delle loro intenzioni. Il "chiaro ed evidente
interesse di ogni individuo" è infatti "un principio
potentissimo" che fa sì che nessuna parte della quota di reddito
risparmiata possa "mai essere impiegata se non per mantenere lavoratori
produttivi", pena "una evidente perdita per colui che la distogliesse
in tal modo dalla sua giusta destinazione"(Ricchezza, p. 333). La
"parsimonia", dunque, tende ad aumentare il numero dei lavoratori. Ed
anche il loro consumo, perché "ciò che ogni anno si risparmia viene
regolarmente consumato", non direttamente ma indirettamente, "dai lavoratori,
dai manifatturieri e dagli artigiani, i quali riproducono con un profitto il
valore del loro consumo annuo"(ivi).
Il ragionamento è chiaro. Il profitto fa della produzione un
mezzo per l'ulteriore accumulazione del capitale; lo stesso consumo dei
lavoratori è un consumo "produttivo" finalizzato coscientemente
all'accrescimento senza limiti del valore, al perseguimento di uno smodato
desiderio di arricchimento. Ma, a sua volta, l'accumulazione è il mezzo per
ottenere il benessere della grande massa della popolazione. La massimizzazione
dell'accumulazione è la via più sicura per rendere massimo il consumo dei
"poveri che lavorano". Il capitalismo realizza così, senza saperlo,
una vera e propria missione civilizzatrice: grazie alla divisione del lavoro,
porta al pieno sviluppo le caratteristiche razionali e comunicative della
cultura umana, e rende massima la crescita della ricchezza; attraverso l'
"inganno" di un risparmio finalizzato all'acquisizione futura di una
ricchezza che non verrà però mai consumata da chi lo effettua, trasforma dei
poveri "oziosi" in lavoratori "operosi"; garantendo la
disuguaglianza con la "giustizia", cioè tutelando giuridicamente la
proprietà dei pochi, li spinge ad una accumulazione accelerata che ha l'effetto
di redistribuire nel modo più favorevole ai molti quanto si è prodotto. E' da
questo punto di vista che si comprende bene il giudizio negativo che Smith dà
della condizione di stato stazionario, che consegue alla caduta del saggio del
profitto.
L'argomentazione smithiana su quella che abbiamo definito la
giustificazione storica del capitale la si ritrova, con poche variazioni, tanto
nella Teoria dei sentimenti morali come nella Ricchezza
delle nazioni. Bastino due passi:
"I ricchi pescano nel mucchio solo ciò che è più
prezioso e più piacevole. Consumano poco più dei poveri, e
nonostante il loro egoismo e la loro rapacità naturali, benché pensino
solo al loro interesse e il solo scopo che si prefiggono dalle
fatiche delle migliaia di persone cui danno lavoro sia la gratificazione dei
propri desideri vani ed insaziabili, essi dividono con i poveri il prodotto di
tutti i loro progressi. Sono portati da una mano invisibile a operare
quasi la stessa distribuzione delle necessità della vita che avrebbe avuto
luogo se la terra fosse stata divisa in parti uguali fra tutti i suoi
abitanti; e così, senza volerlo e senza saperlo, fanno l'interesse della
società e forniscono i mezzi per moltiplicare la specie." (Teoria dei
sentimenti morali, cit. in Michael Ignatieff, I bisogni degli altri,
Il Mulino, Bologna 1986, p. 198)
"La ricompensa reale del lavoro, la
quantità reale di cose necessarie e comode della vita che esso può procurare al
lavoratore, è forse aumentata durante questo secolo in misura maggiore
del suo prezzo in moneta . . . Questo progresso nelle condizioni dei
ceti più bassi del popolo deve essere considerato un vantaggio o un
inconveniente per la società? La risposta sembra a prima vista estremamente
agevole. Servi, lavoratori e operai di diverso genere rappresentano la parte di
gran lunga maggiore di ogni grande società politica. Ma tutto ciò che fa
progredire le condizioni della maggioranza non può mai essere considerato un
inconveniente per l'insieme. Nessuna società può essere florida e
felice se la grande maggioranza dei suoi membri è povera e miserabile.
Oltretutto, è semplice questione di equità il fatto che coloro che nutrono,
vestono e alloggiano la gran massa del popolo debbano avere una quota del
prodotto del loro stesso lavoro tale da essere loro stessi passabilmente ben
nutriti, vestiti e alloggiati (Ricchezza, pp. 77-78)
Sinteticamente - e provocatoriamente, rispetto alla vulgata
di uno Smith apologeta di un capitalismo liberista disposto ad immolare gli
uomini di oggi sull'altare di un benessere futuro; quando invece, se la lettura
che qui è suggerita è corretta, sarebbe vero esattamente l'opposto - potremmo
dire: il profitto come mezzo del salario. Smith, insomma, come il teorico
dell'accumulazione: ma soltanto perché una accumulazione sempre più veloce si
traduce, appunto, in una economia di alti salari e di massima occupazione. O
ancora, Smith come teorico della libera concorrenza: ma soltanto perché la
rivalità e la competizione tra "mercanti", impedendo il monopolio,
rendono minimi i profitti (date le rendite e gli interessi), e danno luogo a
prezzi delle merci i più bassi possibili (alzando dunque, coeteris paribus, la
retribuzione reale del lavoro).
Vediamo il ragionamento sul salario. I comportamenti
coscienti della classe capitalistica e del governo mirano, ineluttabilmente, a
colpire la condizione operaia: "I padroni sono sempre e ovunque in una
specie di tacita ma non per questo meno costante e uniforme coalizione volta a
impedire il rialzo dei salari al di sopra del loro livello attuale"(Ricchezza,
p. 67); d'altro canto, "Tutte le volte che il legislatore cerca di
regolare le controversie fra i padroni e i loro operai, i suoi consiglieri sono
sempre i padroni"(Ricchezza, p. 141). In questa situazione, è l'
"anarchia" del mercato l'unica carta che può - paradossalmente -
giocare a favore dei lavoratori. Tanto più è rapido e variabile il ritmo
dell'accumulazione del capitale, tanto più è elevato il saggio di crescita
della domanda di lavoro; e tanto meno efficaci le coalizioni degli imprenditori,
costretti a farsi concorrenza l'uno con l'altro (Ricchezza, p. 85-6). Di
conseguenza, nel breve periodo il salario fissato dal mercato del lavoro tende
a eccedere il livello naturale, "il più basso compatibile con la natura
umana". Ma, se l'accumulazione procede e lo scarto tra salario di mercato
e salario naturale permane abbastanza a lungo, è convinzione di Smith che la
sussistenza stessa finirà con l'essere trascinata verso l'alto. Il meccanismo
che regola la "produzione di uomini" al variare del salario reale
rispetto alla sua norma, pur continuando ad operare, non è talmente forte da
annullare gli effetti positivi dell'accumulazione.
Peraltro, gli alti salari non sono soltanto l'effetto ma
anche, almeno in parte, la causa del "progresso" economico. Vi è, per
Smith, un vero e proprio circolo virtuoso tra crescita del salario e
aumento della produttività: il maggior costo del lavoro è messo in moto dallo
stesso meccanismo che spinge gli imprenditori ad un approfondimento della
divisione del lavoro; e l'impulso alla divisione del lavoro ha - come sappiamo
- dei benefici effetti di ritorno sulla prosperità di tutta la società:
"Tuttavia la stessa causa che eleva i salari,
cioè l'aumento dei fondi, tende a fare aumentare le capacità produttive del
lavoro e a far sì che una minor quantità di lavoro produca una
maggiore quantità di prodotti. Il proprietario dei fondi che impiegano un gran
numero di lavoratori deve sforzarsi, nel suo stesso interesse ,
di organizzare una divisione e una distribuzione del lavoro tale da metterlo in
grado di produrre quanto più è possibile. Per la stessa ragione egli si sforza
di fornire ai lavoratori le macchine migliori che sia lui stesso sia loro
possono escogitare. Ciò che avviene tra i lavoratori di una particolare casa di
lavoro, avviene per la stessa ragione nell'insieme della società." (Ricchezza,
p. 86)
Con terminologia moderna, potremmo dire che l'aumento della
produttività rende "compatibile" un corrispondente aumento del
salario. Nella stessa logica, non c'è che un passo per intravedere, in un
aumento del salario, il mezzo attraverso cui l'accumulazione riproduce se
stessa, governando il tasso di innovazioni nelle imprese. "L'aumento dei
fondi, mentre innalza i salari, abbassa i profitti" (Ricchezza, p.
87), scrive Smith. Quando la concorrenza è massima, i profitti ordinari saranno
ridotti al minimo possibile (Ricchezza, p. 94). Mentre, infatti,
"il prezzo di monopolio è in ogni occasione il più alto che si possa
ottenere, al contrario, il prezzo naturale è il più basso che
possa essere accettato, se non proprio in ogni occasione, almeno per un periodo
considerevole." (Ricchezza , p. 62).
4.2. I costi della divisione del lavoro
Smith vede dunque nell'accumulazione capitalistica un mezzo
per rendere più felici i lavoratori in quanto consumatori. Non gli sfugge,
però, che le cose stanno ben diversamente se si guarda a ciò che ne è dei
lavoratori in quanto produttori. Riemerge qui, in altra forma, la duplicità di
Smith, teorico dello scambio e teorico del lavoro.
I brani che Smith dedica agli effetti negativi della
divisione del lavoro sono giustamente famosi, ma meritano una rilettura:
"Con lo sviluppo della divisione del lavoro,
l'occupazione della stragrande maggioranza di coloro che vivono di lavoro, cioè
della gran massa del popolo, risulta limitata a poche semplicissime operazioni,
spesso una o due. Ma ciò che forma l'intelligenza della maggioranza
degli uomini è necessariamente la loro occupazione ordinaria.Un uomo che
spenda tutta la sua vita compiendo poche semplici operazioni, i cui effetti
oltretutto sono forse sempre gli stessi, o quasi, non ha nessuna
occasione di applicare la sua intelligenza o di esercitare la sua
inventiva a scoprire nuovi espedienti per superare difficoltà che non
incontra mai . . . La sua destrezza nel suo mestiere specifico sembra
in questo modo acquisita a spese delle sue qualità intellettuali, sociali e
militari. Ma in ogni società progredita e incivilita, questa è la
condizione in cui i poveri che lavorano, cioè la gran massa della popolazione,
devono necessariamente cadere a meno che il governo non si prenda cura
di impedirlo"(Ricchezza, pp. 769-770)
Il "povero che lavora", la cui condizione era
qualificata come la più felice e confortevole quando si analizzavano gli
effetti dell'accumulazione sull'occupazione e sul consumo, è ora un soggetto
senza virtù civiche o marziali, istupidito ed impoverito nelle sue capacità da
quella stessa divisione del lavoro che rende florida la società. Riemergono qui
accenti rousseauiani: nelle
"società barbare . . . le svariate occupazioni di ogni
uomo lo costringono a esercitare le sue capacità e a inventare espedienti per
superare le difficoltà che incontra continuamente. L'inventiva è mantenuta viva
e la mente non è lasciata cadere in quella sonnolenta stupidità che in
una società civile, sembra ottenebrare l'intelligenza di quasi tutti i ceti
inferiori del popolo. In queste cosiddette società barbare . . . ogni uomo
è un guerriero ed è in una certa misura anche un uomo di stato, e può formarsi
un discreto giudizio sull'interesse della società e sulla condotta di coloro
che lo governano."(Ricchezza, p. 770)
Certamente, queste note pessimistiche non sono sufficienti a
rovesciare il giudizio che Smith aveva formulato sulla divisione del lavoro.
Nelle società moderne, è vero, la ricchezza è ottenuta a spese della virtù. Ma,
se è vero che nelle società primitive vi è
"molta varietà nelle occupazioni di ogni individuo, non
c'è molta varietà in quelle della società nel suo complesso . . . Al contrario,
in uno stadio avanzato della civiltà, sebbene ci sia poca varietà nelle
occupazioni della maggior parte degli individui, c'è una varietà quasi
infinita in quelle del complesso della società." (Ricchezza, p.
771)
Il ragionamento è chiaro. La divisione del lavoro comporta
un costo elevato per gli individui appartenenti alle classi più povere, cioè
per la gran massa della popolazione. Più precisamente, si tratta di una vera e
propria caduta nell'eteronomia, nei processi di lavoro e nella società
politica. Un destino senza ritorno, si potrebbe dire, perché la fabbrica
manifatturiera costruisce un nuovo tipo d'uomo, integrato agli altri nel
consumo ma ignorante ed incapace di giudizio. Ma ciò che perde l'individuo lo
guadagna, con l'interesse, la società. Aumentando le attività, aumentano
le abilità, e dunque le capacità del corpo sociale collettivo. Può goderne
quella frazione ristretta della popolazione che ha mantenuto un qualche tenue
legame con la condizione originaria, in cui "ognuno fa, o è capace di
fare, quasi tutto ciò che chiunque altro fa, o è capace di fare". Si
tratta dei "filosofi", la cui collocazione particolare nella
divisione del lavoro era stata sottolineata già nel primo capitolo del libro:
la loro specificità consiste non "nel fare qualche cosa, ma nell'osservare
ogni cosa" (p.14). E' a loro che deve riferirsi l'osservazione di
Smith secondo cui la moltiplicazione delle mansioni e la frantumazione del
lavoro "presentano una varietà quasi infinita di oggetti alla
contemplazione di quei pochi che, non essendo essi stessi impegnati in nessuna
occupazione particolare, hanno tempo libero e predisposizione per esaminare le
occupazioni degli altri." (Ricchezza , p. 771) Aumenta dunque
l'intelligenza della società: e con essa il numero di invenzioni e innovazioni,
dal momento che è dall'osservare ogni cosa che può svilupparsi la facoltà
"di combinare e unificare le possibilità insite negli oggetti più
dissimili e lontani fra loro" (Ricchezza , p. 15).
La stupidità - se non addirittura l'infelicità -
dell'individuo è il prezzo da pagare per allentare il vincolo della scarsità, e
per consentire ai pochi un' "intelligenza progredita e raffinata" (p.
771). Il discorso di Smith assume qui un accento spietatamente realistico:
amaro, certamente, ma che di nuovo non mi sentirei di definire
apologetico. Non tanto per la cura, in verità un po' superficiale, che
l'autore scozzese propone: un intervento statale che imponga una istruzione di
base alle classi più povere sarebbe poco più di un lenitivo, per un processo
dalle tinte così fosche. E nemmeno per il pessimismo che conduce Smith a
concludere che, in ogni caso, "tutti i tratti più nobili del carattere
umano possono essere in gran parte cancellati ed estinti nella gran massa del
popolo" (Ricchezza, p. 771): un pessimismo troppo frammisto alla
rivendicazione con cui viene, a ragione o a torto, lamentata l'esclusione della
propria corporazione, dei "filosofi", dalle leve del comando ("a
meno che a questi pochi non capiti di essere collocati in situazioni molto
particolari, le loro grandi capacità, per quanto onorevoli per loro, possono
contribuire ben poco al buon governo o alla felicità della società." (Ricchezza ,
p. 771).
Quello che più conta è che nella Ricchezza delle
Nazioni l'abbrutimento della classe lavoratrice appare non come un
destino di natura ma come un risultato storico: di una storia, per di
più, che sarebbe potuta svolgersi in tutt'altro modo. Il capitalismo
della "rivoluzione industriale" non è insomma per Smith il capitalismo
"naturale", quel capitalismo che si sarebbe potuto realizzare con
altre leggi ed altre istituzioni. E' certamente, sotto gli ordinamenti storici
dell'Europa a lui contemporanea, il migliore dei mondi possibili: non però il
mondo in cui vorrebbe vivere, né quello che, con altri presupposti e con una
piena libertà commerciale, avrebbe potuto aver luogo.
E' con alcune citazioni da uno Smith così inconsueto e poco
frequentato, almeno dagli economisti - uno Smith il cui peccato non è
l'apologia ma semmai l'utopismo - che chiuderò la parte di questo saggio
dedicata all'autore scozzese.
4.3. Innaturalità del capitale
E' nella natura delle cose che la sussistenza preceda la
"comodità e il lusso", e dunque "l'attività che procura la prima
deve necessariamente aver preceduto quella che fornisce i secondi"(Ricchezza,
p. 374). La sequenza naturale dello sviluppo economico e del progresso della
divisione del lavoro dovrebbe dunque andare, per Smith, dal "miglioramento
e dalla coltivazione della terra" - che determina la creazione di un
sovrappiù in agricoltura il quale a sua volta garantisce alla città cibo e
materie prime - al conseguente aumento della domanda di manufatti, che stimola
la produzione nelle città, alla ricerca di sbocchi all' estero:
"Quindi, secondo il corso naturale delle cose,
la maggior parte del capitale di ogni società che comincia a formarsi è diretta
prima all'agricoltura, poi alle manifatture, e infine al commercio estero . . .
Ma per quanto quest'ordine naturale delle cose debba aver avuto luogo
in qualche misura in ogni società, in tutti i moderni stati europei esso è
stato sotto molti aspetti completamente rovesciato. Il commercio estero di
alcune delle loro città vi ha introdotto manifatture più raffinate, cioè quelle
adatte per la vendita in luoghi remoti e le manifatture e il commercio estero
insieme hanno dato occasione ai principali miglioramenti dell'agricoltura"
(Ricchezza, p. 377)
"Quest'ordine di cose innaturale
e retrogrado": così Smith definisce la sequenza storicamente
data, quella per cui le manifatture invece di essere figlie dell'agricoltura
sono figlie del commercio estero.
Non è questo il luogo per affrontare alcune questioni,
peraltro di notevole interesse, suggerite dal modo con cui Smith sviluppa la
sua argomentazione. Quale, per esempio, il senso da darsi alla sua "storia
congetturale", che fa delle città il luogo primo di quella emancipazione
dal dominio dei grandi proprietari fondiari che poi si estende alla campagna,
in forza del graduale ed impersonale diffondersi dello scambio. O quale,
ancora, il riconoscimento dell'esistenza di vie alternative
all'industrializzazione: quella che è stata definita "semi-naturale",
che pur attivata dal commercio internazionale vede uno sviluppo
dell'agricoltura precedente lo sviluppo delle manifatture secondo la sequenza
commercio estero-agricoltura-manifatture, ed è dunque incentrata su un
equilibrio tra settori che salvaguarda il lavoro indipendente tanto nelle
campagne quanto nelle città; e quella "storica", sbilanciata a favore
delle fabbriche e delle concentrazioni operaie secondo la sequenza commercio
estero-manifattura-agricoltura, che finirà con il prevalere. Un contrasto che
si riflette in quello tra crescita "proporzionale", quando le città
si sviluppano secondo le capacità di estrazione di sovrappiù della campagna che
le circonda, e crescita "non proporzionale", quando le manifatture si
liberano dal vincolo costituito dalla domanda interna per inseguire quella
estera.
Vorrei piuttosto limitarmi a ricordare gli eroi di questo
capitalismo naturale di Smith: l'agricoltore proprietario e l'artigiano
indipendente. E' indubbio da che parte stiano le simpatie di Smith; come è
indubbio che l'inedito capitalismo, agrario e di libera concorrenza, che
ha in mente manterrebbe, a suo parere, i tratti positivi dell'efficienza
produttiva e dell'allocazione ottima delle risorse, senza i tratti negativi
della divisione del lavoro e di una eccessiva mobilità del capitale.
Dai grandi proprietari terrieri non ci si può aspettare
grandi miglioramenti, dediti come sono al consumo di lusso; ma meno ancora da
chi lavora alle loro dipendenze ("una persona che non può acquisire
proprietà, non può avere altro interesse oltre quello di mangiare il più
possibile e lavorare il meno possibile": Ricchezza, p. 382):
"Un piccolo proprietario, però, che conosce
ogni palmo del suo piccolo terreno, che lo guarda tutto con l'affetto che la
proprietà, e specialmente quella piccola, naturalmente ispira, e che per tale
motivo trae piacere non solo a coltivarlo, ma anche ad adornarlo, è in
generale il più industrioso, il più intelligente e
il più fortunato fra tutti coloro che attendono ad apportare
miglioramenti alla terra"(Ricchezza, p. 410)
La premessa del giudizio di Smith è che si dia una maggiore
produttività del lavoro agricolo, in quanto quest'ultimo è favorito dalla
collaborazione della natura. Di norma, dunque, la redditività dell'agricoltura
è superiore a quella delle manifatture, e lo sviluppo delle campagne dà il via
a quello delle città. Se non vi fossero retaggi storici o vincoli istituzionali
a deviare il corso delle cose, lo stesso meccanismo concorrenziale dovrebbe
imporre uno sviluppo trainato dal capitale agrario. La peculiare collocazione
geografica dell'Inghilterra, che ne favorisce i rapporti con l'estero,
giustifica che la crescita sia stata qui attivata dalle esportazioni, ma non
che l'inversione della sequenza naturale sia così completa: il commercio
internazionale avrebbe potuto comunque privilegiare la campagna prima della
città, mentre invece è avvenuto proprio l'opposto.
Un elemento che certamente concorre nella valutazione
positiva che Smith dà di una crescita caratterizzata da un primato
dell'agricoltura sulla manifattura, di questa possibilità non percorsa dallo
sviluppo economico, è che il capitale del proprietario terriero "è fissatonei
miglioramenti della sua terra"(Ricchezza, p. 375) e, di
conseguenza, è "il più sicuro, per quanto lo consente la natura
delle vicende umane". Al contrario, il "mercante non è
necessariamente cittadino di un particolare paese", e "il
capitale che viene acquisito da un paese con il commercio e le manifatture
costituisce un possesso molto precario e incerto." (Ricchezza,
p. 413) Ed ancora: mentre i mercanti e i manifatturieri sono mossi da
"bassa rapacità" e da uno "spirito di monopolio", e dunque
"il loro interesse è sempre direttamente opposto a quello della gran massa
della popolazione" (Ricchezza, p. 483), "i gentiluomini di
campagna e gli agricoltori sono, a loro grande onore, tra tutta la popolazione
i meno soggetti al meschino spirito del monopolio".
Né va trascurato che per Smith il lavoro dell'agricoltura è
per sua natura meno soggetto alla suddivisione del lavoro (Ricchezza,
p.11): se questa circostanza di per sé rallenta l'aumento della produttività
nelle campagne, è certo però che il lavoratore agricolo è appunto per ciò più
tutelato dalle conseguenze nefaste della specializzazione:
"Al comune aratore, generalmente considerato un
campione di stupidità e di ignoranza, è raro manchino questo giudizio e quest'
avvedutezza. Certamente egli è meno pratico di relazioni sociali di quanto lo
sia il meccanico che vive in città, la sua voce e il suo linguaggio sono più
incolti e più difficili da capire per coloro che non vi sono abituati, ma il
suo intelletto, essendo abituato a considerare una grande varietà di cose, è in
genere molto superiore a quello di coloro la cui attenzione è interamente
occupata, da mattina a sera, nel fare una o due operazioni semplicissime"(Ricchezza,
p. 127)
Lo sviluppo della città a rimorchio della campagna ha un
ultimo vantaggio. Si tratta di un processo caratterizzato non dalla presenza di
grandi opifici e dall'impiego di lavoro salariato ma dalla predominanza nei
centri urbani del lavoro artigiano indipendente. Una situazione in cui virtù e
ricchezza sembrano, finalmente, poter andare di concerto:
"Nulla può essere più assurdo, comunque,
dell'immaginare che gli uomini in generale lavorino meno quando lavorino per se
stessi che quando lavorino per altri. Un bravo operaio indipendente sarà in
genere più attivo anche di un giornaliero che lavori a
cottimo. L'uno gode dell'intero prodotto della sua attività, mentre
l'altro lo spartisce col suo padrone. L'uno, nella sua situazione
di isolamento e di indipendenza, è meno soggetto alle tentazioni delle
cattive compagnie che nelle grandi manifatture rovinano tanto spesso i costumi
dell'altro. La superiorità dell'operaio indipendente sui servi pagati a mese o
ad anno, i salari e il mantenimento dei quali restano identici sia che facciano
poco o molto, è probabilmente ancora maggiore." (Ricchezza, p.
83-4)
Ritroviamo uno Smith diviso. La storia realizzata, il
capitalismo realmente esistente, hanno al loro attivo non solo la crescita
materiale, ma anche la creazione di un ordine politico fondato sull'ordine e il
buon governo. E' grazie allo sviluppo "distorto" delle città e delle
manifatture che si è passati dalla dipendenza servile e dalla soggezione
personale alla dipendenza dal mercato ed alla libertà individuale. Il
giudizio che Smith dà è inequivocabilmente positivo, anche se vede i costi del
processo; ed anche se non si stanca di sottolineare la possibilità di
accelerare l'accumulazione rimuovendo "i cento inconsulti ostacoli con cui
la follia delle leggi umane" (Ricchezza, p. 532) intralcia la
spontaneità delle leggi di mercato. Gli ordinamenti politici possono ormai solo
rallentare ma non arrestare il cammino verso la ricchezza e il progresso: quel
cammino che è retto dai "principi potentissimi" dell'egoismo e
dell'inclinazione allo scambio; e che è certo nella sua direzione anche se non
nella sua velocità, una volta garantite libertà personale e sicurezza della
proprietà.
Ma Smith non nasconde l'esistenza di un'altra storia, di una
storia possibile. Una storia che, come rivela l'ultima citazione, percorrendo,
parzialmente o integralmente, la sequenza naturale dello sviluppo avrebbe
consentito di far permanere nella "società commerciale" non solo, per
così dire, il lato negativo ma anche quello positivo del "lavoro dell'uomo
isolato". Non solo la pena e il sacrificio del lavoro, ma anche
l'autonomia e l'indipendenza personale: massima nel caso dell'agricoltore
piccolo proprietario, comunque superiore a quella dei "poveri che
lavorano" nel caso dell'artigiano indipendente.
Una storia non percorsa dall'Europa, ma che potrebbe essere
il presente ed il futuro di quello che è il vero modello di Smith: le nuove
colonie, l'America:
"Nelle nostre colonie americane, dove la terra incolta
si può ancora avere a buone condizioni, non si è stabilita in nessuna città
nessuna manifattura per la vendita in luoghi lontani. Quando nell'America del
Nord un artigiano ha acquisito un po' più dei fondi sufficienti a condurre la
sua attività rifornendo la campagna vicina, egli con quei fondi non tenta di
fondare una manifattura per la vendita in luoghi più remoti ma li impiega
invece nell'acquisto e nel miglioramento della terra incolta. Da artigiano
diventa piantatore, e né gli alti salari, né la facile sussistenza che quel
paese concede agli artigiani possono indurlo a lavorare per altri invece che
per se stesso. Egli sente che un artigiano è il servo del suo
cliente , dal quale trae la propria sussistenza, e che un
piantatore che coltiva la propria terra e trae la sua necessaria sussistenza
dal lavoro della propria famiglia è in effetti un padrone ed è indipendente da
tutto il mondo ." (Ricchezza, p. 376)
5. Cambiare la natura umana. John Stuart Mill e John
Maynard Keynes oltre la passione per il denaro.
"nel contemplare ogni movimento di progresso, non
illimitato nella sua natura, la mente non è soddisfatta soltanto dal fatto di
tracciare le leggi del suo movimento; non può infatti fare a meno di porsi
l'altra domanda: a quale fine? Verso quale punto tende in definitiva la società
con il suo progresso produttivo? Quando il progresso giunge al termine, in
quali condizioni ci si deve attendere che lasci il genere umano?"
John Stuart Mill, Principi di economia politica ,
Utet, Torino 1983, p. 997
5.1. Smith smembrato: ricardiani e neoclassici.
La conciliazione che Smith opera tra le due visioni
dell'accumulazione che attraversano la sua opera - quella di un processo
autoreferenziale per cui la produzione è fine a se stessa, e quella di una
produzione che ha per risultato il consumo sempre più ricco di un numero crescente
di lavoratori - è una conciliazione possibile solo sulla base della sua
filosofia etica e della sua filosofia della storia. Il suo schema teorico si
regge infatti tutto sull'ipotesi che l'egoismo che spinge i capitalisti alla
massimizzazione del profitto sia un benefico "inganno" che la Natura
ha ordito per realizzare il suo ordine: quell'inganno che, mettendo in moto il
meccanismo della divisione del lavoro, e dispiegando al massimo grado il
principio sociale dello scambio, fa della produzione per la produzione il mezzo
della massimizzazione del benessere. E' la medesima ipotesi che fa sì che non
appaia immediatamente contraddittorio il fatto che il fine storico, il consumo
dei "poveri che lavorano", sia nel processo accumulativo nient'altro
che un mezzo del suo mezzo. Un consumo "produttivo", necessario al
fine dell'accrescimento del valore.
Il pensiero economico successivo, abbandonando i presupposti
filosofici di Smith, si scinderà in due tronconi. Da un lato, abbiamo il filone
classico-ricardiano che, radicalizzando la riduzione del lavoratore a mezzo di
produzione, vedrà nel processo capitalistico un processo circolare, di
"produzione di merci a mezzo di merci". Dall'altro lato, il filone
neoclassico, che ricomporrà le due massimizzazioni smithiane - quella
"individualistica" del profitto, e quella "sistemica" del
consumo dei "poveri" - sotto il cappello di una universale
massimizzazione dell'utilità di un generico agente economico; ma quest'ultima a
sua volta, in quanto massimizzazione del consumo mediante l'impiego efficiente
di risorse scarse disponibili per usi alternativi, verrà intesa come
nient'altro che l'espressione particolare di un più generale ed astorico
aspetto della condotta umana, in quanto condotta razionale, cioè della massimizzazione
di una funzione obiettivo sotto vincolo.
In entrambi i casi, perde di senso l'argomentazione
smithiana sulla giustificazione storica del capitale. Nel caso di Ricardo, per
l'insensatezza stessa di una interrogazione sulla qualità di un processo che ha
la sua essenza nella riduzione di tutto a quantità. Nel caso dei neoclassici,
per la naturalizzazione e universalizzazione della razionalità calcolante
tipica del capitalismo. L'economia politica - ridotta ad economica, e dunque a
teoria della scelta - può ormai descrivere qualsiasi contesto istituzionale e
qualsiasi forma di agire, sicché finisce con il dissolversi l'oggetto stesso
del giudizio storico di Smith, la "società commerciale".
Sarebbe però interessante invertire la prospettiva, e
chiedersi quale giudizio dare di questi sviluppi teorici prendendo come punto
di partenza il discorso smithiano sulla missione civilizzatrice del capitale.
Ci si potrebbe chiedere, per esempio, quale conclusione trarre quando con
Ricardo si dimostra che l'accumulazione può procedere indisturbata pur in
presenza di una riduzione tanto dei consumi che dell'occupazione dei
lavoratori: se, insomma, una autonomizzazione dell'accumulazione dai
"poveri che lavorano" non segnali un esaurirsi della funzione storica
svolta dal modo di produzione capitalistico. Ci si potrebbe chiedere, ancora,
che contributo alla conoscenza dia una teoria come quella neoclassica incapace
di distinguere, come invece Smith era in grado di fare, tra realtà moderna e
realtà premoderne, attribuendo solo alla prima l'attributo di
"società" in senso proprio.
Ci si potrebbe chiedere, insomma, se l'impostazione
ricardiana e quella neoclassica non escano dalla filosofia della storia
smithiana solo perché - in modi certamente opposti - fanno del capitale un
pezzo di natura. Solo perché, dunque, si reggono implicitamente su filosofie
della storia altrettanto arbitrarie di quella: che semplicemente negano che
possano esistere storie diverse; e, per questo, che mirano entrambe a fare
dell' economia una scienza "esatta" come la geometria o la
fisica.
5.2. Lo stato stazionario: John Stuart Mill.
L'argomentazione smithiana sulla giustificazione storica del
capitale non scompare però totalmente dal discorso economico. Essa riappare
ovviamente, nella forma che vedremo, nell'opera di Marx. Ma fa anche la sua
comparsa in altri due momenti di svolta cruciali della storia d'Europa:
l'esplosione rivoluzionaria del 1848, e la crisi successiva alla "grande
guerra".
Nel libro quarto dei Principi di economia politica
di John Stuart Mill, dedicato all' "Influenza del progresso su produzione
e distribuzione", si incontrano due capitoli successivi, strettamente
intrecciati e da leggere insieme: il capitolo VI, molto citato, dedicato allo
stato stazionario; ed il capitolo VII, meno frequentato, che discute "del
probabile avvenire delle classi lavoratrici". La ripresa di temi smithiani
è puntuale, ma la prospettiva è ora cambiata. Mill riconosce al capitale il
ruolo di momento necessario del progresso: ritiene però che alla fase attuale,
caratterizzata dall'egoismo e dal primato della produzione, possa seguirne
un'altra che sostituisca a questo "falso ideale" del genere umano
fini più desiderabili:
"Confesso che non mi piace l'ideale di vita di coloro
che pensano che la condizione normale degli uomini sia quella di una lotta per
andare avanti; che l'urtarsi e lo spingersi gli uni con gli altri,
che rappresenta il modello esistente della vita sociale, sia
la sorte maggiormente desiderabile per il genere umano, e non piuttosto uno
dei più tristi sintomi di una fase del processo produttivo. Esso può
indubbiamente rappresentare una fase necessaria del progresso
della civiltà, e quelle nazioni europee che finora hanno avuto la fortuna di
esserne quasi esenti può darsi che la debbano attraversare. E' un incidente di
sviluppo e non un segno di decadenza . . . Ma non è comunque un genere di
perfezione sociale che i filantropi futuri possano desiderare di vedere
realizzato. Molto più auspicabile è invece, finché la ricchezza continuerà a
rappresentare il potere, e il diventare più ricchi possibile continuerà ad
essere oggetto dell'ambizione universale, che la via per giungere alla
ricchezza sia aperta a tutti, senza favori o parzialità. Ma la condizione
migliore per la natura umana è quella per cui, mentre nessuno è
povero, nessuno desidera diventare più ricco, né deve temere di essere respinto
indietro dagli sforzi compiuti dagli altri per avanzare." (Principi,
pp. 999-1000)
"Come primo passo da uno stadio
semplicemente animale a uno stato umano, dallo sconsiderato abbandono agli
istinti bruti alla prudente preveggenza e al dominio di se stessi, questa
condizione morale può essere guardata senza dispiacere. Ma se si desidera lo
sviluppo dello spirito pubblico, di sentimenti generosi,
o della vera giustizia e della vera eguaglianza, è
l'associazione e non l'isolamento degli interessi, la scuola alla
quale queste virtù si possono sviluppare. Lo scopo del
processo dovrebbe essere non soltanto di porre gli esseri umani in condizioni
nelle quali essi siano in grado di fare a meno gli uni degli altri, ma di
consentire loro di lavorare con gli altri e per
gli altri in rapporti che non implichino una dipendenza." (Principi,
p. 1015).
Per Mill, dunque, il capitalismo è la fase necessaria di
transizione da uno stato primitivo e "animale" ad uno stato veramente
umano". Nello stato primitivo la cooperazione, se c'è, è legata alla
soggezione personale. Anche nelle condizioni moderne il lavoro sotto padrone
costringe gli operai ad abusi che la crescente educazione culturale e
politica - frutto della stessa associazione coatta nelle fabbriche -
renderà sempre meno praticabili. Mill vede con favore che i lavoratori prendano
nelle proprie mani il loro destino, e vogliano passare dal lavoro salariato al lavoro
cooperativo; ma l'associazione tra eguali tenderà a prevalere non soltanto
nella fabbrica, ma anche nella politica come nella famiglia.
L'evoluzione spontanea ed inintenzionale dell'economia è,
insomma, un processo che ha come fine la realizzazione di una situazione
opposta. Compie una autentica "rivoluzione morale" (Principi,
p. 1043), ed una incruenta e graduale rivoluzione politica: sostituisce
all'individuo egoista l'individuo altruista; al soggetto dipendente il soggetto
indipendente. Fa di tutti degli "esseri razionali" (Principi,
p. 1009): in grado di scegliere la cooperazione, e non condannati invece ad una
competizione tra agenti isolati, che verrà piuttosto mutata in "amichevole
emulazione"(Principi, p.1043). La mano invisibile, si potrebbe
dire, crea le condizioni di una società fondata sul consenso cosciente.
L'evoluzione cede il passo al contratto.
Smith è mantenuto e rovesciato. Il dualismo etico di egoismo
e simpatia diviene successione storica. "La sproporzionata importanza
attribuita al semplice aumento della produzione", che è in Smith il mezzo
per una generalizzazione passabilmente equa del benessere, diviene solo lo
strumento per raggiungere quel livello della ricchezza materiale che è la
precondizione per una migliore distribuzione e per una trasformazione della
natura umana:
"Finché le menti sono rozze esse richiedono stimoli
rozzi, ed è bene che li abbiano. Intanto però quelli che non accettano
l'attuale stadio iniziale del progresso umano come il suo modello definitivo,
possono essere scusati se rimangono relativamente indifferenti al tipo di
progresso economico che suscita di solito le congratulazioni dei politici; il
semplice incremento della produzione e della accumulazione."(Principi,
p. 1000)
Sullo sfondo di questa visione, non stupisce che il giudizio
di Mill sullo "stato stazionario" sia, diversamente che in Smith e
negli altri classici, improntato all'ottimismo. Mentre per "gli economisti
delle ultime generazioni", scrive Mill, lo stato stazionario è
"una prospettiva spiacevole e scoraggiante, dal momento
che il tono e la tendenza delle loro speculazioni sono quelli di identificare
tutto ciò che è economicamente desiderabile con lo stato progressivo . . . [io]
sono propenso piuttosto a credere che, nel complesso, esso rappresenterebbe un
considerevole miglioramento rispetto alle nostre condizioni attuali." (Principi,
p. 999)
La riduzione del tasso di crescita della produzione, se
accompagnata alla riduzione della crescita della popolazione, non
significherebbe per nulla l'esaurirsi del progresso umano. L'aumento assoluto
della produzione materiale cederebbe semmai il passo allo sviluppo culturale ed
al perfezionamento dell' "arte della vita"(p. 1002). L'industria
continuerebbe certamente ad essere retta da leggi astoriche ed immutabili; ma,
a differenza che nella situazione attuale, le innovazioni
"produrrebbero il loro effetto legittimo, quello
di abbreviare il lavoro. Finora è dubbio se tutte le invenzioni
meccaniche compiute sino a questo punto abbiano alleggerito la fatica
quotidiana dell'uomo. Esse hanno piuttosto consentito a una maggiore
popolazione di vivere la stessa vita di schiavitù e di prigionia, e a un
maggior numero di industriali e altri di accumulare fortune. Esse hanno
indubbiamente accresciuto gli agi delle classi medie, ma non hanno ancora
cominciato a operare quei grandi mutamenti nel destino umano che per loro
natura sono destinati a compiere. Soltanto quando accanto a giuste istituzioni,
l'accrescimento del genere umano sarà posto deliberatamente sotto la guida di
una saggia previdenza, le conquiste sui poteri della natura compiute
dall'intelletto e dall'energia degli scienziati potranno diventare il
retaggio comune della specie umana, e il mezzo per migliorare ed elevare la
sorte dell'umanità ."( Principi, p. 1003).
Mill spera che l'umanità scelga lo stato stazionario prima
di esservi costretta dal destino che le assegna la ineluttabile caduta del
saggio del profitto. In realtà, nonostante questa sua affermazione, la sua
posizione non può non risultare intimamente contraddittoria a meno di legarsi
ad una evoluzionismo meccanicistico.
Paladino di una visione che separa le leggi ferree della
produzione dalle leggi storiche della distribuzione, Mill non dispone di
argomentazioni teoriche a favore della auspicata trasformazione della natura
umana: deve ancorare quest'ultima, di necessità, alla dinamica deterministica
della produzione. Alla luce della sua separazione dicotomica di produzione e
distribuzione rimane infatti misterioso cosa potrebbe originare una metamorfosi
così radicale, pur nella sua gradualità, del carattere umano quale egli delinea
nel suo "ideale del futuro" - se non intervenisse ad imporla,
appunto, il corso stesso delle cose; in questo modo ribadendo però, contro le
intenzioni, un permanente primato dell'evoluzione materiale sul progresso
culturale.
E' per la stessa ragione che Mill deve limitare gli effetti
del processo all'ampliamento del tempo di non lavoro: cioè, a ben vedere,
ancora ad una misura meramente redistributiva. La sua prospettiva di una
riduzione del primato dell'economico si configura dunque, coerentemente,
soltanto nei termini di una più equa ripartizione e, al limite, di un'uscita
dal lavoro.
Il solo altro sostegno della sua visione di società
dell'avvenire - l'unico che nel suo sistema giustificherebbe la speranza che
"i nostri discendenti si accontenteranno di essere in uno stato
stazionario molto prima di trovarsi costretti ad esso dalla necessità" (Principi,
p. 1002) - avrebbe potuto essere il compimento del progetto, da lui lungamente
accarezzato, di costruire una scienza del carattere umano, l'etologia.
Individuate le leggi generali della formazione e del mutamento del carattere
umano, si sarebbe anche mostrato come la trasformazione potesse essere il
prodotto congiunto delle condizioni esterne e della volontà degli individui.
Ma, come è noto, quel libro Mill non riuscì a scriverlo mai.
5.3. Il doppio inganno è rivelato: John Maynard
Keynes.
Ben maggiore consapevolezza di queste difficoltà ha Keynes
quando, tra le due guerre mondiali, riproporrà l'utopia di Mill.
Come Smith e Mill, Keynes ritiene che il capitalismo
presupponga condizioni culturali (oltre che istituzionali) particolari,
decadute le quali esso è destinato ad entrare in crisi. A differenza dell'uno e
dell'altro, sottolinea però che l'avverarsi di quelle condizioni non solo è
stato in grande misura casuale, ma ha dato luogo ad un sistema sociale ed
economico instabile (contro Smith), ed il cui esaurirsi non significa di per sé
un indolore ed automatico passaggio ad uno stadio più alto dell'evoluzione
umana (contro Mill).
Appena terminata la "grande guerra", nel paragrafo
delle Conseguenze economiche della pace intitolato "La
psicologia della società", Keynes riprende l'immagine di Smith che vede nella
"parsimonia" un inganno ordito a danno dei singoli ma favorevole alla
società. E, come Smith, individua nella traduzione del risparmio in
investimento e nella conseguente, sempre maggiore, soddisfazione dei bisogni
fondamentali la giustificazione storica dell'ineguaglianza e del capitale.
La corrispondenza con i temi smithiani è talmente
pronunciata che vale la pena di citare ampi brani:
"L'Europa [dopo il 1870 e prima della guerra] era
socialmente ed economicamente organizzata in modo da permettere la massima
accumulazione di capitale. Mentre vi era un certo continuo miglioramento nelle
condizioni quotidiane di vita della massa della popolazione, la società era
organizzata in guisa che una gran parte del reddito di nuova formazione veniva
a cadere sotto il controllo della classe che era meno incline a consumarlo . .
. era precisamente la 'ineguaglianza' di distribuzione della ricchezza
che rendeva possibili quelle vaste accumulazioni di ricchezza fissa e di
sviluppo di capitali che distinguono quel periodo da ogni altro. E
qui sta, in fatto, la principale giustificazione del sistema
capitalistico. Se i ricchi avessero speso la loro ricchezza di nuova
formazione nei godimenti personali, il mondo già da un pezzo avrebbe trovato
questo sistema intollerabile. Ma, come api, essi risparmiavano ed accumulavano
a vantaggio anche della comunità, perché essi stesso avevano di mira fini più
ristretti. . . . Lo sviluppo di questo rimarchevole sistema dipendeva perciò da
un doppio inganno. Da un lato le classi lavoratrici accettavano,
per ignoranza o per impotenza, o erano costrette, persuase o indotte dal
costume, dalla convenzione o dall'autorità e dal ben regolato ordine sociale,
ad accettare una situazione per la quale esse potevano chiamare propria una ben
piccola parte della torta che esse stesse e la natura e i capitalisti avevano
cooperato a produrre. dall'altro lato era consentito ai capitalisti di
considerare propria la miglior parte della torta ed essi erano teoricamente
liberi di consumarla, nella tacita, sottintesa condizione che in pratica ne
avrebbero consumato una ben piccola porzione. Il dovere di 'risparmiare'
divenne celebrata virtù e l'ingrossamento della torta oggetto di vera religione
. . . Ciò dicendo io non riprovo necessariamente il metodo di quella
generazione. Negli inconsci recessi del suo essere la società sapeva
quello che si faceva." (Le conseguenze economiche della pace,
Rosenberg & Sellier, Torino 1983, pp. 34-35)
Il soggetto è dunque la società, ed i comportamenti degli
individui sono - di nuovo come in Smith - dettati dalla propria collocazione di
classe determinati dalle leggi di riproduzione di quel sistema. Il mezzo è il
capitale; fini sono il superamento della scarsità, ed il passaggio ad una
economia dell'abbondanza e dell'ozio:
"forse sarebbe venuto un giorno in cui ce ne
sarebbe stato finalmente abbastanza per tutti e la posterità avrebbe
potuto cominciare a godere il frutto delle 'nostre'
fatiche"(Conseguenze, p. 36)
Il futuro è però incerto. Il processo può incepparsi prima di
aver raggiunto il suo termine: la "torta" può essere insufficiente
per una eccessiva crescita della popolazione, come in Mill; oppure, come è
avvenuto, a causa di una guerra. Ma l'effetto principale della guerra non è
stato tanto materiale, quanto culturale: ha dissolto quelle
"condizioni psicologiche instabili, che non
si possono riprodurre . . La guerra ha rivelato a tutti la possibilità del
consumo immediato ed a molti la vanità dell'astinenza. Così l'inganno è
rivelato; le classi lavoratrici possono non essere più disposte a così
larghe rinunzie e le classi capitalistiche, non più fiduciose nel futuro,
possono avere voglia di godere in modo più completo la loro libertà di consumo
fin quando essa duri, precipitando così l'ora della sua confisca." (Conseguenze,
p. 36)
La questione sarà affrontata di nuovo nel 1930, nelle
"Prospettive economiche dei nostri nipoti". Questa volta, ad essere
impressionanti non sono solo le corrispondenze con Smith, ma anche quelle con
Mill.
In analogia con quanto scriveva nel 1919, Keynes ritiene che
la velocità dello sviluppo sia tale che "scartando l'eventualità di guerra
e di incrementi demografici eccezionali, il problema economico può
essere risolto, o per lo meno giungere in vista di una soluzione, nel giro di
un secolo" ("Prospettive economiche per i nostri nipoti",
in Esortazioni e profezie, Il Saggiatore, Milano 1968, p. 272;
corsivo nel testo).
Il sintomo della nuova situazione è il diffondersi di una
nuova malattia, la disoccupazione tecnologica. La causa, l'essere ormai vicino
il soddisfacimento completo dei bisogni "assoluti", "quelli che
sentiamo quali che siano le condizioni degli esseri umani nostri simili" -
bisogni che, a differenza di quelli "relativi", caratterizzati dal bisogno
insaziabile di superiorità sugli altri, possono raggiungere la saturazione
("Prospettive", p. 272). La via di uscita: la riduzione dell'orario
di lavoro: "Turni di tre ore e settimana lavorativa di quindici ore
possono tenere a bada il problema per un buon periodo di
tempo."("Prospettive", p. 274-275)
Come in Smith, la storia della società sino al capitalismo è
una storia sotto il segno della lotta per la sussistenza. Come in Mill,
l'evoluzione naturale del sistema ha uno scopo di cui l'azione dei singoli è
inconsapevole - la soluzione del problema economico - ma che una volta
raggiunto deve lasciare spazio ad attività il cui fine sia cosciente: "per
la prima volta dalla sua creazione l'uomo si troverà di fronte al suo vero , costante
problema: come impiegare la sua libertà dalle cure economiche più
pressanti, come impiegare il tempo libero"
("Prospettive", p. 221). Ancora come in Mill, il meccanismo
dell'accumulazione conduce oltre il lavoro, al tempo stesso modificando - sino
a rovesciarlo rispetto a Smith - il codice morale:
"Dovremo saperci liberare di molti dei principi
pseudomorali che ci hanno superstiziosamente angosciati per due secoli, e per i
quali abbiamo esaltato come massime virtù le qualità umane più spiacevoli.
Dovremo avere il coraggio di assegnare alla motivazione 'denaro' il suo
vero valore. L' amore per il denaro come possesso, e distinto
dall'amore per il denaro come mezzo per godere i piaceri della vita, sarà
riconosciuto per quello che è: una passione morbosa, un po' ripugnante,
una di quelle propensioni a metà criminali a metà patologiche che di solito si
consegnano con un brivido allo specialista di malattie mentali"
("Prospettive", p. 275)
Muta rispetto a Mill, come avevamo preannunciato, la
coscienza della drammaticità della transizione. Una drammaticità che nel testo
del '30 sembra soprattutto localizzata al livello della cultura della società,
cui viene imposta una trasformazione troppo accelerata:
"Sarà un bene? Se crediamo almeno un poco nei valori
della vita, si apre per lo meno una possibilità che diventi un bene. Eppure io
penso con terrore al ridimensionamento di abitudini e istinti nell'uomo comune,
abitudini e istinti concresciuti in lui per innumerevoli generazioni e che gli
sarà chiesto di scartare nel giro di pochi decenni. . . . Per troppo tempo,
infatti, siamo stati allenati a faticare anziché godere."
("Prospettive", pp. 273-274)
Già nel '36, nelle "Note conclusive sulla filosofia
sociale alla quale la Teoria generale potrebbe
condurre", la preoccupazione di Keynes si sarà radicalizzata. L'
"amore per il denaro" costituisce uno sfogo per tendenze aggressive
ben radicate nell'essere umano, come amaramente dimostrano i fascismi.
Pretendere di cancellarlo in poco tempo può essere più un male che un
bene:
"E' meglio che un uomo eserciti la sua tirannia sul
proprio conto in banca che sui suoi concittadini; e mentre talvolta si denuncia
il primo quale un mezzo per raggiungere il secondo, talaltra almeno ne è
un'alternativa." (Teoria generale dell'occupazione , dell'interesse e
della moneta , Utet, Torino 1978, p. 545)
La difficoltà di Mill si presenta ora sotto nuove spoglie:
come conciliare il compito di trasformare la natura umana con il compito di
governarla, quando i mezzi necessari al secondo scopo ostacolano il primo,
perché si fondano proprio su quelle passioni che occorrerebbe estirpare
affinché prevalgano i valori della vita?
Può essere utile fare un passo indietro, per indicare un
altro aspetto della questione. La distinzione operata da Keynes tra i bisogni
assoluti e quelli relativi - una distinzione che è anche separazione ed
indipendenza dei primi dai secondi - non può non richiamare alla mente la
distinzione di Smith tra bisogni "naturali" (cibo, vestiario e
riparo) e desiderio di "quelle comodità che sono richieste dalla
raffinatezza e delicatezza del nostro gusto" (si vedano, per esempio,
le Lezioni di Glasgow ). I primi, potremmo dire, sono comuni
agli esseri umani in quanto eguali, siano essi soli o in società; i secondi,
che pongono l'accento sulle differenze reciproche, sono necessariamente
relazionali e posizionali.
A differenza del Keynes di questi brani, però, Smith mette
in relazione i due tipi di bisogni, ed anzi crea un effetto di ritorno dei
secondi sui primi. Non soltanto perché lo scopo del processo capitalistico, il
sempre migliore soddisfacimento dei bisogni naturali, è per lui il risultato
inintenzionale di attività che sono invece rivolte all'obiettivo impossibile di
esaudire il desiderio di distinzione, attraverso l'impulso che esse danno alla
divisione del lavoro e alla crescita economica. C'è di più. Quei beni, dapprima
prodotti come "comodità" per i ricchi, finiranno con il tempo -
quando le classi superiori se ne saranno stancate - con il passare alle classi
più povere, soddisfacendo i loro bisogni naturali. Che, dunque, sono in realtà
sempre meno autonomi, e vanno a rimorchio del desiderio dei ricchi.
Qui l'antico si rivela più attuale del moderno. I fenomeni
di induzione e imitazione del consumo sembrano confermare più l'intuizione di
Smith che la tesi di Keynes. L'economia ha più a che fare con i bisogni
relativi che con quelli assoluti: sia perché le necessità fondamentali sono
sempre più determinate dal contesto storico e sociale; sia perché è la
produzione stessa a plasmare la domanda. Ma allora, se le cose stanno così, non
si vede perché l'espansione "artificiale" dei bisogni non possa
costringere ancora l'essere umano nel mondo del lavoro e dell'economia,
contrariamente a quanto scrive Keynes. E, d'altronde, una ulteriore riprova di
ciò la si ritrova nella stessa forma che ha poi assunto proprio l'intervento
keynesiano, quando si è proposto di rimuovere i limiti che il capitalismo
"puro" poneva alla piena utilizzazione delle risorse, limiti che
intralciavano la strada che conduce al superamento del problema economico.
Quell'intervento si è infatti configurato come un'immissione di domanda
aggiuntiva da parte dello Stato che ha sostenuto, direttamente ed
indirettamente, la domanda privata, ed in particolare la quota dei consumi sul
reddito. Vista da questo punto di vista, la politica economica eretta sulle
basi della Teoria generale - qui non importa con quanta
fedeltà - è la smentita più radicale del futuro preconizzato da Keynes, dal
momento che si traduce in un ulteriore salto nell' "artificialità"
del consumo. Una "artificialità" che un commentatore, malevolo ma
certamente acuto, come Schumpeter mette in risalto con perfidia in una
tempestiva recensione al libro di Keynes:
"Chi accetta il messaggio lì esposto potrebbe
riscrivere la storia dell' ancien régime francese grosso modo
nei termini seguenti. Luigi XV fu un monarca molto illuminato. Percependo la
necessità di stimolare la spesa, egli si procurò i servizi di spenditori
esperti quali M.me de Pompadour e M.me du Barry. Esse si misero all'opera con
un'efficacia insuperabile. La conseguenza avrebbe dovuto essere la piena
occupazione, indi il massimo di produzione e in ultimo un generale benessere.
In verità si trova invece miseria, infamia e, alla fine di tutto, un fiume di
sangue. Ma ciò fu una coincidenza del caso." ("Review of
Keynes's General Theory ", trad. it. in Schumpeter,
a cura di Marcello Messori, il Mulino, Bologna 1984, p. 357)
Certo, Schumpeter è incapace di prevedere l'efficacia dell'
interventismo keynesiano, e perciò la possibilità che su di esso si fondi la
tregua sociale tra capitale e lavoro che vedrà la luce nel secondo dopoguerra.
Ai nostri scopi, però, è proprio l'innaturalità dei bisogni soddisfatti dal
capitalismo - cui approdano, da sponde diverse, tanto lo Schumpeter della Teoria
dello sviluppo quanto il Keynes della Teoria generale, ad
essere di un qualche significato. Un meccanismo capitalistico di questo tipo,
in cui è la produzione a tirar dietro di sé la domanda, riproduce, invece
che superare, il problema economico.
6. Come se avesse l'amore in corpo. Marx e l'enigma del
lavoro.
"La libertà autentica non è definita da un rapporto tra
il desiderio e la soddisfazione, ma da un rapporto tra il pensiero e l'azione;
sarebbe completamente libero l'uomo le cui azioni procedessero tutte da un
giudizio preliminare concernente il fine che egli si propone e il
concatenamento dei mezzi atti a realizzare questo fine."
Simone Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e
dell'oppressione sociale , Adelphi, Milano 1983, pp. 77
Il discorso smithiano sulla giustificazione storica trova la
sua ripresa ed il suo rovesciamento in Marx. I brani probabilmente più
rappresentativi sono i due seguenti:
"Dal punto di vista storico, questa inversione [di
soggetto e oggetto] appare come il punto di passaggio obbligatorio per
ottenere, a spese della maggioranza, la creazione della ricchezza in quanto
tale, l'inesorabile sviluppo di quelle forze produttive del lavoro
sociale che sole possono fornire la base materiale di una libera
società umana. Passare attraverso questa forma contraddittoria è necessario
come, in un primo tempo, l'uomo deve dare alle proprie forze intellettive la
forma religiosa di potenze indipendenti da sé." (Capitolo VI inedito,
La Nuova Italia, Firenze 1969, p. 21)
"I rapporti di dipendenza personale (all'inizio
su una base del tutto naturale) sono le prime forme sociali, nelle quali la
produttività umana si sviluppa soltanto in un ambito ristretto e
in punti isolati. L'indipendenza personale fondata sulla
dipendenza materiale è la secondaforma importante in cui
giunge a costituirsi un sistema di ricambio generale, un sistema di relazioni
universali, di bisogni universali e di universali capacità. La libera
individualità, fondata sullo sviluppo universale degli
individui e sulla subordinazione della loro produttività
collettiva, sociale, quale loro patrimonio sociale, costituisce il terzo stadio"(Grundrisse,
vol. I, La Nuova Italia, Firenze 1968-70, pp. 98-99)
In questa sezione cercherò di mostrare come la riconduzione
dell'incivilimento dell'umanità allo sviluppo della produttività del lavoro
portato dal capitalismo e l' individuazione di tre fasi della storia umana -
della dipendenza personale; della indipendenza personale fondata sulla
dipendenza materiale; della affermazione della libera individualità - non
configurano né una concezione economicistica ed escatologica della storia, né
una ontologia; benché, certamente, siano fondate su una particolare visione
dell' "essenza" dell' essere umano, ed affermino la possibilità di
dare un senso alla storia.
6.1. Il lavoro come essenza dell'essere umano
Nei Manoscritti economico-filosofici del 1844 Marx
svolge la sua critica del modo di produzione capitalistico a partire dalla tesi
che in esso viene ad essere alienata l'essenza stessa dell'essere umano,
costituita dal lavoro. Per il Marx dei Manoscritti, la specificità
dell'essere umano è di essere un ente, al contempo, naturale e generico.
Naturale: l'essere umano è, infatti, egli stesso una parte della natura, ed ha
una natura fuori di sé, di cui vive; dalla natura trae i propri mezzi di
sussistenza, e la materia con cui appronta gli strumenti e l'oggetto del
lavoro. Generico: in quanto essere pensante, e dunque dotato di ragione, è
l'indifferenza di tutte le differenze; non è perciò legato ad alcuna
determinazione particolare, ma può in potenza, attraverso il lavoro, progettare
e rendere oggettiva ogni determinazione. Agendo secondo le leggi della natura
ed in rapporto con gli altri, in società, l'essere umano produce la stessa realtà
che lo circonda secondo una misura universale:
"La libera attività consapevole è il carattere
specifico dell'uomo . . . L'animale fa immediatamente uno con la sua attività
vitale, non si distingue da essa, è essa . L'uomo fa della sua
attività vitale stessa l'oggetto del suo volere e della sua coscienza. Egli ha
una cosciente attività vitale: non c'è una sfera determinata con cui
immediatamente si confonde. L'attività vitale consapevole distingue l'uomo
direttamente dall'attività vitale animale. Proprio solo per questo egli è un
ente generico . . . La pratica produzione di un mondo oggettivo ,
la lavorazione della natura inorganica è la conferma
dell'uomo come consapevole ente generico, cioè ente che si rapporta al genere
come al suo proprio essere ossia si rapporta a sé come ente generico. Invero
anche l'animale produce: esso si costruisce un nido, delle abitazioni, come le
api, i castori, le formiche etc. . Ma esso produce soltanto ciò di cui
abbisogna immediatamente per sé o per i suoi nati; produce parzialmente, mentre
l'uomo produce universalmente; produce solo sotto il dominio del bisogno fisico
immediato, mentre l'uomo produce anche libero dal bisogno fisico e produce
veramente soltanto nella libertà dal medesimo. L'animale produce solo se stesso,
mentre l'uomo riproduce l'intera natura; il prodotto dell'animale appartiene
immediatamente al suo corpo fisico, mentre l'uomo confronta libero il suo
prodotto. L'animale forma cose solo secondo la misura e il bisogno della specie
cui appartiene; mentre l'uomo sa produrre secondo la misura di ogni specie e
dappertutto sa conferire all'oggetto la misura inerente, quindi l'uomo forma
anche secondo le leggi della bellezza. Proprio soltanto nella lavorazione del
mondo oggettivo l'uomo si realizza quindi come un ente generico .
Questa produzione è la sua attiva vita generica. Per essa la natura si palesa
come opera sua , dell'uomo, e sua realtà. L'oggetto del lavoro
è quindi l' oggettivazione della vita generica dell'uomo: poiché
egli si sdoppia non solo intellettualmente come nella coscienza, bensì
attivamente, realmente, e vede se stesso in un mondo fatto da lui. (Manoscritti
economico-filosofici del 1844, in Opere filosofiche giovanili ,
Editori Riuniti, Roma 1974, pp. 199-200. Corsivi di Marx. Sottolineature mie)
In un lavoro autenticamente umano si mediano la genericità
dell'attività, che non è fissata in uno scopo determinato, e la sua naturalità,
la dipendenza da un mondo naturale ed oggettivo. La realtà viene appresa
trasformandola: è un "in sé" che può essere colto come tale, nella
sua indipendenza, solo nella misura in cui è al contempo reso un "per
noi". Ma il passaggio al lavoro salariato inverte qui, nel cuore stesso
della sua essenza sociale, la natura del lavoro. Separa il lavoratore dal mezzo
di lavoro, facendo anzi del primo uno strumento del secondo. Separa, ancora, il
lavoratore dal prodotto del suo lavoro, che non soltanto non è di sua proprietà
ma gli è indifferente. Separa, di conseguenza e per ultimo, il lavoratore dal
suo stesso lavoro, che diviene così una maledizione.
Alla originaria dipendenza della natura segue una
altrettanto cieca dipendenza da meccanismi sociali incontrollati. Invece di
trovare nel lavoro il luogo di uno sviluppo universale delle proprie capacità,
l'individuo vive nel lavoro il massimo di estraneazione. Come si sa, gli
interpreti si dividono tra chi ritiene che il Marx maturo,
"scientifico", abbia abbandonato queste tesi del Marx giovane,
"filosofo" troppo influenzato dalla critica che Feuerbach muove ad
Hegel. Ed anche chi sostiene la tesi della continuità si trova quasi sempre a
leggere il discorso di Marx sul lavoro come essenza dell'essere umano come una
generalizzazione mentale, oppure come la descrizione di una realtà metastorica.
In quanto tale, esso andrebbe visto come la base di un giudizio - o
pregiudizio, se si preferisce - filosofico, che stigmatizza la realtà del
capitale in quanto deviazione da una essenza, appunto,
"naturale". Credo che le cose stiano molto diversamente. Che il Marx
maturo trasformi ma non abbandoni la visione giovanile. Che però in questa
trasformazione avvenga un mutamento di grande portata: l'universalità e la
socialità del lavoro sono ora ritenuti fenomeni integralmente storici: essi
fanno la loro apparizione, sia pure in forma rovesciata ed astratta, soltanto
con il modo di produzione capitalistico. E' con quest'ultimo, infatti, che
trovano pratica conferma il carattere sociale della produzione e la possibilità
di non essere costretti permanentemente in una ed una sola attività - elementi
cruciali della definizione di quella genericità che costituisce il tratto
distintivo di quel particolare ente naturale che è l'essere umano. In questa
luce, il discorso sul lavoro come essenza dell'essere umano non è più, come nel
1844, il fondamento di una critica filosofica ed esterna della realtà
esistente, ma diviene parte di una scienza che vuole totalmente immanente il
punto di vista della critica. Vediamo meglio.
Il luogo più opportuno per accertare la posizione del Marx
maturo è, a me pare, la parte dei Grundrisse dedicata alle
"forme economiche precapitalistiche". E' qui, nella discontinuità tra
il mondo del capitale e ciò che lo precede, che Marx sottolinea come nella
storia venga a compimento quel cambiamento radicale della configurazione del
rapporto tra essere umano e natura che si riflette nella realtà del lavoro, e
dunque anche nella riflessione su di esso.
Nelle forme economiche precapitalistiche, l'essere umano
intrattiene un rapporto particolare e determinato con la natura, che irrigidisce
gli stessi rapporti personali dentro i vincoli della tradizione. Prima del
capitalismo, la natura non soltanto appare, ma ancora in larga misura
effettivamente è, una condizione esterna, non mediata, dell'attività umana. Ne
impone i ritmi, e ne segna il limite. L'agricoltura è in queste condizioni il
centro dell'organizzazione economica. La terra come natura è presupposta al
lavoro, "la principale condizione obiettiva del lavoro non si presenta
essa stessa come prodotto, ma esiste come natura "
(Forme economiche precapitalistiche, Editori Riuniti, Roma 1974, p. 83).
Il rapporto con la terra è mediato dall'esistenza dell'individuo come membro di
una comunità, ed egli deve riprodursi in questo ruolo determinato:
"In tutte queste forme la riproduzione
di rapporti dati in precedenza - più o meno naturali, o anche
sorti storicamente, ma divenuti tradizionali - del singolo con la propria
comunità, e una esistenza che sia oggettiva, determinata,
predeterminata nei suoi confronti sia in rapporto alle condizioni di
lavoro che ai suoi collaboratori, membri della sua tribù, ecc. - è il
fondamento dello sviluppo, che fin dal principio è pertanto limitato ,
ma con l'eliminazione delle limitazioni diventa rovina e decadenza . . .
All'interno di una determinata cerchia, possono qui verificarsi grandi
sviluppi. Le individualità possono apparire grandi. Ma non c'è qui da pensare a
uno sviluppo libero e completo né dell'individuo, né della società, in quanto
un tale sviluppo è in contraddizione con il rapporto originario." (Forme,
p. 86. Corsivi nel testo. Sottolineatura mia.)
La divisione del lavoro è in queste forme economiche, come
anche nella produzione artigianale precapitalistica, una divisione del lavoro
"naturale-spontanea". Il lavoro del singolo, in quanto lavoro utile,
è un lavoro immediatamente sociale. Ma, si badi, soltanto in quanto esso è al
contempo lavoro parziale in una comunità ristretta, che mira a riprodursi in
quanto tale. La separazione del lavoratore dalla proprietà dei mezzi di
produzione, dalla terra come "laboratorio naturale", e quindi anche
dai mezzi di sussistenza, è per Marx una condizione storica necessaria per
emancipare l'essere umano dalla destinazione ad una forma di attività limitata,
che ne fa un ente particolare, non universale. L'universalità del lavoro
capitalistico va intesa in modo duplice. Si tratta, innanzitutto, del fatto che
nelle nuove condizioni il lavoro diviene sociale solo attraverso la mediazione
del mercato: attraverso, cioè, un processo di equiparazione nello scambio, che
realmente separa ed oppone il lavoro vivo del salariato - in quanto produttore
di denaro, e dunque in quanto lavoro sociale-astratto in potenza - rispetto ai
lavori utili-concreti dei medesimi operai - che sono invece immediatamente
privati, e disomogenei gli uni rispetto agli altri.
Ma vi è anche un secondo aspetto. Una volta che la ricchezza
non è più costituita dai valori d'uso, ma da una ricchezza astratta, la
produzione non ha più un limite esterno dato dalla finalizzazione al consumo
della classe dominante, o dalla riproduzione di rapporti già dati e fissi.
Diviene autovalorizzazione del capitale, massimizzazione dell'estrazione del
pluslavoro, produzione per la produzione. La stessa struttura tecnica della
produzione viene incessantemente rivoluzionata, allo scopo di ottenere il
profitto il più elevato possibile. In tal modo, peraltro, il capitale finisce
con l'infrangere all'interno della produzione stessa il legame tra lavoratore
singolo e mansione lavorativa. Autonomizza la produzione capitalistica dalle
abilità particolari dell'individuo - un punto che segna un vero e proprio
rovesciamento della posizione di Smith sulla divisione del lavoro.
Nell'universalità del lavoro capitalistico vi è dunque una doppia separazione
dalla naturalità. Nello scambio generalizzato è stata soppressa ogni traccia
del lavoro utile, produttore di beni concreti, ed il lavoro si è realmente
ridotto ad una pura astrazione, a creazione di ricchezza generica. Nel processo
lavorativo non vi è quasi più rapporto tra le abilità particolari dell'operaio,
ormai tendenzialmente annullate o ridotte all'insignificanza, e gli specifici
valori d'uso prodotti.
Il modo di produzione capitalistico è così l'espressione di
una contraddizione. Costituisce, per la prima volta nella storia, la società
come effettiva universalità di relazioni nello scambio; fa ciò però isolando i
produttori e contrapponendoli nella concorrenza. Rende il lavoro del singolo
funzione della cooperazione sociale; gli impone però quest'ultima come risultato
di una scienza e di una organizzazione capitalistica, di cui diviene un
accessorio vivente:
"quello che compera il capitalista e che il lavoratore
vende è il valore d'uso della capacità di lavoro, vale a dire il lavoro stesso,
la forza che crea e accresce il valore. Perciò la forza che crea e che accresce
il valore appartiene non al lavoratore ma al capitale. Incorporandosela esso
diventa vivo e comincia to work "come se avesse amore in corpo"
[J.W.Goethe, Faust, vv. 2130-2149]" (Manoscritti del
1861-1863, Editori Riuniti, Roma 1980, p. 114)
6.2. Il lato positivo del capitale. Natura e storia in
Marx.
Poche altre citazioni basteranno a confermare la nostra
interpretazione. Marx riprende da Smith la tesi che l'unica vera società è
quella capitalistica, e ne ammette la superiorità rispetto alle forme
precedenti. Ma ne sottolinea la contraddittorietà, e la possibilità che essa
apre: che l'evoluzione spontanea lasci il posto alla libera individualità, la
quale fa della società il suo progetto.
"Si è detto e si può dire che il lato magnifico sta
proprio in questo ricambio materiale e spirituale, in questa connessione
naturale, indipendente dal sapere e dal volere degli individui, e che
presuppone proprio la loro indipendenza e indifferenza reciproche. Altrettanto
certo è che gli individui non possono subordinare a sé i loro stessi nessi
sociali prima di averli creati. Ma è anche insulso pensare quel nesso
soltanto materiale come un nesso naturale, inscindibile dalla natura
dell'individualità (in antitesi al sapere e al volere riflessi) e ad essa
immanente. Esso invece ne è un prodotto. E' un prodotto storico.
Appartiene ad una determinata fase del suo sviluppo. L'estraneità e l'autonomia
in cui esso ancora si trova rispetto a loro, dimostra soltanto che essi sono
ancora presi nella creazione delle condizioni della loro vita sociale invece di
averla iniziata a partire da queste condizioni. Quella naturale è la
connessione di individui nell'ambito di determinati e limitati rapporti di
produzione di produzione. Gli individui universalmente sviluppati,
i cui rapporti sociali in quanto loro relazioni proprie, comuni, sono già
assoggettati al loro proprio comune controllo, non sono un prodotto della
natura, bensì della storia. Il grado e l'universalità dello sviluppo della
capacità in cui questa individualità diventa possibile, presuppone appunto la
produzione sulla base dei valori di scambio, la quale essa soltanto produce,
insieme con l'universalità, l'alienazione dell'individuo da sé e dagli altri,
ma anche l'universalità e l'organicità delle sue relazioni e delle sue capacità."
(Grundrisse, vol I, p. 104)
Per Marx, il modo di produzione capitalistico va visto
dunque come il momento di passaggio tra due fasi della storia dell'essere
umano: la prima "naturale", dove nel rapporto tra l'essere umano e la
natura è il secondo elemento che prevale; la seconda "storica", dove
è predominante l'attività dell'essere umano su una natura che, pur rimanendo
esterna, è però sempre più sotto il suo dominio e la società è propriamente
tale, cioè generale.
A queste due fasi corrispondono necessariamente due diverse
configurazioni del lavoro. Nella prima, lo scopo del lavoro è dettato dalla
necessità naturale, mentre nella seconda è posto dall'essere umano stesso (e lo
stesso vale, in certa misura, per gli ostacoli che il lavoro inevitabilmente
incontra).
La libera individualità è peraltro sociale non solo, per
così dire, a valle, ma anche a monte. Le relazioni sociali non sono soltanto il
prodotto di un nuovo tipo di individualità, ma esse entrano nella sua stessa
costituzione. Si tratta nuovamente di un risultato reso possibile dall'epoca
borghese. Infatti, il capitalismo che nello scambio riunifica unità produttive
separate ed antagonistiche, dissolve però nella produzione l'isolamento
dell'individuo e ne fa un essere generale, collettivo. Marx nega, di
conseguenza, tanto che lo stadio primitivo possa essere caratterizzato, come in
Smith, dal "lavoro dell'uomo isolato", quanto che la divisione del
lavoro si limiti a frantumarne l'unità mantenendone però immutata la natura. La
storia può piuttosto essere letta come il passaggio dal gregarismo primitivo
all'autentica socialità del futuro, attraverso la fase contraddittoria
dell'atomismo concorrenziale, da un lato, e della cooperazione nella
produzione, come anche della solidarietà tra i lavoratori, dall'altro
lato:
"L'essere umano si isola attraverso il processo
storico. Originariamente egli si presenta come essere sociale, tribale,
animale gregario - anche se assolutamente non come uno zwon politixon
nel senso politico. Lo scambio stesso è uno dei mezzi principali di questo
isolamento. esso rende superfluo il gregarismo e lo dissolve. Non appena le
cose si svolgono in modo tale che egli in quanto individuo isolato si ponga
ormai in rapporto solo con se stesso, i mezzi per affermarsi come isolato
consistono però nel suo farsi essere generale e collettivo." (Forme,
p. 99. Corsivi nel testo. Sottolineature mie)
Che il capitalismo, giunto allo stadio del macchinismo,
produca per un verso il massimo arricchimento potenziale delle capacità dei
lavoratori, "liberandoli" dalle rigidità del mestiere e facendone in
potenza gli ideatori e i controllori di una produzione universale, e per
l'altro verso il loro massimo impoverimento, legandoli alla determinazione
particolare impostagli dalla macchina di cui divengono mero strumento ed
appendice, è affermato a chiare lettere nel Capitale, di nuovo in
implicita contrapposizione a Smith:
"S'è visto che la grande industria elimina tecnicamente
la divisione del lavoro di tipo manifatturiero con la sua annessione d' un uomo
intero ad una operazione parziale vita natural durante, mentre allo stesso
tempo, la forma capitalistica della grande industriariproduce in
maniera anche più mostruosa quella divisione del lavoro, nella fabbrica vera e
propria, mediante la trasformazione dell'operaio in accessorio consapevole e
cosciente d'una macchina parziale . . . Finché l'artigianato e la manifattura
costituiscono il fondamento generale della produzione sociale, la subordinazione
del produttore a un ramo esclusivo della produzione, cioè la distruzione della
molteplicità originaria della sua occupazione, è un momento necessario dello
sviluppo. Su quella base ogni branca particolare della produzione trova
empiricamente la configurazione tecnica che le si confà, la perfeziona
lentamente e la cristallizza rapidamente appena è raggiunto un dato grado di
maturazione. Quel che provoca qua e là dei cambiamenti è, oltre qualche nuovo
materiale di lavoro, fornito dal commercio, la graduale modificazione dello
strumento di lavoro. Una volta raggiunta la forma confacente secondo
l'esperienza, anche lo strumento di lavoro si irrigidisce, come dimostra il suo
passare, spesso per millenni, dalle mani di una generazione in quelle della seguente.
. . La industria moderna non considera e non tratta mai come definitiva la
forma esistente di un processo di produzione. Quindi la sua base tecnica è
rivoluzionaria, mentre la base di tutti gli altri modi di produzione era
sostanzialmente conservatrice . . . Quindi la natura della grande industria
porta con sé variazione del lavoro, fluidità delle funzioni, mobilità
dell'operaio in tutti i sensi. Dall'altra parte essa riproduce la antica
divisione del lavoro con le sue particolarità ossificate, ma nella sua forma
capitalistica . . . Per essa diventa questione di vita o di morte sostituire a
quella mostruosità che è una miserabile popolazione operaia disponibile, tenuta
in riserva per il variabile bisogno di sfruttamento del capitale, la disponibilità
assoluta dell'uomo per il variare delle esigenze del lavoro: sostituire
all'individuo parziale, mero veicolo di una funzione sociale di dettaglio,
l'individuo totalmente sviluppato, per il quale le differenti funzioni sociali
sono modi di attività che si danno il cambio l'uno con l'altro." (Il
Capitale, Libro primo, 2, Editori Riuniti, Roma 1970, pp. 196-201)
Ben s'intende, sulla base di questa analisi, come Marx
avesse elevato nei Grundrisse un inno al capitale tale da far
impallidire qualsiasi cosa scritta da Smith.
"Perciò la vecchia concezione secondo cui l'uomo anche
se inteso in un senso molto limitato dal punto di vista nazionale, religioso,
politico, è sempre lo scopo della produzione, appare molto elevata nei
confronti del mondo moderno, in cui la produzione si presenta come scopo
dell'uomo e la ricchezza come scopo della produzione. Ma, in fact,
una volta gettata via la limitata forma borghese, che cosa è la ricchezza se
non l'universalità dei bisogni, dei consumi, delle forze produttive, ecc. degli
individui, creata nello scambio universale? Che cosa è se non il pieno sviluppo
del dominio dell'uomo sulle forze della natura, sia su quelle della cosiddetta
natura, sia su quelle della propria natura? Che cosa è se non l'estrinsecazione
assoluta delle sue doti creative, senz'altro presupposto che il precedente
sviluppo storico, la quale rende fine a se stessa questa totalità dello
sviluppo, cioè dello sviluppo di tutte le forze umane, non misurate su di un
metro già dato. Nella quale l'uomo non si riproduce entro un modo
determinato, ma produce la propria totalità? Dove non cerca di rimanere qualche
cosa di divenuto, ma è nell'assoluto movimento del divenire?" (Forme,
p. 87-88. Corsivi nel testo. Sottolineature mie.)
6.3. Una filosofia della storia?
Non ci aiuta ad intendere il senso della riflessione
marxiana interpretarla come una ontologia, dove la critica concreta della
realtà sociale viene fatta dipendere da una previa comprensione speculativa del
lavoro in quanto "modello" generale dell'agire umano. Non credo
neanche che sia corretto leggerla come una filosofia della storia: almeno se
con questo termine si intende, come è d'uso per i critici di Marx, una
concezione "forte", aprioristica e teleologica, che dispone le fasi
dello sviluppo del genere umano secondo un ordine orientato secondo la
realizzazione di un Fine, imposto dalla Ragione o dalla Materia poco importa;
una concezione in cui quindi la spiegazione si colora dei tratti della
giustificazione. A questo schema Marx corrisponde altrettanto poco di Smith,
Stuart Mill o Keynes, per i quali il capitalismo era un "caso", sia
pure fortunato. In modo analogo, il riconoscimento da parte di Marx di un
"senso" della storia, ricostruibile grazie a certe categorie
generali, è più sotto il segno della possibilità che della necessità
Confesso che mi è sempre apparsa convincente la posizione di
Alfred Schmidt, che legge in tutt'altri termini il discorso marxiano. Marx
individua, a partire dalla sua analisi - scientifica e critica - di questa
società, la differenza specifica tra il capitalismo e le forme
precapitalistiche di produzione, differenza consistente nel fatto che:
"nel mondo preborghese il rapporto tra l'elemento
naturale e lo storico rientra nel grande contesto della natura; nel mondo borghese,
anche per quanto concerne la natura non ancora appropriata, quel rapporto
rientra nella storia"(Alfred Schmidt, Il concetto di natura in
Marx, Laterza, Bari 1973, p. 171)
L'attribuzione marxiana della "naturalità" alle
formazioni sociali precapitalistiche è data, insomma, solo nel confronto con la
società borghese, e sulla base della comprensione teorica dei moderni rapporti
di produzione. Così, anche la fase della libera individualità sociale non
costituisce tanto il fine cui tende linearmente l'evoluzione sociale, ma può
essere il risultato di una prassi emancipativa:
"Solo alla considerazione teoretica la modificazione di
una forma si dimostra come suo sviluppo superiore pur senza esserne il
necessario prodotto. Il corso della storia per Marx è quindi molto meno lineare
di come viene concepito generalmente; esso non obbedisce ad alcuna idea
che ne costituisca l'unità e il senso, bensì si ricompone continuamente a
partire da singoli processi originali. In questo modo alla formazione della
società borghese spetta nel materialismo dialettico un ruolo metodologicamente
decisivo, in quanto a partire da essa si dischiudono tanto il passato
quanto anche le possibilità del futuro. Marx è tutt'altro che un semplice
evoluzionista. Ogni momento storicamente superiore si fonda su quello
inferiore, ma l'alterità qualitativa dell'inferiore rispetto al superiore che
da esso scaturisce può essere compresa soltanto quando questo momento superiore
si è pienamente dispiegato, ed è diventato oggetto di una critica immanente"(Alfred
Schmidt, Il concetto di natura in Marx, p. 171)
"Il materialismo marxiano è critica alla filosofia
perché attribuisce al mondo un significato soltanto nella misura in cui
gli uomini sono riusciti a realizzarlo attraverso le loro istituzioni sociali.
Il materialismo rifiuta di trasfigurare il continuo negativo della storia
movendo dal concetto di una natura umana comune a tutti e immutabile o di un
fondamento ontologico che il singolo dovrebbe scoprire in se
stesso"(Alfred Schmidt, "Ontologia esistenziale e materialismo
storico in Herbert Marcuse", in Risposte a Marcuse , a
cura di Jürgen Habermas, Laterza, Bari, p. 46)
7. Orfeo e Narciso contro Prometeo. La fuga dal lavoro.
"Un singolo essere umano, puro e semplice, non
mescolato con altri esseri umani, non esiste. Ogni personalità è un mondo in
sé, una società di molti . . . Noi facciamo parte gli uni degli altri."
Joan Rivière, "La fantasia inconscia di un mondo
interno riflessa in esempi tratti dalla letteratura", in Nuove vie
della psicoanalisi, a cura di Melanie Klein, Paula Heimann, Roger
Money-Kyrle, il Saggiatore, Milano 1966, pp. 460-461.
7.1. La positività del finito.
La contraddittorietà del modo di produzione capitalistico si
esprime, secondo Marx, nel fatto che, benché esso misuri la ricchezza sul tempo
di lavoro, ha la tendenza a ridurre al minimo il tempo di lavoro che la società
dedica alla produzione della ricchezza.
Di solito, Marx viene rinchiuso dagli interpreti in
posizioni estreme, entrambe caricaturali. Secondo taluni, Marx sarebbe il
teorico della esaltazione del lavoro, all'interno di una visione della storia
che riconduce le leggi di movimento di qualsiasi formazione sociale in un vero
e proprio determinismo tecnologico, e fa del comunismo la condizione in cui si
generalizza la figura del salariato. E' una tesi che ha, di fatto, attraversato
tanto la Seconda quanto la Terza Internazionale. Altri ne hanno fatto,
all'opposto, il teorico del rifiuto del lavoro, all'interno di una visione
della rivoluzione come salto nell'assoluto. Come uscita, cioè, dai limiti di un
finito alienato, in cui il lavoro sarebbe costitutivamente intrappolato, allo
scopo di realizzare un agire, quello sì autenticamente umano, dai caratteri a
priori indeterminati. Salto, dunque, dal finito all'infinito, da un lavoro
condizionato ad un'attività incondizionata. E' questa, per esempio,
l'interpretazione di autori così diversi come Franco Rodano, che ne fa la base
di una critica di Marx, o come Toni Negri, che ne fa il fondamento di una
apologia del sabotaggio della produzione e dell' esproprio
"proletario".
Si tratta di un duplice, grottesco, travisamento della
posizione di Marx. L'interpretazione "lavorista" inverte, rispetto a
Marx, il nesso di causalità tra determinazioni tecniche e relazioni sociali,
facendo comandare le prime sulle seconde; e non vede che in Marx la centralità
della produzione e il discorso sul lavoro come essenza dell'essere umano sono
antitetici, nel senso che la realizzazione del secondo può avvenire solo in un
mondo in cui la prima sia stata superata.
L'interpretazione "antilavorista" compie un errore
idealistico, speculare a quello oggettivistico implicito nella precedente.
Confonde, infatti, oggettivazione e alienazione: il Marx di questa lettura
riterrebbe che qualsiasi attività che si svolge entro una materialità
condizionante vada per ciò stesso ritenuta alienante. Ma, come scrisse Claudio
Napoleoni all'inizio degli anni settanta, per Marx
"il finito non è negativo, ma è reso tale
da una situazione sociale determinata. La rivoluzione, nel senso di Marx, ne
risulta allora caratterizzata come la riconquista della positività del finito,
come quella riappropriazione dell'essere umano per cui il limite proprio
dell'ente naturale generico, e perciò del lavoro, è solo limite e non anche
alienazione e sfruttamento." ("Quale funzione ha avuto la Rivista
Trimestrale", in Rinascita, 6 ottobre 1972)
Rimane, comunque, il problema di individuare quale possa
essere, in una prospettiva marxiana, la conciliazione tra riduzione del tempo
di lavoro e "libero sviluppo dell'individualità", una volta che
l'aumento della produttività sociale abbia esaurito il ruolo storico della
centralità della produzione. Quale, insomma, la relazione tra economia e
società, una volta superata la forma contraddittoria del capitalismo.
La riflessione più recente dello stesso Claudio Napoleoni
può esserci anche qui di aiuto. In alcuni scritti di questo autore, infatti,
viene proposta una rilettura della prospettiva marxiana di superamento del
capitalismo che riprende esplicitamente le argomentazioni di Mill e Keynes.
Dopo aver ribadito che:
"la centralità dell'economico, da un certo punto di
vista, non può che essere constatata . . . Però, all'interno di quello che
possiamo continuare a chiamare un compito, questa centralità va
negata."("La libertà del finito. Conversazione con Claudio
Napoleoni", in Palomar. Quaderni di Porto Venere, n. 3, 1987,
p. 15)
osserva:
"Questo però è un discorso aperto, e allora qui vengono
concetti molto delicati, come quello di 'scarsità', e il suo corrispettivo in
negativo, che è l'abbondanza. Insomma, l'economia come scienza della scarsità -
anche questo è un paradosso - è stata pensata così da chi pensava di dare una
definizione generale, non connessa a un sistema sociale dato. Invece, secondo
me, si potrebbe mostrare che questa definizione è strettamente legata al
sistema sociale dato; e che, se invece si volesse tentare una definizione non
così condizionata, bisognerebbe probabilmente pensare ad un'economia in
cui il momento dell'abbondanza - perciò della quiete,
in qualche modo della tranquilla fruizione di ciò che si è
conseguito - non si configura solo come necessaria base per andare avanti, ma
come pacificazione, almeno relativa, rispetto ad una certa condizione
storica. Questo concetto avrebbe altrettanta legittimità di essere elemento
costitutivo di una definizione dell'economia, di quanta ne abbia la
scarsità."("La libertà", pp. 15-16)
Proprio perché incapaci di intravedere una definizione
diversa di economia, prosegue Napoleoni, Stuart Mill e Keynes avrebbero inteso
l'uscita dal capitale come una uscita dall'economia tout court. Piuttosto, si
tratterebbe di vedere che in tal modo viene a terminare solo una particolare
modalità dell'economia. Un ragionamento, ed un suggerimento, suggestivi: ma che
rimandano, inevitabilmente, ad un chiarimento ulteriore, che riempia di
contenuto l'economia dell'abbondanza, della "tranquilla fruizione di ciò
che si è conseguito".
Vale la pena di seguire tre possibili piste, tutte in
qualche modo consentite dal percorso dell'ultimo Napoleoni - anche se, come
dirò, le prime due non possono in alcun modo essere da sole viste come
rappresentative della sua posizione.
7.2. Tramonto o eclissi dei valori tradizionali?
La prima possibile interpretazione è quella di leggere nel
recupero operato da Napoleoni della nozione greca di "scholé", di
contemplazione, come dimensione dell'essere umano altrettanto essenziale del
lavoro, nient'altro che il rovesciamento rivoluzionario della posizione
conservatrice di Augusto Del Noce.
La situazione contemporanea viene definita in termini di
completa secolarizzazione, e quindi di crisi dei valori tradizionali: tale
crisi andrebbe intesa però non come definitivo tramonto ma come temporanea
eclissi. Il "compito" di cui parla Napoleoni potrebbe allora essere
ridetto in questo modo: si tratta di superare insieme la riflessione
preborghese, che ritiene che la vera umanità possa esplicarsi soltanto fuori
dal lavoro, e l'assolutizzazione del lavoro realizzata dalla società borghese.
Il ruolo storico del capitale, all'interno di questa lettura, sarebbe stato
quello di costruire le condizioni materiali per estendere a tutti la
"scholé". Il gigantesco progresso tecnico portato dall'industrialismo
libera gli individui dal lavoro come sacrificio, e lo dispone ad
"altro", ad attività in senso lato spirituali. Una prospettiva
non troppo dissimile dal Keynes che, chiedendosi in cosa consista la fine
dell'economia, si trova a citare il vangelo di Matteo (2, 26-30):
"Vedo quindi gli uomini tornare ad alcuni dei principi
più solidi ed autentici della religione e della virtù tradizionali: che
l'avarizia è un vizio, l'esazione dell'usura una colpa, l'amore per il denaro
spregevole, e che chi meno s'affanna per il domani cammina veramente sul
sentiero della virtù e della profonda saggezza. Rivaluteremo di nuovo i fini
sui mezzi e preferiremo il bene all'utile." ("Prospettive", p.
276)
7.3. Marxismo e psicoanalisi. Un nuovo principio di
realtà?
Una seconda interpretazione, non necessariamente alternativa
alla precedente, è quella di vedere l'uscita dal capitalismo come la condizione
del superamento della contrapposizione tra principio della realtà e principio
del piacere. Questa lettura può prendere lo spunto da alcune considerazioni di
Napoleoni stesso:
"Io credo che una linea di ricerca molto
proficua è quella del collegamento, che finora è stato tentato soltanto in modo
superficiale, tra il marxismo e una parte della psicoanalisi, della
psicoanalisi come interpretazione della storia. C'è un punto in cui avviene
un possibile congiungimento, che è proprio il punto del lavoro. Il
primo Freud, quello che contrappone principio della realtà e principio del
piacere, si è posto il problema del lavoro in maniera molto precisa, cioè il
problema del processo attraverso il quale, per ragioni attinenti essenzialmente
alla sussistenza fisica, l'uomo abbia dovuto sviluppare una facoltà - appunto
il principio della realtà, cioè il lavoro - che è stata la negazione di una
altra sua facoltà, con una frattura al suo interno che ha determinato, nello
stesso momento, sul terreno sociale la necessità della repressione, e sul
terreno della vita individuale la costituzione graduale dell'inconscio. Poi
Freud ha abbastanza cambiato le sue idee su questo terreno. Però una
problematica di questo tipo è molto vicina, secondo me, a quella che Marx
affrontò già nei Manoscritti : perché anche in Marx c'è il
problema del lavoro come opposto ad altre facoltà, lo sviluppo delle quali
viene da lui visto, non a caso, come possibile in una fase in cui il lavoro è
diventato meno necessario di quanto fosse all'origine." ("Marx e la
critica dell'economia politica", in "An.archos", 2, 1979, pp.
104-105)
Tra i "tentativi superficiali" cui fa riferimento
Napoleoni vi è forse da annoverare quello di un autore, cui peraltro egli ha
sempre prestato molta attenzione: mi riferisco al Marcuse di Eros e
civiltà. Accanto al testo di Marcuse, non privo di interesse è un altro
libro degli anni cinquanta, dalle tesi non molto dissimili: si tratta de La
vita contro la morte di Norman Brown, che dedica uno dei suoi capitoli
centrali - intitolato "lo sporco denaro" - all'irrazionale
razionalità dell' homo oeconomicus , e che fonda gran parte
della sua argomentazione sui brani di Keynes, dalle Conseguenze
economiche della pace, che abbiamo citato. Vale la pena di soffermarsi un
attimo su questa particolare versione di marxismo psicoanalitico.
Basteranno poche citazioni per cogliere il senso della
filosofia della storia proposta da Marcuse e Brown:
"Per Keynes, l'arte di vivere, che in un'età di
abbondanza e di tempo libero dovrà prendere il posto dell'arte di accumulare i
mezzi di sussistenza, è un'arte difficile che richiede una raffinata
sensibilità, come quella dei membri del Bloomsbury Group immortalato nell'opera
di Virginia Woolf. Per questo Keynes guarda con terrore all'emancipazione dal
lavoro dell'uomo comune. Ma dal punto di vista di Freud ogni uomo ha gustato il
paradiso del gioco durante l'infanzia; sotto le abitudini al lavoro, in ogni
uomo c'è l'immortale istinto del gioco. Nell'inconscio rimosso esistono
già le fondamenta su cui costruire l'uomo del futuro; non bisogna crearle
dal nulla, basta recuperarle." (Brown, La vita contro la morte. Il
significato psicoanalitico della storia , Garzanti, Milano 1986, p.53)
"nel nostro tentativo di mettere in luce la portata e i
limiti della repressività che domina nella civiltà contemporanea, dovremo
descriverla nei termini dello specifico principio della realtà che ha
governato le origini e la crescita di questa civiltà. Gli abbiamo dato il
nome di principio di prestazione per dare rilievo al fatto che
sotto il suo dominio la società si stratifica secondo le prestazioni economiche
(in regime di concorrenza) dei suoi membri. (Marcuse, Eros e civiltà,
Einaudi, Torino 1968, p. 87)
"Il pretesto della penuria , che
ha giustificato la repressione istituzionalizzata fin dai
suoi inizi, diventa meno plausibile man mano che le conoscenze dell'uomo e il
suo controllo della natura aumentano i mezzi per soddisfare i bisogni umani con
una fatica minima"(Marcuse, Eros e civiltà, p. 127)
"Il regno della libertà è prospettato
come al di là del regno della necessità : la libertà non sta
nella 'lotta per l'esistenza', ma al di fuori di questa. Il
possesso e la conquista dei mezzi necessari all'esistenza, sono il
prerequisito, più che il contenuto, di una società libera. Il regno della
necessità, del lavoro faticoso, manca di libertà poiché in questo regno
l'esistenza umana è determinata da obiettivi e funzioni che non le sono propri,
e che non consentono il libero gioco delle facoltà e dei desideri
dell'uomo." (Marcuse, Eros e civiltà, p. 213)
"Quanto più completa è l'alienazione del lavoro, tanto
maggiore è il potenziale di libertà: l'optimum sarebbe un'automatizzazione
totale. E' la sfera al di fuori del lavoro che determina la libertà e
la realizzazione, ed è la possibilità di determinare l'esistenza umana in base
ai valori di questa sfera che costituisce la negazione del principio di
prestazione." (Marcuse, Eros e civiltà, p. 181)
"Se Prometeo è l'eroe civilizzatore della fatica, della
produttività e del progresso per mezzo della repressione, i simboli di un altro
principio di realtà vanno cercati al polo opposto . . . Orfeo e Narciso sono
simboli di realtà, esattamente come Prometeo . . . Ora siamo in grado di
trovare qualche conferma della nostra interpretazione nel concetto freudiano
di narcisismo primario . . . con esso, si rivelò l'archetipo
di un'altra relazione esistenziale con la realtà . Il
narcisismo primario è più che autoerotismo; esso assorbe l' 'ambiente'
integrando l'Io narcisistico col mondo oggettivo. . . [in quanto sentimento di
estensione senza limiti, e identità con l'universo (senso oceanico)] il
narcisismo può contenere il germe di un differente principio di
realtà."(Marcuse, Eros e civiltà, p. 185-191. Corsivi nel
testo; sottolineature mie)
Il ragionamento è chiaro. Il principio di realtà viene
identificato con il principio di prestazione, cioè con il lavoro. La civiltà si
è potuta sviluppare, a partire dalla sua originaria situazione di penuria, solo
in forza della repressione del principio di piacere: la desessualizzazione del
corpo è stata necessaria per costringere al lavoro. Ma il superamento della
scarsità, determinato dallo stesso capitalismo, rende possibile lo stabilirsi
del nuovo principio di realtà, il ritorno del rimosso. La condizione di una
società liberata è che vengano recuperati gli istinti infantili repressi, che
spingono verso l'autosoddisfazione e la fusione con l'altro.
In un saggio di qualche anno fa, raccolto recentemente in
volume ("Beyond Drive Theory: Object Relations and the Limits of Radical
Individualism", in Theory and Society, n. 13, 1985, ora
in Feminism and Psychoanalytic Theory , Polity Press, Oxford
1989), Nancy Chodorow ha sviluppato una critica distruttiva di queste tesi, che
rivela insospettate convergenze con il filo di discorso che sto perseguendo.
Secondo la Chodorow, Marcuse e Brown assolutizzano il punto
di vista del bambino. In tal modo, non si rendono conto che il principio di
realtà non è integralmente riducibile ad una civilizzazione repressiva basata
sul principio di prestazione. Esso è anche, ed in primo luogo, la soggettività
di altri - per il bambino, la soggettività della madre. I bisogni degli altri
divengono un problema solo per l'adulto, e nel corso del processo di
crescita.
Negando l'altro, si nega in primo luogo la donna. Svalutando
la relazione sessuale di tipo 'genitale', Marcuse e Brown concepiscono il
piacere soltanto in quanto non separazione dall'oggetto d'amore: ma è proprio a
partire dalla separazione che è possibile l'incontro con i desideri dell'altro,
che acquistano quasi la stessa importanza dei propri. Ancora, il rifiuto
dell'elemento procreativo nella sessualità (che entrambi gli autori riprendono
da Nietzsche) esprime una negazione dell'esperienza della maternità (e, più in
generale, della genitorialità), la quale richiede un agire che combina
razionalità teleologica, senso della realtà, accoglimento dei bisogni dell'altro.
La donna è qui negata, dunque, tanto come soggetto di desiderio, quanto come
madre-persona che insieme gratifica e limita l'onnipotenza infantile. Al più
compare - sulla scorta di Totem e tabù di Freud - come oggetto
sessuale (proprietà comune della donna); o viene, addirittura, annullata in
quanto singola ed identificata con il mondo (senso oceanico), in una fusione
che configura una relazione asimmetrica di asservimento dell'altro a sé.
Non a caso, rileva la Chodorow, gli eroi di Marcuse e
Brown sono Orfeo e Narciso: uomini che incorporano in sé il femminile, ma non
hanno relazioni con donne. La liberazione, in questa prospettiva di
individualismo radicale, è in primo luogo liberazione dall'altro, dalla donna
(un individualismo da cui, sia detto tra parentesi, non sfugge, come vorrebbe,
la critica che alla "cultura del narcisismo" viene da autori come
Cristopher Lasch, i quali, contrariamente a Marcuse e Brown, imputano alla
società contemporanea l'allentarsi delle forme di controllo culturale tradizionale;
ma in fondo non stupisce che ad un "es" asociale si contrapponga un
"super-io" altrettanto asociale). Su queste basi, di rifiuto del
processo di crescita e del principio di realtà, il recupero del narcisismo
primario difficilmente può far da base ad una teoria della società non
individualistica, ed a suo modo repressiva.
All'opposto, psicoanalisi e femminismo possono essere visti
come l'affermazione di una diversa fondazione psicoanalitica per una teoria
sociale alternativa: si tratta di rifarsi ad un "individualismo
relazionale", che sottolinei come gli individui siano costituiti dalle
relazioni con gli altri, a partire da quella primaria con la madre. La nostra
struttura psichica è sin dal principio costruita socialmente. I soggetti possono
sfuggire all'alternativa tra solipsismo e fusione, se accettano la separazione
e una "matura dipendenza" dall'altro come condizione della propria
individuazione e del perseguimento del proprio desiderio.
Da questo punto di vista, si potrebbe dire che tanto la visione
della società del futuro come ripresa dei valori tradizionali à la
Del Noce quanto il ritorno della natura istintuale à la
Marcuse-Brown condividono, sia pure in forma a loro peculiare, la prospettiva
smithiana dell' "uomo solo". Con la specificazione, ora, che alla
solitudine dell'individualismo corrisponde un genere sessuale non casualmente
maschile. E si potrebbe forse aggiungere che a partire da questa diversa
prospettiva, fondata su una necessaria intersoggettività e sul ruolo cruciale
della relazionalità (a partire da quella primaria e fondamentale, quella con la
madre), sarebbero possibili diverse filosofie della storia. Per esempio,
sarebbero possibili una visione della storia che vede nell'intersoggettività e
nella relazionalità (appunto, se si vuole, perché ha origine in un legame
apparentemente "naturale" come quello madre-figli) un tratto
permanente, che porta dunque a criticare tutte le filosofie che trascurano tale
elemento; oppure una visione della storia che interpreta l'intersoggettività e
la relazionalità (e, addirittura, la stessa relazionalità "materna")
come un prodotto storico - una posizione che evidentemente finirebbe con
l'intersecare le tesi di Marx.
In effetti, se il discorso su Marx che ho svolto nelle
sezioni che precedono ha una qualche plausibilità, la natura umana resa
possibile dal capitalismo ha caratteri sorprendentemente simili a quelli
indicati dalla Chodorow: in particolare, una essenziale socialità
dell'individuo (nel lavoro), una intrinseca relazionalità, che rende ormai
improponibile il paradigma dell' "uomo solo". Non può non colpire la
corrispondenza tra la descrizione che Marx dà - nei suoi "Estratti
dagli Élémens d'économie politique di James Mill", del
1844 - di un lavoro autenticamente umano, e quella che la Chodorow offre di una
relazione sessuale e di una maternità (e paternità) mature. Sia l'una che
l'altra sottolineano come l'altra persona entri in qualche misura realmente
dentro di noi; come l'individuo sia, davvero, anche comunità:
"Supponiamo d'aver prodotto in quanto uomini: ciascuno
di noi avrebbe, nella sua produzione, affermato doppiamente se
stesso e l'altro. Io avrei 1) oggettivato, nella mia produzione, la
mia individualità e la sua peculiarità, ed avrei
quindi goduto, nel corso dell'attività, una manifestazione individuale della
vita, così come, contemplando l'oggetto, avrei goduto della gioia
individuale di sapere la mia personalità come oggettuale, sensibilmente
visibile e quindi come una potenza elevata al di sopra di
ogni incertezza. 2) Nel tuo godimento o uso del mio prodotto io avrei immediatamente il
godimento consistente nella consapevolezza di aver soddisfatto col mio lavoro
un bisogno umano, e dunque d'aver oggettualizzato l'essenza umana ed
aver quindi procurato un oggetto atto a soddisfare il bisogno di un altro
essere umano. 3) D'essere stato per te l' intermediario fra
te ed il genere, e dunque di venir inteso e sentito da te stesso come
un'integrazione del tuo proprio essere e come una parte indispensabile di te
stesso, di sapermi dunque confermato tanto nel tuo pensiero quanto nel tuo
amore. 4) D'aver posto immediatamente nella mia individuale manifestazione di
vita la tua manifestazione di vita, e dunque d'aver confermato
e realizzato immediatamente nella mia attività la mia vera
essenza, la mia essenza comuneed umana."(Marx, Opere ,
vol. III, 1843-1844, Editori Riuniti, Roma, p. 247. Corsivi nel testo)
Una descrizione che, d'altronde, è ripetuta da Marx
nei Manoscritti, con termini quasi identici, in riferimento al
rapporto dell'uomo alla donna: quel rapporto "da cui si può, dunque,
giudicare ogni grado di civiltà dell'uomo"; quel rapporto in cui si mostra
"fino a che punto l' altro uomo come uomo è divenuto un
bisogno per l'uomo, e fino a che punto l'uomo, nella sua esistenza la più
individuale è a un tempo comunità."(Manoscritti, p. 225. Corsivi
nel testo)
La visione di Marx è, insomma, caratterizzata da un
pessimismo non lontano da quello di Freud. L'essere umano, per vivere, deve
trasformare, ma perciò anche in una certa misura dominare, una natura esterna a
sé; il lavoro a sua volta, cioè la realizzazione della propria natura storica,
comporta una rinuncia al pieno dispiegarsi della propria natura istintuale. E'
in questa rinuncia, peraltro, che l'essere umano può raggiungere la sua
autentica umanità - una umanità definita, come abbiamo visto, non
metastoricamente, ma nell'attuale e contraddittorio svolgersi della dinamica
capitalistica. E' in questa rinuncia, ancora, che l'essere umano diviene
davvero un essere sociale, un individuo segnato ab origine dalle relazioni con
gli altri.
La prospettiva di Marx non può allora essere la negazione
del lavoro, o la sua riduzione a gioco, come vorrebbe Marcuse: semmai, la sua
integrazione con le altre facoltà umane, quali la contemplazione e il piacere.
La libertà reale non si nega ma si afferma in quel "superare gli
ostacoli" che è tipico del lavoro. Lo stesso lavoro caratterizzante il
regno della necessità - le necessità della riproduzione materiale al livello
dato delle forze produttive e delle relazioni sociali - può divenire lavoro
libero, autorealizzazione dell'individuo:
"Il lavoro di produzione materiale può acquistare
questo carattere solamente 1) se è posto il suo carattere sociale,
2) se è di carattere scientifico, e al tempo stesso è lavoro universale,
se è sforzo dell'uomo non come forza naturale appositamente addestrata, bensì
come soggetto che nel processo di produzione non si presenta in forma meramente
naturale, primitiva, ma come attività regolatrice di tutte le forze
naturali." (Grundrisse, II, p. 278-279)
L'atto d'accusa di Marx al capitalismo è, appunto, quello di
avere creato le condizioni di possibilità di questo sviluppo universale e
relazionale dell'essere umano, mentre al tempo stesso ne impedisce la realizzazione.
La società contro cui Marx si scaglia non schiaccia i diritti dei lavoratori:
più radicalmente, ne violenta la natura. E', in questo senso - ormai del tutto
alieno alla filosofia politica anglosassone - una società non giusta.
Un punto colto lucidamente da un'autrice estranea al canone
classico del marxismo, come Simone Weil. Il linguaggio dei diritti, scrive, può
forse essere adeguato al rapporto tra acquirente e venditore sul mercato delle
merci. Non alla condizione del lavoratore dentro la fabbrica nel regime
attuale, in tutto analoga a quella di una giovane donna condotta al bordello:
"chiunque parlasse in tal caso dei suoi diritti utilizzerebbe una parola
che suona ridicolmente inadeguata." ("La Personne et le sacré",
in Ecrits de Londres et dérnieres lettres, Gallimard, Paris 1957)
8. Dobbiamo disperare? Ancora su Marx, tra macchine e
antagonismo.
"Compito della conoscenza è: non capitolare dinanzi
alla realtà, che come una parete di pietra circonda gli uomini. E poiché la conoscenza
rimette in vita i processi storici umani ormai spenti nei fatti compiuti, essa
dimostra che la realtà è un prodotto degli uomini e perciò trasformabile: così
il concetto più importante della conoscenza, la prassi, si rovescia nel
concetto di azione politica"
Alfred Schmidt, Il concetto di natura in Marx ,
Laterza, Bari 1973, p. 189
Vorrei proporre una terza interpretazione del suggerimento
di Napoleoni che individua come "compito" una ridefinizione della
nozione stessa di economia; una interpretazione in sintonia con quel Marx che
mantiene al lavoro, anche materiale, un ruolo essenziale oltre il
capitalismo.
Si può partire da questo giudizio, contenuto nello stesso
testo in cui quel suggerimento è avanzato:
"La produzione come dominio è la 'fissazione' in senso
psicotico; l'ossessione del superamento di ogni e possibile scarsità: sempre,
senza che questo abbia fine. Ecco: qui c'è proprio la possibilità di un momento
di riflessione razionale; e quindi di ricostruzione di un'economia - e
perciò di una regola - che si dovrebbe dare all'intenzionalità morale
- che comunque non può mancare ogni volta che si parla di 'compito' - un
punto di riferimento che non sia solo uno scatenamento soggettivistico."
(La libertà del finito, p. 23)
Come intendere questa "regola" - questo principio
di realtà, dunque, che non si contrappone, ma nemmeno si identifica, con il
principio di piacere, configurando uno 'scatenamento soggettivistico'? Credo si
tratti di intendere questa "regola" in continuità con queste altre
osservazioni che Napoleoni formula, proprio criticando la visione di Stuart
Mill e di Keynes di una fine del primato dell'economico da intendersi come
uscita dal lavoro:
"Che il lavoro sia un fatto puramente negativo, un mero
costo, rispetto al quale non si potrebbe porre altro problema che quello di
liberarsene, è un'immagine che sorge appunto sulla base della storia
data. Se questa storia viene criticata, se quindi non si pensa
che essa sia stata l'espressione compiuta delle facoltà umane, allora si può
pervenire all'idea che il lavoro non soltanto potrebbe essere cosa diversa da
ciò che è stato finora, ma potrebbe anzi essere l'attività mediante la quale
l'uomo si realizza nella sua 'libertà e felicità'. Entro questa impostazione,
lo stesso processo di 'liberazione' dal lavoro a cui il capitalismo darebbe
luogo . . . comporta un giudizio diverso da quelli che si è portati a dare
sulla base di un'impostazione, per intendersi, smithiana: si dovrebbe infatti
dire che ciò a cui quel processo perverrebbe sarebbe una situazione di 'tempo
libero' che gli uomini, appunto perché negati nella loro personalità quando
lavorano, non saprebbero come riempire, fino a giungere (e l'esperienza dei
paesi più sviluppati ne dà una conferma) alla disperazione. Questo significa
che il traguardo di un lavoro come attività libera e realizzatrice (che, come
tale, potrebbe addirittura diventare, nell'immagine datane da Marx, il 'primo
bisogno') non dovrebbe essere spostato in un futuro indeterminato, ma dovrebbe
essere preparato fin da ora." (Elementi di Economia politica, 3°
edizione, La Nuova Italia, Firenze 1980, p. 219-220)
Una diversa economia presuppone, al tempo stesso, un lavoro
diverso e un diverso "consumo" - una diversa produzione, insomma, è
la condizione di un autentico recupero delle dimensioni della contemplazione e
del piacere. Credo che quest'ultima lettura sia la più fedele alle intenzioni
di Napoleoni. Pure, penso che non sia senza significato che anche le precedenti
interpretazioni abbiano comunque una qualche plausibilità. Le oscillazioni del
Napoleoni più recente trovano infatti la loro origine in difficoltà della
posizione di Marx, e nel particolare contesto storico-sociale in cui ci
troviamo.
Per quanto riguarda Marx, si tratta di ciò. Un lavoro
diverso nel "regno della necessità" richiede per lui che i soggetti
siano in grado di riappropriarsi della propria produttività sociale alienata al
capitale, del sapere sociale generale, che si erge loro contro nella forma di
macchine usate capitalisticamente allo scopo di estrarre il massimo possibile
di plusvalore. Marx, ovviamente, sa benissimo che l'introduzione delle macchine
è determinata dall'antagonismo fondamentale tra capitale e lavoro. La ricchezza
capitalistica è il pluslavoro, il tempo di lavoro vivo erogato dai lavoratori
produttivi in eccesso rispetto al lavoro oggettivato nel salario reale che essi
percepiscono: ma perché questa ricchezza sia ottenuta, il capitalista deve
garantirsi sia che il lavoro sia effettivamente prestato, sia che sussista una
differenza "soddisfacente" tra valore d'uso e valore di scambio della
forza-lavoro. Le macchine sono appunto disegnate in modo da sottrarre il più
possibile agli operai il controllo della prestazione lavorativa trasferendolo
all'impresa, e da consentire lo sfruttamento massimo.
Se le cose stanno così, però, ci si può chiedere in che
misura sia possibile distinguere tra un uso capitalistico ed un uso non
capitalistico delle macchine. Come Marx stesso sembra sospettare, il processo
storico che ha dato nascita ad un determinato tipo di base tecnica della
produzione segna quest'ultima in modo indelebile. "Quelle" macchine
non potranno essere impiegate altrimenti che per il dominio delle cose
sull'essere umano.
D'altro canto, si potrebbe sostenere con molte ragioni che
la missione storica del capitale è la costituzione delle condizioni del lavoro
sociale non dal lato oggettivo - dal lato della scienza e della tecnica - ma
dal lato soggettivo. L' "individuo relazionale" costruito nella
produzione non sarebbe allora altri che il lavoratore, non in quanto
singolo ma in quanto collettività solidale che lotta per l'eguaglianza e
l'autonomia contro il meccanismo sociale che lo sfrutta. Se si vuole: l'unico
comunismo realmente conosciuto è il tempo libero, l'ozio produttivo, la
dignità, riconquistati qui ed ora, dentro e fuori dai luoghi di lavoro, da chi
ha lottato contro un sistema che annulla le soggettività. Un comunismo la cui
legge di movimento è stata sinora quella di procedere attraverso
sconfitte. Ma qui la difficoltà si presenta in altra forma: il processo
capitalistico, che nasce dall'antagonismo, tende però sistematicamente ad
abolirlo. Da questo punto di vista, Marx non può che dar ragione a Ricardo:
immanente al sistema capitalistico è il periodico tentativo di ridurre il
lavoratore ad elemento della produzione in tutto analogo al bestiame; a merce
che produce altre merci.
La realtà italiana degli anni ottanta può essere
interpretata come un'illustrazione storica esemplare di tutto ciò. Ha rivelato
nei fatti la capacità del sistema capitalistico di abbattere una opposizione
operaia interna ed antagonistica al processo produzione della ricchezza
sociale. Lo strumento di questa distruzione di soggettività è stato un salto
tecnologico. E' il "progresso" nel sistema di macchine ad avere non
soltanto espulso donne e uomini dalla fabbrica, ma ad avere ridotto ad atomo
chi vi rimaneva. Su questo sfondo, non stupisce che la prospettiva marxiana di
integrazione tra lavoro e bisogni vada persa; che il soggetto possa essere recuperato
solo fuori dal lavoro. Ma non è detto, come oggi troppo facilmente si pensa,
che sia una strada senza ritorno.
La liberazione di tempo per la società cui
stiamo assistendo si fonda, come altre volte nella storia del capitale, su
quella negazione di umanità dentro il processo di produzione materiale che è, a
detta di Simone Weil, un autentico sacrilegio compiuto sulla carne e lo spirito
dei lavoratori. La domanda che essa si pose all'inizio degli anni trenta è
ancora la nostra: "Dobbiamo disperare, allora?". Così,
credo, deve esserlo la sua risposta: "Certamente, non ce ne mancherebbero
le ragioni . . . ma, d'altro canto, la nostra debolezza può impedirci di
vincere, ma non di comprendere la forza da cui siamo abbattuti. Nulla al mondo
può impedirci di pensare chiaramente." (Simone Weil, "Perspectives.
Allons nous vers la révolution prolétarienne?" in Révolution
prolétarienne, n. 158, 25 agosto 1933).
Nota bibliografica
Può essere di qualche utilità indicare i testi che più
strettamente mi sono stati di ausilio nel delineare il percorso logico della
mia argomentazione. Un contributo di grande rilievo sui temi qui trattati è il
capitolo "Economia e filosofia" di Claudio Napoleoni, in Filosofia.
Storia del pensiero occidentale, diretta da Emanuele Severino, Armando
Curcio editore, Milano 1987. Di Napoleoni, come è ovvio, ho anche tenuto
presente il capitolo su Smith in Smith, Ricardo, Marx, Boringhieri,
Torino 1970.
La mia lettura di Smith - che non ha esclusivamente pretese di
maggiore correttezza filologica, ma anche e soprattutto l'obiettivo di
illuminare aspetti del suo pensiero centrali e pure trascurati dalla vulgata
liberista - ha come riferimento principale più la letteratura secondaria
sull'economista scozzese prodotta da filosofi politici, antropologi, e storici,
che non le interpretazioni avanzate tra gli economisti. Si vedano, per esempio,
per quanto riguarda i filosofi politici Wealth and Virtue. The Shaping
of Political Economy in the Scottish Enlightenment, edited by Istvan Hont e
Michael Ignatieff, Cambridge University Press, Cambridge 1983 (di Ignatieff va
citato anche lo splendido I bisogni degli altri. Saggio sull'arte di
essere uomini tra individualismo e solidarietà, Il Mulino Bologna 1986),
che vede nella "mano invisibile" ciò che concilia disuguaglianza
sociale e assistenza ai più poveri; e per quanto riguarda gli antropologi Louis
Dumont, Homo aequalis. 1. Genesi e trionfo dell'ideologia economica,
Adelphi, Milano 1984 (ed. orig. 1977), il quale individua in Smith una tensione
tra un momento ontologico e naturalistico che rimanda al primato della
produzione e del lavoro dell'uomo isolato, e un momento sociale in cui il
valore di scambio è determinato sul mercato.
Tra i numerosi lavori di storici, segnalo in particolare
Maxine Berg, The age of manufactures. Industry, innovation and work in
Britain 1700-1820, Fontana Press, London 1985, per quanto riguarda la
questione delle diverse vie all'industrializzazione, e E.A.Wrigley, People,
Cities and Wealth. The Transformation of Traditional Society, Blackwell,
Oxford 1987, per quanto riguarda i limiti naturali allo sviluppo. Parte da
questi due testi l'ottima rassegna critica di Maria Luisa Pesante, "La
rivoluzione industriale, gli storici, e la ingannevole concretezza dei
classici", in Metamorfosi, seconda serie, n. 8, 1988 (di
Pesante ho anche tenuto presente - non soltanto per quanto riguarda le sezioni
su Smith, ma anche quella dedicata a John Stuart Mill e a John Maynard Keynes -
il non facile ma stimolante Economia e politica, Franco Angeli,
Milano 1986). Va visto anche, pur con qualche forzatura, David McNally, Political
Economy and the Rise of Capitalism. A Reinterpretation, University of
California Press, Berkeley 1988, che a partire dalle posizioni controverse di
Robert Brenner sulla transizione dal feudalesimo al capitalismo vede in Smith
piuttosto il campione di un capitalismo agrario che non l'interprete della
rivoluzione industriale.
Tra le analisi di Smith avanzate da economisti me ne sono
state utili due che non a caso fanno storia a sé: quella ormai classica di
Giulio Pietranera, La teoria del valore e dello sviluppo capitalistico
in Adam Smith, Feltrinelli, Milano 1963, e quella più recente di Carlo
Benetti, Smith. La teoria economica della società mercantile, Etas,
Milano 1979. Un'attenzione alle molteplici sfaccettature della filosofia morale
di Smith è suggerita da Amartya Sen, Etica ed economia, Laterza,
Roma-Bari 1988 (ed. orig. 1987). Il lettore economista intuirà una qualche
consonanza tra quanto sostengo e quanto scrive Albert O. Hirschman,
"Interpretazioni rivali della società di mercato: civilizzatrice,
distruttiva o debole?", in Idem, L'economia politica come scienza
morale e sociale, con un saggio di Luca Meldolesi, Liguori, Napoli
1987, per quanto riguarda in particolare la tesi del doux commercee
la tesi dell'autodistruzione (su questo libro, e su Hirschman più in generale,
si veda la mia recensione su questa rivista, "Hirschman: domande e
inquietudini", Teoria politica, n. 1, 1988). Ovviamente, di
Hirschman rimane fondamentale il suo Le passioni e gli interessi.
Argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo trionfo,
Feltrinelli, Milano 1979 (ed. orig. 1977), recentemente ristampato. Un cenno va
fatto anche all'articolo di Nathan Rosenberg, "La divisione del lavoro in
Adam Smith: due concezioni o una?", originariamente apparso su Economica nel
1965 e ora incluso in L'economia classica. Origini e sviluppo
(1750-1848), a cura di Riccardo Faucci ed Enzo Pesciarelli, Feltrinelli, Milano
1976.
Due monografie di impianto marxiano muovono anch'esse alcuni
passi in direzione della linea che ho esposto. Si tratta di Norman
Fischer, Economy and Self. Philosophy and Economics from the
Mercantilists to Marx, Greenwood Press, Westport, Connecticut 1979, e
soprattutto, di David Levine, "Political Economy and the Argument for
Inequality", numero monografico di una rivista americana molto
valida ma poco conosciuta (Social Concept, September 1985). Si vedano
anche, sulla stessa rivista, i commenti al saggio di Levine di Anna Yeatman e
Greeg O. Kvistad (June 1986), ed il dibattito tra David Gleicher e David F.
Weiman sulle origini della teoria classica del valore (March 1985).
Su Stuart Mill, a parte i testi già richiamati, va vista
soprattutto l'introduzione di Giacomo Becattini ai Principi di economia
politica, Utet, Torino 1983. Per quanto riguarda Keynes, pur nella
differenza di alcune valutazioni mi è stato di notevole stimolo lo scritto di
una anglista: Alessandra Marzola, Retorica e immaginario nel discorso
economico e politico di J.M.Keynes, raccolto in AA.VV., L'altro
Keynes: linguaggio ed economia, Pierluigi Lubrina editore, Bergamo 1990.
Tra Stuart Mill e Keynes salta agli occhi l'assenza (del tutto ingiustificata)
di Alfred Marshall, che pure alle questioni qui trattate dedicò non poco spazio
nella sua riflessione. Anche in questo caso rimando a Giacomo Becattini,
"Mercato e comunismo in Alfred Marshall", in Teoria dei
sistemi economici, a cura di Bruno Jossa, Utet, Torino 1989. Qualche
ragione ha invece la non considerazione di Karl Polanyi, la cui critica
all'identificazione della nozione di economia (valida per società non di
mercato) con il concetto di "economico" (modellato sulle categorie
della scienza economica) segnala una rottura più drastica con la
problematica smithiana di quanto non sia il caso degli altri autori analizzati.
La trattazione anche di Marshall e Polanyi avrebbe allungato eccessivamente un
articolo già non breve.
La sezione su Marx riprende e sviluppa alcune tesi che avevo
già sostenuto in "Il concetto di lavoro in Marx", in Ricerche
economiche, n. 3-4, 1979, e in "L'enigma del lavoro", Collegamenti,
n. 23-24, 1989, dove si trovano più dettagliati riferimenti bibliografici.
L'interpretazione che avanzo, oltre che ai lavori di Alfred Schmidt, si
appoggia sulla ricostruzione della teoria marxiana suggerita nei primi anni
settanta da Lucio Colletti e da Claudio Napoleoni in scritti largamente noti
(ho provato a dare una sintesi delle posizioni del Napoleoni di quel periodo
in Un programma di ricerca incompiuto. La ripresa dell'economia
politica critica in Claudio Napoleoni: 1970-1976, relazione al Convegno
"La lezione di Claudio Napoleoni. Politiche, teorie economiche, e critica
dell'economia", Rovigo, 27-28 maggio, di prossima pubblicazione, a cui
rimando per ulteriori indicazioni bibliografiche). Debbo però almeno ricordare
la lucida introduzione di Cristina Pennavaja a Karl Marx, L'analisi
della forma di valore, Laterza, Roma-Bari 1976, che sottolinea l'importanza
della distinzione marxiana tra "divisione del lavoro
naturale-spontanea" e "divisione del lavoro naturale-spontanea
sociale". Più in generale, questa introduzione è un ottimo frutto di una
fase di rinascita di studi marxisti in Italia sull'onda delle traduzioni di
lavori fondamentali quali quelli di Rubin, Rosdolsky, Reichelt, Sohn-Rethel,
Krahl, Backhaus; fase ormai lontana, e che contrasta con la superficialità
della discussione attuale. Sulla concezione della storia di Marx sono di grande
chiarezza le poche pagine del capitolo "Social change" contenute nel
volume di Wal Suchting, Karl Marx: An Introduction, Wheatsheaf
Books, Brighton 1983.
La tensione tra un Marx affascinato dal dinamismo esasperato
e distruttore del capitalismo e un Marx critico dell'atomizzazione borghese,
cui egli contrappone un agire collettivo e i vincoli comunitari prodotti
contraddittoriamente dallo stesso capitalismo, deve molto al bel libro di
Marshall Berman, L'esperienza della modernità, Il Mulino, Bologna
1985 (ed. orig. 1982). La "soluzione" che suggerisco alla
contraddizione individuata da Berman - "se la visione globale della
modernità [di Marx] è esatta, perché le forme di comunità prodotte
dall'industria capitalistica dovrebbero rivelarsi più solide di qualsiasi altro
prodotto capitalistico? Tali collettività non potrebbero dimostrarsi, come
qualsiasi altro elemento di questo contesto, meramente temporanee, provvisorie,
forgiate per invecchiare?" - consiste proprio nella possibilità e
desiderabilità che la comunità operaia antagonista si percepisca quale è, cioè
autodissolventesi essa stessa, e sia dunque capace di far spazio all'altro da
sé, in significativo contrasto con la totalità capitalistica. E' una soluzione
che non fa altro che sviluppare un suggerimento dello stesso Marx in "La
sacra famiglia" ("Se vince, il proletariato non diventa perciò il
lato assoluto della società; infatti esso vince solo togliendo se
stesso e il suo opposto"), e che ripropone l'autentico nodo
problematico della teoria politica comunista: la necessità cioè di tenere
insieme la centralità del lavoro salariato nella teoria della crisi sociale del
capitalismo, riconoscendo la "gerarchia" reale presente nell'attuale
costituzione della società, e la pari dignità dei soggetti quale base materiale
di una autentica democrazia - qualcosa che fa confusamente capolino nel
dibattito attuale su eguaglianza e differenze.
Un inquadramento delle diverse posizioni di Claudio
Napoleoni che richiamo nel testo all'interno del suo itinerario di riflessione
lo si può trovare nei miei "Un economista critico. Il percorso
intellettuale di Claudio Napoleoni", in Rivista di storia
economica, n. 1, 1989, e "Un' economia politica per la
liberazione", in Il Ponte, n. 3-4, 1989. La posizione
conservatrice di Augusto Del Noce ha una nitida presentazione in Tramonto
o eclissi dei valori tradizionali?, Rusconi, Milano. L'interpretazione di
Franco Rodano è soprattutto consegnata agli articoli pubblicati sulla Rivista
trimestrale. Tra i molti scritti di Toni Negri in cui viene condotta una
lettura antilavorista di Marx segnalo per tutti Marx oltre Marx.
Quaderno di lavoro sui Grundrisse, Feltrinelli, Milano.
La parte finale del mio scritto è molto influenzata, come è
reso del tutto esplicito, da alcune tesi di Simone Weil, di cui, oltre ai testi
citati nel testo, vale la pena di vedere nella stessa linea: Riflessioni
sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale, Adelphi, Milano 1983
(ed. orig. 1955), e la recensione a Materialismo e empiriocriticismo di
Lenin, originariamente pubblicato in La Critique sociale, n. 10,
1933, e ora ristampato in Simone Weil, Oeuvres complètes, II, Écrits
historiques et politiques, tome I: L'engagement syndical (1927-juillet 1934),
Gallimard, Paris 1988. Sul piano interpretativo mi sono stati utili il saggio
di Anna Scattigno, "La volontà di conoscere", originariamente
comparso in Memoria, n. 5, 1982, e ora ripubblicato in Paola
Melchiori-Anna Scattigno, Simone Weil. Il pensiero e l'esperienza del
femminile, la salamandra, Milano 1986 (si tratta della più equilibrata e
attenta introduzione al pensiero della Weil di cui sono a conoscenza), e Peter
Winch, Simone Weil. "The just balance", Cambridge
University Press, Cambridge, 1989. Quest'ultimo testo mette bene in luce la
differenza, e addirittura la possibile opposizione, tra una visione della
filosofia politica incentrata sul linguaggio dei "diritti", quale è
quella del filone oggi egemone e di cui l'esponente più noto è John Rawls,
ruotante attorno ad una nozione astratta ed astorica del "contratto
sociale" stipulato da soggetti autointeressati e calcolanti dietro un
'velo di ignoranza', e il linguaggio della "giustizia" di cui invece
parla la Weil, che rimanda piuttosto in senso forte ad una nozione di
"natura umana" e alla contingenza storica.
Una visione della filosofia morale che recupera anch'essa la
nozione di natura umana, con un minore piglio polemico nei confronti della
tradizione liberale di quanto sia nella Weil, l'ho ritrovata in due libri di
Richard Norman, che mi sono stati di molto aiuto: The Moral
Philosophers. An
Introduction to Ethics, Clarendon Press, Oxford 1983, e Free and Equal. A
Philosophical Examination of Political Values, Clarendon Press, Oxford
1987. Le ultime sezioni di questo lavoro sono anche state influenzate dal giudizio
di Hannah Arendt, che condivido, secondo cui non potrebbe certamente esserci
niente di peggio di una società di lavoratori senza lavoro (Vita activa. La
condizione umana, Bompiani, Milano 1988, ed. orig. 1958, p. 5), giudizio
che però lei impiega erroneamente. Ad Hannah Arendt si deve anche il termine
"ozio produttivo", che utilizzo per designare i momenti di
liberazione che configurano oggi il solo comunismo possibile.
Indice
1. Introduzione.
2. Migliorare la propria posizione. Natura e storia in
Smith.
2.1. La filosofia morale.
2.2. Il problema: ineguaglianza e benessere.
2.3. La soluzione: divisione del lavoro e inclinazione
allo scambio.
2.4. Ancora sulla filosofia morale.
3. Il comando sul lavoro. Individuale e sociale, dallo
stadio rozzo e primitivo alla grande società.
3.1. Il lavoro dell'uomo isolato.
3.2. Lavoro comandato e scambio.
3.3. La ricchezza come potere: lavoro comandato e
diseguaglianza.
3.4. Lavoro comandato e produzione.
3.5. Ancora sulla divisione del lavoro.
4. Il mercato e i "poveri che lavorano". La
giustificazione storica del capitale.
4.1. Mano invisibile ed equità sociale.
4.2. I costi della divisione del lavoro.
4.3. Innaturalità del capitale.
5. Cambiare la natura umana. John Stuart Mill e John
Maynard Keynes, oltre la passione per il denaro.
5.1. Smith smembrato. Ricardiani e neoclassici.
5.2. Lo stato stazionario: John Stuart Mill.
5.3. Il doppio inganno è rivelato: John Maynard Keynes.
6. Come se avesse l'amore in corpo. Marx e l'enigma del
lavoro.
6.1. Il lavoro come essenza dell'essere umano.
6.2. Il lato positivo del capitale. Natura e storia in
Marx.
6.3. Una filosofia della storia?
7. Orfeo e Narciso contro Prometeo. La fuga dal lavoro.
7.1. La positività del finito.
7.2. Tramonto o eclissi dei valori tradizionali?
7.3. Un nuovo principio di realtà? Marxismo e
psicoanalisi.
8. Dobbiamo disperare? Ancora su Marx, tra macchine e antagonismo.
Nota bibliografica.
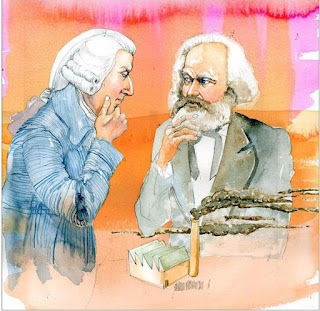
Nessun commento:
Posta un commento