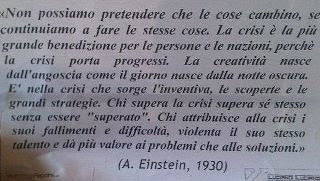[pubblicato in Alternative per il socialismo, n. 30, marzo aprile 2014, p. 77-90] - https://www.sinistrainrete.info/teoria-economica/3507-riccardo-bellofiore-la-socializzazione-degli-investimenti-contro-e-oltre-keynes.html
Le
note che seguono sono nient’altro che appunti, incompleti, sulla
‘socializzazione degli investimenti’: espressione che compare, in
modo cruciale, nell’ultimo capitolo della Teoria
generale di
Keynes. Il termine, negli anni a noi più vicini, è diventato di
moda, soprattutto in una certa sinistra (quella che non si sa più
come chiamare: alternativa, radicale; certo non di classe). Come di
consueto, ciò è avvenuto in modo generico e acritico, all’interno
di una troppo confusa ripresa di Keynes. Essendo stato tra quelli che
la socializzazione degli investimenti la avevano, per così dire, nel
proprio codice genetico da decenni, ma in un senso non poco diverso
dalla lettera dell’economista cantabrigense, ciò che proporrò qui
è un percorso di lettura (spesso costituito da pure e semplici
citazioni, parafrasi), che aiutino ad orientarsi. Seguirà un breve
richiamo agli usi che ne ho proposto in passato, ben prima della
nuova vulgata in
formazione, e qualche considerazione più strettamente teorica e
politica.
Keynes
L’ultimo capitolo del libro del 1936 si apre con la affermazione,
comprensibile ma limitata e discutibile, che i limiti principali
della società economica in cui viviamo son costituiti
dall’incapacità di dar vita al pieno impiego (senza l’intervento
attivo dello Stato) e da una distribuzione inegualitaria della
ricchezza e del reddito (se non vi sono interventi correttivi).
Va
da sé che questi limiti esistono davvero e sono gravi: abbiamo però
qui un esempio di un modo di ragionare che mette al centro del
proprio discorso il plesso domanda-distribuzione, invece di partire,
come sarebbe necessario, da moneta e produzione. Questa ultima è una
lezione che, in fondo, discende da Marx, e che Kalecki (l’economista
polacco che prima di Keynes raggiunse alcuni dei contributi analitici
della Teoria
generale)
non aveva affatto scordato.
Qualche
pagina più oltre, Keynes afferma che lo Stato deve esercitare una
influenza determinante sulla propensione a consumare (per esempio
grazie alla tassazione) e sull’investimento privato (attraverso una
politica monetaria che conduca al ribasso il tasso di interesse di
lungo termine, e conduca all’eutanasia del rentier). Ciò
non sarà sufficiente: Keynes era per varie ragioni convinto di una
tendenza al ristagno nel capitalismo sviluppato, una previsione su
cui fu smentito, e su cui pesavano errori significativi contenuti
nella sua costruzione teorica. Ne traeva perciò la conclusione che
fosse opportuna una significativa ‘socializzazione
dell’investimento’, unico strumento in grado di condurci nella
zona della piena occupazione delle risorse produttive, incluso il
lavoro.
Keynes qualificava però subito il suo discorso. Erano da approvare
tutti i ‘compromessi’ e gli strumenti grazie ai quali l’autorità
pubblica potesse cooperare con l’iniziativa provata (privata). La
‘socializzazione’ che proponeva andava non solo distinta dalla
nazionalizzazione (la proprietà dei mezzi di produzione non era così
importante, sosteneva). Essa era in contrasto netto con il socialismo
di Stato. Per questo definiva la teoria esposta nel libro come
moderatamente conservatrice nelle sue implicazioni. Certo, alcuni
‘controlli’ andavano stabiliti: ma ‘bastava’ che lo Stato,
gradualmente e senza alcuna ‘rottura’ nelle tradizioni della
società, muovesse le sue leve tanto quanto era necessario a indurre
una piena utilizzazione di capitale e lavoro. A quel punto la teoria
tradizionale, neoclassica, tornava ad essere del tutto accettabile, e
non si poteva obiettare alle sue tesi sul come gli interessi privati
guidassero l’allocazione ottimale delle risorse.
Non
vi è ragione alcuna per supporre che il presente sistema determini
una cattiva distribuzione delle risorse, sostiene Keynes. Se 10
milioni di lavoratori potrebbero essere occupati, e solo 9 lo sono,
il problema è trovare occupazione al milione rimanente, non
destinare ad altri lavori i 9 milioni di occupati dalle forze del
mercato. E’ nel determinare il volume, e non la direzione,
dell’occupazione effettiva che il sistema attuale fallisce. Un
discorso che non si può certo accusare di oscurità.
Michał Kalecki
Michał Kalecki aveva colto con lucidità alcuni problemi nel
discorso di Keynes. Era certo possibile che, sulla carta, i
capitalisti potessero guadagnarci, e non poco, con politiche di pieno
impiego: una più elevata massa dei profitti poteva davvero essere il
correlato di una più alta occupazione dei lavoratori. Non era dunque
il riformismo una opzione attraente, in grado di aprire la strada ad
un ‘compromesso’ tra le classi? La stessa teoria di Kalecki -
nella sostanza già formulata prima del 1936 in saggi in polacco, e
derivata da un uso creativo degli schemi di Marx via Luxemburg e
Tugan Baranovski - chiariva che (in una società capitalistica pura,
dove i lavoratori consumano integralmente il salario) la massa dei
profitti è identica a (e causata da) investimento e consumo dei
capitalisti. Dato il grado di monopolio (la quota dei profitti lordi
sul reddito, in fondo riconducibile al saggio di sfruttamento), se ne
poteva derivare il livello di produzione complessiva, e dunque di
occupazione.
Se
lo Stato fosse intervenuto con una spesa pubblica in disavanzo
(magari finanziata con nuova moneta: o direttamente via istituto di
emissione, o indirettamente via banche commerciali), ciò avrebbe
avuto lo stesso effetto che la Luxemburg aveva attribuito alle
esportazioni (nette) in aree non capitalistiche: per questo le aveva
definite esportazioni ‘interne’ o ‘domestiche’. D’altronde,
la stessa Luxemburg, aveva in qualche misura anticipato conclusioni
keynesiane nel caso in cui la spesa pubblica fosse stata di sostegno
al militarismo. E questa era, in qualche misura, la conclusione di
Kalecki. Il capitalismo ‘keynesiano’ a venire sarebbe stato
incentrato sulla spesa militare. Un capitalismo di pieno impiego era
possibile, ma non su base permanente. Se raggiunto, uno stato di
piena occupazione avrebbe ridotto, sia il controllo capitalistico
sulla composizione della spesa (e dunque della produzione), sia il
controllo sulla classe operaia interno ai processi di lavoro
(favorendo episodi di insubordinazione operaia), con conseguente
richiesta di migliori condizioni per i lavoratori dentro e fuori la
produzione. Più che la lotta sul salario, era questo conflitto (o
forse antagonismo) che poteva garantire risultati, nella logica
kaleckiana. L’ostilità della classe capitalistica al pieno impiego
si traduceva in un ‘ciclo economico-politico’: quando ci si
avvicinava al pieno impiego le politiche keynesiane sarebbero state
usate all’incontrario, per ricostituire l’esercito industriale di
riserva.
Joan
Robinson
L’attacco
più violento al keynesismo ‘realmente esistente’ viene nel 1972
da Joan Robinson, una keynesiana di sinistra (oggi verrebbe definita
una postkeynesiana, versante inglese). Le sue parole non lasciano
dubbi sul fatto che è lo stesso Keynes del capitolo finale
della Teoria
generale ad
essere, almeno in parte, direttamente coinvolto nella critica. Un
articolo che ho ben presente, perché è stato uno dei primissimi che
ho letto, poco dopo la sua pubblicazione, all’inizio dei miei studi
di economia.
Robinson
sostiene che nei primi anni Settanta si era nel bel mezzo di una
‘seconda’ crisi della teoria economica. La ‘prima’ è quella
da cui emerge, negli anni Trenta, la ‘rivoluzione keynesiana’
(titolo di un libro allora famoso di Lawrence Klein, del 1947, tratto
dalla sua tesi di Ph.D. al MIT, nel 1944: quando prese il dottorato
Klein, Premio Nobel nel 1980, era iscritto al partito comunista, il
che spiega il capitolo del suo libro in cui compara Keynes e Marx).
La prima crisi ruotava attorno al nodo del livello dell’occupazione,
il fallimento del laisser
faire per
insufficienza di domanda effettiva. La seconda crisi era tutta
diversa, e investiva di petto le carenze della teoria dominante nel
trattare il nodo del contenuto dell’occupazione. Era una crisi sul
terreno anche della distribuzione. Per chi leggeva l’articolo della
Robinson nella Torino dei primi anni Settanta - a contatto con i
lavoratori che contestavano ormai apertamente non soltanto il ‘per
chi’ ma anche il ‘cosa’ si produceva, oltre che il ‘come’;
e che in verità già da qualche anno, a partire dalle lotte sulla
salute, iniziavano ad aver ben chiaro il nodo del ‘quanto’
produrre – non era difficile vedere che il discorso della
economista di Cambridge parlava anche alle lotte sulla produzione.
Cosa c’entrava Keynes? Per portare a casa la sua critica alla
teoria neoclassica sul livello dell’occupazione, Keynes aveva
dovuto dimostrare che lo Stato può aumentare l’occupazione, che
gli investimenti (anche pubblici) inducono una spesa derivata di
consumi, e che questa seconda ondata è del tutto indipendente dalla
natura dell’impulso iniziale di spesa. Per questo scriveva che
scavare buche per poi riempirle andava altrettanto bene, dal punto di
vista del suo ‘modello’, di una spesa pubblica che producesse
valori d’uso per la società. Possiamo dar per scontato che lui
preferisse il secondo tipo di spesa, non è questo il punto. E’ il
medesimo Keynes che, preoccupato dalla disoccupazione di massa degli
anni Trenta, può scrivere nella prefazione alla traduzione tedesca
pubblicata in Germania nello stesso 1936 che un paese totalitario
come il nazismo costituisce uno sfondo istituzionale dove meglio che
nelle democrazie la sua teoria potrebbe essere messa all’opera.
Bene:
quando i ‘keynesiani’ diventano la nuova ortodossia, e il pieno
impiego assurge a obiettivo dichiarato e praticato dai governi
capitalistici dei trent’anni successivi alla guerra, tanto
conservatori quanto progressisti, si guardano bene dal cambiare la
domanda, e passare dalla questione del livello a quella del contenuto
dell’occupazione, come secondo Robinson sarebbe stato opportuno. La
Guerra, scrive, era stata una grandiosa lezione di ‘keynesismo’.
Se in astratto qualsiasi spesa andava bene, il ruolo trainante lo
ebbe però la spesa per armamenti, costruendo il complesso
militare-industriale, e guadagnandosi il consenso non solo di
capitalisti e lavoratori ma anche degli ‘economisti’ che la
consigliavano come profilassi contro la stagnazione e la
disoccupazione, infischiandosene della ‘finanza sana’. La spesa
in disavanzo favorita dai consiglieri keynesiani e la conseguente
centralità del sistema militare-industriale trasformarono il sogno
ad occhi aperti di Keynes in un incubo di terrore. Le nuove forme
della povertà in mezzo all’abbondanza e l’emergere drammatico
dell’inquinamento, nel mondo ‘keynesiano’ di allora (ricordate:
i ‘trenta gloriosi’, il compromesso capitale-lavoro, l’era
aurea del fordismo di cui ci racconta la sinistra; assieme
all’idolatria del PIL), ne furono l’esito necessario.
Hyman
P. Minsky
E’
qui che si inserisce a proposito la ripresa, tre anni dopo (1975),
del tema della ‘socializzazione degli investimenti’ nel primo e
negli ultimi due capitoli del primo libro di Minsky (John
Maynard Keynes,
tradotto in italiano con il titolo, per una volta più
perspicuo, Keynes
e l’instabilità del capitalismo:
ristampati entrambi, sull’onda del ritorno della grande crisi nel
capitalismo, sia negli Stati Uniti che in Italia, rispettivamente nel
2008 e nel 2009). E’ un libro che Minsky andava scrivendo dai primi
anni Settanta, in parte nella stessa Cambridge, dove ebbe senz’altro
modo di discuterne con Joan Robinson. Certo, basta leggere quelle
pagine per trovarsi gettati nello stesso ordine di idee della
Robinson, persino radicalizzato, mille volte lontano dalla timida
ripresa del keynesismo che predomina a sinistra.
Keynes
proponeva un controllo sociale sull’investimento e sognava una
società più egualitaria; e certamente questo messaggio è stato
imbastardito da quella Sintesi Neoclassica che aveva puntato sullo
stimolo all’investimento privato per conseguire alti profitti,
facendone discendere elevata occupazione e aumento del reddito anche
dei ceti più poveri grazie allo ‘sgocciolamento’ in basso
(trickle
down)
della maggiore ricchezza e del maggior reddito dei ceti abbienti.
Così la diseguaglianza (relativa) cresceva e il problema
dell’impoverimento non era affrontato per la via di una migliore
(oltre che più piena) occupazione ma per il tramite di sussidi
monetari e ‘assistenza’.
Il
problema, insiste Minsky, è che non solo le novità di Keynes erano
imprecise e confuse, ma che la stessa ‘vecchia’ teoria era in
buona misura ancora lì – e proprio nei punti chiavi della teoria
degli investimenti, del tasso di interesse, della determinazione dei
prezzi delle attività-capitale (assets).
In parte ciò era voluto, per rendere più accettabile il messaggio
ritenuto più urgente sulla politica economica anti-ciclica; in parte
era involontario, per l’incapacità di sfuggire al peso della
teoria tradizionale in cui era stato educato. I keynesiani hanno
finito con il cancellare lo stesso problema dinamico del ciclo
economico, da cui l’opera di Keynes nasceva, per ridurlo ad un
orizzonte statico di equilibrio. D’altra parte, tra i Quaranta e i
Sessanta, non era forse scomparso il problema del ciclo, sostituito
dalla regolazione fine del meccanismo economico? Lo sgonfiamento
prima, e la repressione poi (almeno per un po’, sino ai primi
Sessanta), della finanza speculativa, facilitavano l’illusione
ottica di una stabilità permanente. Se Kalecki, in anticipo di
trent’anni, ne aveva smontato le basi ingannevoli per quel che
riguardava i rapporti tra le classi sociali, Minsky, in anticipo di
almeno un decennio, faceva lo stesso per quel che riguardava il
rapporto tra finanza e investimento.
Qui
Minsky innestava la sua critica non solo al keynesismo ma allo stesso
Keynes. Non era vero quello che diceva la nuova ortodossia, che
bastavano cambiamenti al margine alle istituzioni del capitalismo per
garantire che crisi e depressioni fossero roba del passato. Al
contrario, era tutto da discutere se le politiche anti-congiunturali
potessero sostenersi nel tempo senza creare altre contraddizioni, ed
era fallace pensare di poter ricacciare sotto il tappeto le domande
del ‘per chi’ si dovesse produrre, di ‘che tipo’ di
occupazione dovesse essere stimolata, di quale natura dovesse avere
il pieno impiego. Il limite risaliva dritto dritto a Keynes, il
Keynes che aveva accantonato con troppa facilità le questioni
gemelle di una radical
reformulation,
di una ricostruzione radicale della società, e di un diverso insieme
di criteri per valutare l’evoluzione di quella stessa società.
Il
lettore vede subito che siamo di fronte a una messa in stato d’accusa
dell’ultimo capitolo della Teoria
generale. E
questo stato d’accusa viene da un economista che non si vergogna di
essere stato socialista (l’American
Socialist Party:
sua madre era attiva nel movimento sindacale, il padre nel partito
socialista di Chicago, e si incontrarono sul tram andando a una
celebrazione della nascitadi Marx). Anzi, che lo è ancora. Certo, un
socialismo rigorosamente antileninista, oltre che antistalinista.
Ciò, evidentemente, poteva fare problema. Pochi anni dopo, quando
Minsky iniziò a collaborare stabilmente al Centro Studi
Confindustria, diretto da Guido Carli (è grosso modo da quegli anni
che iniziò ad abitare a Bergamo, ed ebbi la fortuna di conoscerlo),
vi fu ancora chi, come Karl Brunner, si infuriò, con Paolo
Savona, per aver loro “portato in casa un comunista” (l’episodio
è riportato dallo stesso Savona in “Guido
Carli in Confindustria: maestro di pensiero e statista”, in Carli
G., Savona P., Guido
Carli Presidente di Confindustria 1976-1980,
Bollati Boringhieri, 2008). Non a Minsky stesso, almeno a
quell’epoca. E gli ultimi capitoli del suo libro del 1975
esplicitamente propongono uno tra i 57 tipi di capitalismo, dai
tratti però marcatamente ed esplicitamente socialisti (il
riferimento di Minsky alle 57 varietà possibili del capitalismo
rimandava alle 57 varietà pubblicizzate dalla ditta Heinz).
Seguiamo
il filo di ragionamento di Minsky. Keynes negli anni Venti era un
uomo della sinistra. Non più negli anni Trenta, e ciò sicuramente
era dovuto anche a quello che era la Russia comunista, centralizzata
e autoritaria. La Teoria
generale avrebbe
reso finalmente obsoleta e inutile la teoria marxiana, con tutte le
sue confusioni. Negli anni Venti, in fondo, Keynes flirtava ancora
con un socialismo decentralizzato e ‘umano’. Negli anni Trenta
ritiene che il mercato risolva in modo soddisfacente il problema di
una allocazione efficiente; che le politiche di pieno impiego che
suggerisce facciano un bel tratto di strada per risolvere il problema
della giustizia sociale, e che vadano solo affiancate dalla eutanasia
del rentier (politiche che riducano il tasso di interesse), da una
adeguata tassazione diretta, e da una incisiva imposta di
successione. Il capitalismo come regno della libertà e
dell’iniziativa individuale andava ‘salvato’.
Ovviamente, commenta Minsky, l’idea di Keynes che il capitale
potesse divenire ‘scarso’ era l’altra faccia della sua ingenua
teoria dei bisogni assoluti come ‘saziabili’ (una
generalizzazione indebita delle proprie preferenze), mentre al
contrario ciò che è avvenuto dopo è l’esplosione, indotta dal
sistema stesso, dei bisogni relativi. In ciò hanno svolto un ruolo
importante il modo del sostegno statale all’economia come domanda
di beni e servizi, il privilegio fiscale dei redditi da capitale
rispetto a quelli disponibili per il consumo, la politica di
trasferimenti meramente monetari, di cui è stato intessuto il
keynesismo. Il disciplinamento dei bisogni che con tutta evidenza
sarebbe opportuno non lo si può affidare, come crede Keynes, al
mercato, con solo un piccolo aiuto da parte del sistema della
tassazione e dei sussidi. Il vantaggio della spesa militare è che
distrugge continuamente il suo stesso prodotto, non rientra in
circolo (è una politica di investimento adeguata al capitale proprio
perché non è utile), e in più favorisce un sistema produttivo ad
alta intensità di capitale.
A
dover esser messa sul banco degli imputati, secondo Minsky, è la
contraddizione palese in Keynes tra l’idea della ‘socializzazione
degli investimenti’ e quella secondo cui il mercato svolgerebbe
bene il suo ruolo di allocatore delle risorse. Esisteva, ed esiste,
una alternativa: un ‘socialismo di mercato’ che controlli i
centri di comando (towering
heights)
e promuova il consumo collettivo (communal
consumption);
a cui potremmo aggiungere nello stesso spirito il controllo diretto
del movimento dei capitali. Ciò che i ‘keynesiani’ hanno
perseguito, non del tutto tradendo la lettera di Keynes, è stato
il Big
Government,
uno Stato grande a sufficienza da stabilizzare l’economia e
sussidiare il consumo. Un modello di alti profitti-alti investimenti,
ma dunque anche elevato ‘spreco’ (non siamo lontani, con tutta
evidenza dal mondo di Sweezy (con Baran), citato in JMK,
oltre che di Kalecki, anche se Minsky non aveva ancora recepito il
contributo di quest’ultimo, e non lo cita ancora). Un modello,
insomma, che è predicato proprio sulla esplosione dei bisogni
relativi, e che sostenendo rendite, interessi e profitti nutre nel
suo seno il risorgere della finanza speculativa e di una instabilità
sempre più accentuata. Un universo destinato ad una necessaria
implosione, e a cui non si può rispondere con la nostalgia di un
keynesismo ‘buono’ (che peraltro mai si è dato); e che intanto
destina il pianeta al degrado sociale e naturale.
E’ a questo che deve rispondere la ‘socializzazione degli
investimenti’, in un senso ben più profondo di quello
inevitabilmente aporetico di Keynes. Basta confrontare le frasi di
Minsky con quelle di Keynes: occorre, scrive l’economista di
Chicago, una economia in cui i settori chiave siano socializzati;
dove il consumo in comune [dunque non monetario, ma per così dire
provveduto ‘in natura’] soddisfi la parte maggiore dei bisogni
privati; dove la tassazione del reddito e della ricchezza sia
disegnata per abbattere la diseguaglianza; dove la speculazione nella
struttura delle passività sia regolata da leggi che ne definiscano
rigidamente l’ammissibilità. Un ‘capitalismo’ del genere può
rendere raggiungibile il pieno impiego con meno tensioni e
instabilità di quelli emersi nel capitalismo degli anni Sessanta e
Settanta.
Su
questa strada i fini socialisti, propri di un socialismo libertario,
possono essere riconciliati con il capitalismo. Ma per giungere a una
analisi adeguata di come funziona una economia capitalistica, e di
come intervenire lungo le linee di una teoria ad un tempo razionale e
radicale, è necessario comprendere non soltanto che il capitalismo
ha difetti costitutivi, non risolvibili per la via di una tiepida
regolamentazione, ma anche che si deve tornare ai problemi degli anni
Trenta. E qui, con tutta evidenza, Minsky ha in mente il New
Deal.
Quel New
Deal che
non era keynesiano: per certi versi, negativamente (Roosevelt, prima
della Seconda Guerra Mondiale, non apprezzava affatto i disavanzi nel
bilancio dello Stato); ma anche, per altri versi, positivamente
(Roosevelt, sulla spinta del conflitto sociale, aveva promosso una
spesa che aveva inciso potentemente sulla composizione della
produzione, e che dunque aveva coniugato sostegno alla domanda e
ridefinizione dell’offerta; e dove lo Stato si faceva occupatore
diretto di manodopera).
Da
questo punto di vista aveva di nuovo torto Keynes quando nella sua
lettera aperta a Roosevelt pubblicata nel New
York Times del
31 dicembre del 1933, se giustamente lo invitava a spingere
sull’acceleratore della recovery,
della ripresa, discutibilmente gli suggeriva una politica dei due
tempi, rimandando a tempi migliori la reform,
la riforma radicale dell’economia e della società. Il punto di
Minsky è evidentemente che le due gambe debbano camminare insieme.
Sul New
Deal,
e su quel Piano del Lavoro o sull’ispirazione liberalsocialista di
Ernesto Rossi o Sylos Labini, ho scritto a più riprese (da solo o
con Joseph Halevi) dal 2008, anzi in verità da prima. Un punto che
ritorna negli anni più recenti anche nelle riflessioni di Luciano
Gallino e Laura Pennacchi.
Federico
Caffè, Augusto
Graziani, e
Claudio Napoleoni
Criticando i keynesiani Paul M. Sweezy, a ragione sosteneva che
parlare di riformare il capitalismo significava peccare di ingenuità
o di doppiezza. Il capitalismo difenderà fino in fondo i suoi
privilegi, consentendo soltanto quelle riforme e quel margine di
libertà ai riformatori che non tocchino i loro interessi.
Federico
Caffè era sicuramente un riformista, pur a un certo punto disilluso
e disperato. Ma certo non ingenuo. Cita il Franco Fortini che
sul Corriere
della sera scrive
che “lo sviluppo capitalistico, grazie alle sue crisi e ai suoi
ritorni, drena sempre nuovi strati sociali, produce anzi sempre nuovi
colonizzati interni, almeno da noi, da usare come deterrente nei
confronti del lavoro comunque privilegiato”. La alternativa che
propone è una economia di piena occupazione, ma è chiaro –
aggiunge - che ciò dipende da una riforma fondamentale del contesto
istituzionale. Di questa riforma fanno parte controlli sul commercio
con l’estero, controlli sui prezzi, controlli sulla localizzazione
delle industrie, estensione dell’azione dello Stato anche ai fini
della regolamentazione complessiva dell’investimento privato.
Forse alludendo a Abba P. Lerner, la definisce una vera e propria
‘economia dei controlli’. Di più, si tratterebbe di una
autentica ‘amministrazione globale della offerta’. Siamo
chiaramente nello stesso orizzonte di Minsky, quello di una
socializzazione industriale e della struttura produttiva, della banca
e della finanza, dell’occupazione. Di fatto, e di nuovo, della
rimessa in questione del ‘che cosa’, ‘quanto’ e ‘per chi
produrre’ – qualcosa a cui una sinistra autentica non può non
aggiungere una rimessa in questione anche del ‘come’ produrre.
Caffè qualifica questa prospettiva come ‘riformismo
gradualistico’, ma non si vede (almeno, io non vedo) proprio cosa
vi sia di moderato in tutto ciò. Tant’è che lui stesso rimanda a
Gramsci che scrive che si tratta di proporre fini discreti,
raggiungibili pur nell’intento di approfondirli ed estenderli.
Se
cerchiamo da noi l’esempio massimo di un keynesismo ‘strutturale’,
mille miglia lontano dal keynesismo corrente e un po’ facile degli
economisti alternativi dei nostri giorni, l’autore a cui penserei
per primo è però Augusto Graziani: non a caso un autore che ha
costruito il suo pensiero più originale sulla critica al Keynes
della Teoria
generale,
e sul recupero semmai del Keynes del Trattato
sulla moneta. Per
quel Keynes - come per Wicksell, Schumpeter, e prima ancora Marx -
l’accesso privilegiato alla moneta è ‘comando’ sulle decisioni
attinenti alla produzione e alla occupazione. Quell’accesso è,
certo, prerogativa anche dei governi: ma Graziani non ha mai ceduto a
illusioni ‘sovraniste’; né gli si fa un gran servizio nel
ridurlo a un postkeynesiano, ad un ‘eterodosso’ tra i tanti,
fautore di politiche espansive della domanda effettiva, e magari di
una qualche svalutazione corretta ‘da sinistra’. Graziani ha
sempre ben chiara la natura di classe delle decisioni politiche; e ha
sempre rigorosamente distinto tra governo e Banca Centrale. Per lui,
il conflitto sociale – che si svolge fuori dall’arena del mercato
è di natura, in senso lato, politica: come per Kalecki, il
riferimento è non tanto alle lotte sul salario, piuttosto alle lotte
nella produzione, che può (e deve) imporre i contenuti della spesa
pubblica.
Graziani si è inoltre ben guardato dal farsi fautore di un aumento
generico della domanda. I fallimenti del sistema privato sono
profondi, e i bisogni collettivi sono insoddisfatti: proprio per
questo, sostiene, ogni spesa va accuratamente valutata e indirizzata
ad una composizione del prodotto che sia socialmente utile. Lo Stato
deve inoltre assicurare ai cittadini, per così dire ‘in natura’,
la disponibilità reale di beni e servizi, andando al di là di una
politica di meri sussidi monetari o di riduzioni fiscali. Per ultimo
ma non da ultimo, lo Stato ha la responsabilità di aprire la strada
ad un investimento che migliori la qualità strutturale dell’economia
in un orizzonte di lungo periodo che solo lui può garantire. Di
nuovo, siamo nell’orizzonte della ‘socializzazione degli
investimenti’ intesa in un senso complessivo e radicale.
E’
indubitabile che troppe siano le differenze tra Graziani e Claudio
Napoleoni per accomunarli in modo generico sotto un’unica
prospettiva. Pure, è altrettanto indiscutibile che esista una
convergenza, almeno sul problema. In un intervento al CESPE del 1987,
poi raccolto in un volumetto dal titolo: “Quali risposte alle
politiche neo-conservatrici?”, Napoleoni ribadisce l’importanza
di ripristinare il vincolo ‘interno’, cioè di una spinta sociale
sul terreno distributivo, che può incarnarsi in un aumento dei
salari ma anche in una riduzione dell’orario di lavoro.
L’economista abruzzese non è contrario ad una politica prudente
del cambio, che reputa (se accoppiata alla riproposizione del vincolo
‘interno’) in grado di ripristinare una dialettica di classe, e
di costringere le imprese a un cambiamento strutturale. Che ne è in
questa prospettiva del ‘risanamento’ del bilancio pubblico?
Sostiene questo Napoleoni che dell’intervento sul bilancio pubblico
se ne può fare una bandiera solo dentro un’operazione più
complessiva che non solo agisca sulla distribuzione del reddito ma
che intervenga anche sulle determinanti strutturali dell’economia e
della società. Una politica che riduca la dipendenza dall’estero,
che investa in grandi infrastrutture, che governi il mutamento
tecnologico in maniera da indirizzare l’aumento di produttività
verso un aumento della quota del nuovo valore che va al lavoro, di un
minor tempo di lavoro nella sfera della produzione, di una più
equilibrata ripartizione del lavoro di riproduzione, di un maggior
rispetto della natura. Cosa è questa se non ‘socializzazione degli
investimenti’?
Alain
Parguez
In questo orizzonte di discorso un contributo di rilevo è quello che
viene da Alain Parguez. Lo Stato deve farsi ‘ancora’ di uno
sviluppo che generi un pieno impiego autentico. Per definizione, il
passivo del bilancio dello Stato, qualora il conto corrente con
l’estero sia nullo, equivale ad un attivo del settore privato,
dunque a un suo risparmio netto. Inevitabilmente, politiche che
mirino ad un pareggio o un attivo del bilancio pubblico (le politiche
di ‘austerità’) non possono che rivelarsi controproducenti,
determinando l’opposto di quel che dichiarano. Deprimendo
produzione, occupazione, aspettative, fanno crollare investimenti e
consumi. A questo conducono le varie terapie shock, come quella
imposta alla Grecia, o le politiche recessive e deflazionistiche in
corso. E’ chiaro che i disavanzi dello Stato, invece di ridursi, si
riprodurranno e aumenteranno, in un circolo vizioso, che si riproduce
in una caduta libera pregna di drammi sociali e individuali. Sono,
questi, dei ‘cattivi’ disavanzi, a cui non corrisponde come
contropartita alcuna infrastruttura materiale o sociale. E’ questo
invece ciò che caratterizza i ‘buoni’ disavanzi.
I
‘buoni’ disavanzi sono infatti disavanzi voluti ex ante,
pianificati, che si collocano per così dire ‘naturalmente’ in
una politica di lungo termine. Essi hanno quale scopo dichiarato il
contrario di quel che afferma Keynes al termine della Teoria
generale.
Risultano nella produzione di uno stock di risorse tangibili e
intangibili, non solo infrastrutture concrete, ma anche investimenti
nella ricerca, nell’istruzione, nella salute. Di rimbalzo, possono
creare un clima favorevole migliorando le aspettative, e potrebbero
così favorire una spesa per investimenti privati, che rimane
comunque trainata dal big
push del
settore pubblico. Tale produzione di valori d’uso sociali va
effettuata in disavanzo ma, in realtà, al termine degli effetti che
ha indotto, finisce con l’autofinanziarsi – sempre, nelle
economie capitalistiche e dunque monetarie, il reddito segue alla
spesa, come il risparmio all’investimento, e ancora come le imposte
alla spesa pubblica.
Lucio
Magri
Potrà
sorprendere il prossimo autore preso in considerazione: Lucio Magri,
segretario del Partito di Unità Proletaria. Il documento è la
relazione su “Difesa rigida o offensiva manovrata?”, pubblicato
su il
manifesto quotidiano,
gennaio 1974. Magri si pone il problema di un ‘programma minimo’
di gestione della crisi. I temi che costituiscono l’asse del
discorso, e che qui cito per lo più direttamente senza virgolette,
sono quelli che seguono.
Il primo tema è la questione della distribuzione del reddito, o più
semplicemente del chi paga la fase di stagnazione e di riconversione
produttiva. Il livello di vita delle masse come quello
dell’occupazione, in una fase recessiva, non sono difendibili senza
un massiccio programma di spesa pubblica per finanziare consumi
collettivi, beni primari a basso costo, programmi di sostegno
dell’occupazione nei settori a bassa produttività e di
riconversione in altri settori. Qui il limite del discorso di Magri è
quello di dare per scontato che dalla considerazione, corretta, che
la crisi non era allora causata da insufficienza di domanda, si
potrebbe derivare una più generale critica al finanziamento in
disavanzo della spesa pubblica. Fa di conseguenza cadere l’intero
peso della manovra sull’aumento delle imposte. Discutibile allora,
senz’altro errato oggi. Come discutibile era una certa
sopravvalutazione della natura ‘finale’ della crisi, di cui
sottovalutava la natura di (lunga) crisi di ristrutturazione.
Il secondo tema era quello dei consumi collettivi. Che essi non
possano funzionare da elemento di rilancio del meccanismo
capitalistico non toglie nulla, per Magri, al fatto che una massiccia
spesa e una razionale pianificazione nel settore dei consumi sociali
potessero rappresentare un passo avanti decisivo per le condizioni di
vita delle masse e per il livello civile di tutta la società. Lo
spostamento di significative risorse da consumi individuali
inessenziali a consumi sociali poteva garantire sia una migliore
soddisfazione dei bisogni, anche senza sostanziali incrementi
produttivi, sia, almeno nel breve periodo, maggiori occasioni di
lavoro. Da una impostazione del genere Magri derivava scelte concrete
e una linea di classe. Sia per ciò che riguardava quali beni
collettivi produrre, sia per ciò che riguardava la loro
distribuzione. La linea di classe si riduceva a tre discriminanti.
Una impostazione accentuatamente egualitaria nella produzione e nella
distribuzione del bene collettivo. Una chiara autonomia del consumo
collettivo da un diretto obiettivo produttivistico (ritenuto il solo
modo di garantire una vera produttività). Una lotta a fondo contro
l’annidarsi del parassitismo nella spesa pubblica, contro la
borghesia di stato e la paralisi burocratica.
Per
quel che riguarda il problema dell’occupazione, pareva a Magri del
tutto illusoria – et
pour cause -
la prospettiva, sostenuta dai ‘riformisti’ di allora, di
risolvere il problema della occupazione intensificando gli
investimenti e rilanciando il meccanismo di sviluppo capitalistico.
Non era peraltro proponibile una pura e semplice lotta per la difesa
dei posti di lavoro esistenti. Si doveva riuscire ad aprire lotte per
nuovi posti di lavoro, per una politica dell’occupazione. La scelta
che andava fatta era di puntare (anche, ma in modo significativo) su
settori a bassa produttività, su tecnologie ad alto contenuto di
lavoro. Una politica che andava ancorata a priorità socialmente
riconosciute. A questo si poteva accoppiare una ondata di grossi
investimenti nella ricerca, e di stimoli economici in direzione di
una riconversione di settori industriali per l’esportazione di beni
e di tecniche verso paesi in via di sviluppo.
Aggiungeva Magri che pensare a questa serie di scelte di politica
economica come a un ‘programma di governo’, a un insieme di leggi
di riforma o di decisioni di spesa, frutto di un accordo di vertice,
sia pure sotto la pressione di una spinta di massa, sarebbe stato
puramente illusorio. Esse non potevano configurarsi se non come il
frutto di un permanente e articolato movimento di massa, capace di
funzionare in ogni momento e in ogni settore, oltre che come forza di
pressione, come controparte del potere pubblico in precise
‘vertenze’, come elemento di controllo permanente, e anche di
gestione attiva delle conquiste ottenute. Gestione diretta e di massa
di un programma di lotta che via via si impone e si controlla e il
cui procedere non risolve ma approfondisce la crisi del sistema
(siamo, a me sembra, ancora nell’orizzonte del Gramsci delle Tesi
di Lione, con una insospettabile convergenza con Federico Caffè).
Concludeva: non si tratta di imporre dal basso in modo diverso la
linea riformista, ma di portare avanti in modo differente dal
riformismo un programma che è intrinsecamente diverso, perché parte
dalla demistificazione dell’illusione del ‘nuovo modello
capitalistico’ (oggi diremmo: della ‘via alta’ allo sviluppo
capitalistico). Se non si riesce, nella articolazione degli obiettivi
e delle esperienze, a far avanzare il discorso sulla redistribuzione
del reddito, sui consumi sociali, sull’occupazione, come strumento
di lotta reale di massa, come crescita di potere prima e più che di
singoli obiettivi, ogni discriminante di impostazione e di contenuto
diventa formale. Non era un modello alternativo, stabile, di
capitalismo, ma di gestione della crisi.
Ho
scritto con le parole stesse di Magri, ma non ho potuto fargli
giustizia. Troppo – di condivisible, ma anche di non condivisibile
– ho dovuto tralasciare. Ma certo, in questo che Magri chiama
provocatoriamente ‘modello alternativo di stagnazione’,
condizione per poter porre un domani sul tappeto la questione di un
(comunista) ‘modello alternativo di sviluppo’, troppe sono le
somiglianze nei confronti di una radicale ‘socializzazione degli
investimenti’, per non chiedersi in che misura le due analisi
debbano reciprocamente essere confrontate, e interrogarsi
vicendevolmente.
Conclusioni
La gran parte degli autori che ho citato ha scritto quanto ho
riportato negli anni Settanta. Quale l’attualità in ciò che hanno
sostenuto allora? Enorme, a mio parere. La svolta neoliberista, se ha
spiazzato per lungo tempo le questioni che si ponevano in quel
decennio, non le ha affatto cancellate. Le ha viste semmai eclissarsi
per tornare allo scoperto con maggior forza ed evidenza, ma in un
contesto di rapporti di forza sociali ben più degradato.
Per mio conto, mi sono trovato a coordinare, per Rifondazione
Comunista e assieme a Emiliano Brancaccio (quello che scrivo impegna,
sia chiaro, soltanto me), una commissione sulla politica economica.
Eravamo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni
Duemila. La mia convinzione – potrei dire, da sempre: dall’inizio
degli anni Settanta – è che la crisi italiana non soltanto fosse
paradigmatica, pur nella sua eccezionalità, delle dinamiche del
capitalismo europeo e globale, ma anche che essa avesse una natura
‘strutturale’. Non era, come non è, riducibile alla questione
della diseguaglianza (i ‘bassi salari’). Né era, o è,
risolvibile con un più acceso (e benvenuto) conflittualismo, con una
(auspicata) migliore distribuzione: un po’ più di reddito qui, un
po’ meno di orario di lavoro lì.
Il mio tentativo nella commissione fu quello di organizzare
discussioni che portassero gli economisti italiani ‘di sinistra’
– una categoria purtroppo sempre più affetta dalla tara di
agognare una presenza mediatica la più pronunciata possibile (tra un
appello, una lettera, un monito, una comparsata in televisione); come
anche dal desiderio profondo di divenire consiglieri di un qualche
nuovo Principe - alla cognizione che il capitalismo che si era
costituito negli anni Ottanta e Novanta, non era per niente un
ritorno del ‘liberismo’, un trionfo di una generica
‘globalizzazione’, un misterioso e novissimo ‘postfordismo’,
né tanto meno la vittoria di un introvabile ‘pensiero unico’.
Insomma, le vuote sigle della sinistra alternativa e radicale. Era
invece un ‘nuovo’ capitalismo nel pieno di un intervento politico
attivo, che aveva trasformato e incluso i lavoratori dentro un
meccanismo infernale, che gestiva internamente la domanda effettiva,
e che dava vita a nuove forme del vecchio sfuttamento.
Da
studiare era il nuovo mondo della produzione e della finanza, prima
ancora di porre in questione domanda e distribuzione: perché
appunto reform e recovery vanno
insieme. Un capitalismo per cui era prevedibile l’avvicinarsi di
una grande crisi (tanto che sovrastimai la gravità della crisi
scoppiata nel 2000, e con Joseph Halevi mi trovai pronto a quella del
2007; gli economisti della nostra sinistra se ne accorsero, male, a
fine 2008). Con pazienza bisognava attrezzarsi sul piano
‘strutturale’ del modo di produzione: tanto per quel che
riguardava l’approfondimento della conoscenza, quanto per quel che
riguardava l’abbozzo di costruzione di un programma minimo.
Muovendosi verso una politica economica attenta, ebbene sì, alle
questioni legate alla ‘socializzazione degli investimenti’. Basta
andarsi a rileggere quello che scrivevo allora.
Se devo essere sincero, non ho mai capito bene quale e quanto fosse
l’investimento della dirigenza del Partito su quella
sotto-commissione. Non molto, sospetto. Ci veniva detto di rimanere
‘sulle generali’, perché erano ‘ovviamente’ i politici a
dover dettare la linea programmatica. E però quando le elezioni si
avvicinavano ci si chiedeva con urgenza di scrivere le righe da
mettere fianco a fianco agli altri mattoni approntati, separatamente,
dagli ‘ecologisti’, dalle ‘femministe’, e così via (io, devo
dire, mi sottrassi). Una cosa deve essere chiara. Una socializzazione
degli investimenti, per essere proposta da sinistra (figuriamoci da
partiti o movimenti comunisti), non si improvvisa. Richiede un
lavoro. Non individuale, ma collettivo. Di lunga lena, che si
costruisce nel tempo: basti pensare a che tipo di scuola e di
università presuppone.
Bisognerebbe cominciare, un giorno o l’altro, con pazienza, a
farlo, scontando i tempi della costruzione inevitabilmente lenta. Se
no sarebbe meglio, di queste cose, non parlarne nemmeno. Non è tema
né di articoli né di interventi ai convegni, se non si vuole essere
superficiali. Pure, potete contare sul fatto che la dura realtà dei
fatti (che hanno la testa dura, e non badano agli equilibri dei
politici o delle comunità intellettuali) ci costringerà a parlarne
sempre di più, seppur male, nei tempi a venire. Speriamo solo di
sfuggire alla massa di banalità, e di vere e proprie insensatezze,
che ci affligge sulla questione dell’euro, dove un tragitto simile
è stato già percorso, in modo probabilmente irreparabile, sino a
che non si sa veramente cosa dica la politica della sinistra (al
singolare).